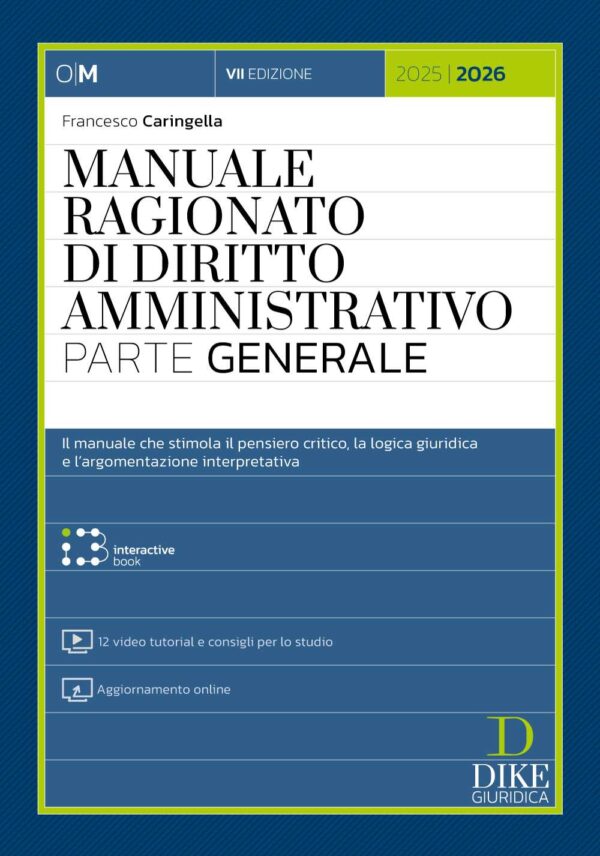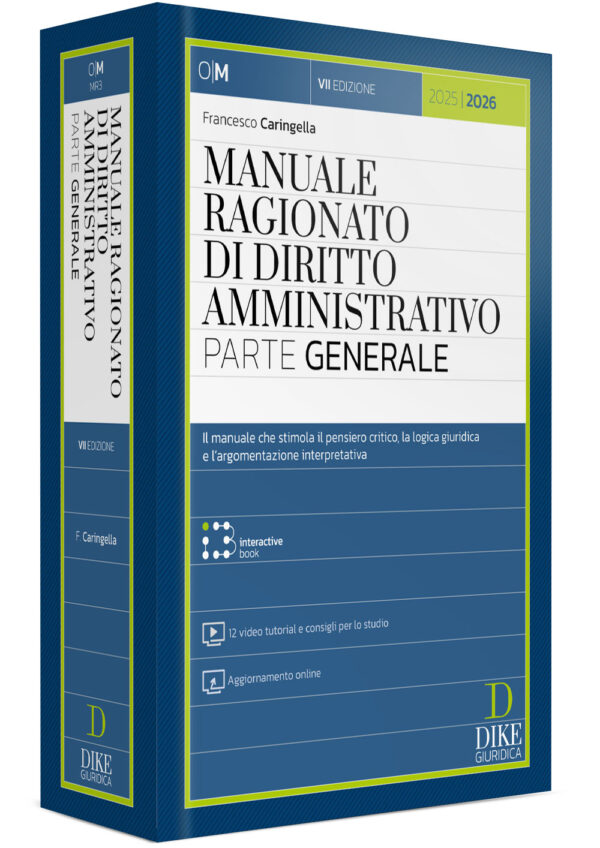La “proprietà pubblica” è un istituto anfibio, di difficile decifrazione, perché mescola ingredienti incompatibili.
Al pari di quanto accade nelle “società pubbliche” e nei “https://dikegiuridica.it/catalogo/italiappalti/manuale-dei-contratti-pubblici-ia1/contratti pubblici”, si mettono insieme una veste formale privatistica e un’essenza pubblicistica. Il risultato è un’ambiguità, se non un ossimoro. La complessità dell’istituto è tale che si è icasticamente parlato del mystère du domain (Klein, La police du domain public), a sottolineare il groviglio di dubbi e di questioni che aleggiano sullo stesso concetto di proprietà pubblica.
Affiora, soprattutto, una domanda: come si fa a conciliare un istituto di diritto privato, regolato dal diritto comune secondo una logica propriamente egoistica e utilitaristica, con la caratterizzazione pubblicistica dei soggetti e degli interessi perseguiti con l’uso di beni pubblici, per definizione volti in direzione di interessi collettivi e di valori solidaristici?
La proprietà pubblica è l’ennesima testimonianza, forse la più eclatante, della frantumazione dell’originaria unitarietà della proprietà privata.
Già Santi Romano, agli albori del Novecento, e, con più incisività, Salvatore Pugliatti, nel saggio del 1954, La proprietà nel nuovo diritto, ci hanno insegnato che non esiste la proprietà, esistono le proprietà.
Il regime del diritto dominicale e, con esso, il contenuto del diritto di proprietà non sono ontologicamente dati, ma conoscono profonde differenze a seconda della tipologia di beni che ne sono oggetto e del conseguente coacervo di facoltà, limiti e obblighi connessi alla titolarità del terribile diritto (Rodotà). Quindi, esistono tante proprietà quante sono le categorie omogenee di beni che richiedono una diversa conformazione dello statuto proprietario. La proprietà edilizia è diversa da quella agraria, così come la proprietà di un bene di interesse culturale è diversa da quelle relative a compendi di interesse storico, archeologico, ambientale.
La proprietà pubblica è l’incarnazione forse più pura del pluralismo della proprietà. La proprietà pubblica (ci si riferisce naturalmente ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili, non ai beni disponibili, integralmente sottoposti a regole privatistiche), non può non distinguersi dalle altre proprietà, dal momento che il fine pubblico, perseguito dalle pubbliche amministrazioni attraverso l’uso dei suoi beni, si riverbera, in modo fatale, sul regime giuridico, dando la stura a una regolamentazione significativamente diversa.
2. La proprietà pubblica: una storia di diversità
Il punto è proprio questo. La proprietà pubblica non può che essere diversa da quella privata. Ma quanto? È una diversità estrema, esasperata, antitetica, che si sostanzia in un istituto che ha poco a che spartire con il diritto di cui all’art. 832 c.c., o una diversità limitata, che si traduce in temperamenti e adattamenti a uno statuto che, nella sua essenza, resta quello scolpito del diritto comune? È un altro diritto, o un diritto con taluni profili di specialità?
Storicamente è prevalsa, pur se con graduazioni variabili, la prima impostazione, secondo cui si tratta di una proprietà morfologicamente diversa. Anzi, una non proprietà.
Pochi cenni vanno fatti all’epoca in cui la proprietà pubblica rivestiva carattere sacrale, perché riferibile al monarca assoluto.
Prima della Rivoluzione Francese, sinonimo dell’inizio della modernità, non esisteva la proprietà pubblica, ma la proprietà privata del sovrano, che piegava i beni della corona ai suoi capricciosi e imperscrutabili disegni egoistici e personali.
Nell’Ancien Régime il domaine de la Couronne era considerato un compendio unitario nelle mani individuali e divine del Re (Edit de Moulins, 1566).
2.1 Dalla proprietà-sovranità…
Nel 1789 le cose cambiano, in quanto nasce la proprietà dello Stato, entità diversa dalla persona fisica che lo regge. Una proprietà che persegue fini pubblici, non scopi personali.
Sotto il profilo giuridico, il passaggio della titolarità dei beni dalla proprietà del monarca allo Stato (o alla Nazione, secondo la tradizione francese) è stato così accompagnato dalla sottrazione dei medesimi al regime di diritto privato o comune.
Con la presa della Bastiglia, infatti, alcune categorie di beni già della Corona vengono esplicitamente poste al di fuori del commercio giuridico; per legge sono destinate alla realizzazione di interessi pubblici e sono sottratte alla piena disponibilità dello Stato e dell’amministrazione pubblica che pure ne divengono formalmente titolari.
Sul piano delle teorizzazioni, si elabora la teoria, recepita dal Code Napoléon, della proprietà pubblica come essenzialmente distinta da quella privata e, nella sostanza, coincidente con una manifestazione della stessa sovranità dello Stato.
Si sviluppa così, nella galassia dei beni pubblici, la distinzione tra un domaine public e un domaine privé: i primi sono veri e propri beni pubblici, caratterizzati da una affectation d’utilité publique, incompatibile con una gestione ispirata a una logica meramente patrimoniale; i secondi, cespiti privati d’appartenenza pubblica, sono una categoria residuale, che ricomprende tutti gli altri beni dei pubblici poteri.
In questa cornice ideologica – che iscrive tra i sostenitori più autorevoli nella prima metà dell’ottocento Proudhon, con il suo Traité du domanie public ou de la distinction des biens considérés principalment par rapporta au domaine public, Ducrocq, Berthélemy, Deguit e Jeze –, i poteri spettanti allo Stato e alle altre pubbliche amministrazioni sul domaine public sono qualcosa di profondamente diverso dalla proprietà, espressione di poteri di sovranità, di tutela, di conservazione, di amministrazione della cosa pubblica: un droit de garde et de surintendance a favore dell’interesse pubblico, inconcepibile nella disciplina della proprietà privata.
2.2 …alla proprietà diversa
L’idea della proprietà-sovranità – fortissima nella Francia del secondo impero e ancora presente in Italia nel codice civile del 1865, impregnato dal codice napoleonico del 1804 – tramonta nei primi anni del ’900, grazie al pensiero di Harrou in Francia e di Santi Romano in Italia.
Prende così piede, agli albori del secolo breve, l’idea della proprietà pubblica come vero e proprio diritto di proprietà sul domaine public. Si sviluppa, infatti, una ricostruzione che distingue la natura dal regime giuridico. Il regime giuridico è profondamente diverso dalla proprietà classica (si pensi all’inalienabilità, all’imprescrittibilità e all’inespropriabilità), ma la natura è quella della proprietà privata.
Emblematiche le parole di Santi Romano nei suoi ‘Principi del diritto amministrativo’: «la proprietà pubblica appare parallela alla proprietà privata, non come una modificazione di quest’ultima e tanto meno come un suo contrapposto; l’una e l’altra non son che modificazioni di una nozione comune, che si rende necessaria tutte le volte che si vuole designare un diritto che investe una cosa nella sua totalità».
L’idea della proprietà speciale affiora così nel codice civile del 1942 e, quindi, nell’art. 42, comma 1, Cost., secondo cui «la proprietà è pubblica o privata» e i beni appartengono allo Stato, ad enti e a privati. È plastica la doppia anima di tale dominium publicum: per un verso, le proprietà pubbliche sono specie di un genere più ampio che è la proprietà generalmente intesa; per altro aspetto, si stagliano significative differenze della property of public goods, sul piano delle caratteristiche strutturali, dei profili funzionali e dei regimi regolatori (v. anche Cap. 3, §2).
La considerazione della proprietà pubblica come un sottosistema peculiare della categoria giuridica “proprietà”, spezza, in sostanza, il nesso tra sovranità dello Stato sul territorio e il diritto di proprietà (si vedano sul punto le osservazioni illuminanti di S. Rodotà, Note su proprietà e sovranità, in Politica del diritto, 1993, pp. 172 e ss.), con la conseguenza che la proprietà pubblica nulla ha più a che vedere con il potere originario e assoluto dello Stato: essa si situa su un versante diverso, è espressione di una forma peculiare di proprietà imputabile allo Stato – persona giuridica, pienamente disponibile da parte del legislatore, se non da parte dell’amministrazione.
Guardando ancora una volta oltralpe, anche il codice francese del 2006 sui beni pubblici (ordonnance 21 avril 2006, il cui titolo emblematico è Code général de la propriété des personnes publiques), ha sposato con nettezza l’assunto della natura proprietaria dei diritti della pubblica amministrazione sui propri beni.
Resta forte però, come cennato, la profonda divaricazione concettuale tra l’elaborazione moderna del concetto di proprietà privata – nozione unitaria, che indica un fascio di situazioni giuridiche attive e che consente al titolare, cioè il singolo individuo, di godere e di disporre, in modo pieno, esclusivo e autonomo della res – e la disciplina della proprietà pubblica, caratterizzata dall’incommerciabilità, dalla non usucapibilità, dall’inespropriabilità (vedi anche art. 4 T.U. Espr. 327/2001), dall’impossibilità di sottrarre il bene alla sua destinazione pubblica e, quindi, dall’assenza del proprium del diritto dominicale, ossia il libero potere di disposizione da parte del titolare.
Sul tema, la normativa europea è neutrale, visto che, in base al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, le disposizioni unionali «lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».
[…]
*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto amministrativo – parte generale” di F. Caringella – Dike giuridica editrice – Ottobre 2025