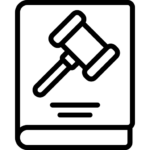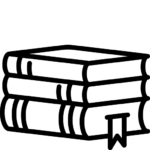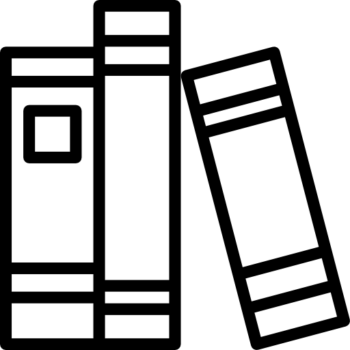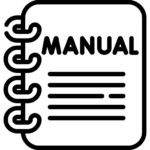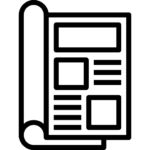La rescissione del contratto: squilibrio e rimedi in generale ed evoluzione storica
La rescissione ha origine nel diritto postclassico, sotto l’influenza della morale cristiana, come rimedio all’iniquità contrattuale.
La funzione dell’istituto nel diritto romano era simile, ma non identica, a quella che svolge attualmente: nasce per porre rimedio a negozi validi nella forma e nella sostanza e tuttavia viziati per altre ragioni. Lo strumento perseguiva due obiettivi: il primo, inerente alla conservazione dei patrimoni; il secondo, inerente alla conservazione del negozio che avesse modificato quei patrimoni. Il rimedio cui si puntava era quello della ricostituzione del patrimonio originario. La tipologia negoziale che offriva più spesso lo spunto per l’applicazione del rimedio era quella del trasferimento di un bene a titolo oneroso, l’odierna compravendita; oppure, in altri casi, si trattava del trasferimento di proprietà in godimento dietro il versamento di un corrispettivo, il pretium. Nella sua collocazione originaria, dunque, l’istituto preserva intatte le caratteristiche essenziali della disciplina attuale: la violazione di un equilibrio contrattuale; la necessità di ripristinare la situazione antecedente; la lesione dell’interesse patrimoniale di una delle parti coinvolte.
Per assistere alla prima vera e diffusa applicazione della rescissione si dovrà attendere la fine dell’alto medioevo e l’intero basso medioevo. In questo contesto l’applicazione che si faceva dell’istituto era molto varia. Anzitutto, erano legittimati attivamente un ampio numero di soggetti: appartenenti alla categoria ecclesiale e laici; di maggiore e di minore età; appartenenti alla nobiltà o semplici mercanti. Variavano, inoltre, le situazioni in cui l’istituto era applicato, passando dal diritto di famiglia, in particolare le successioni, al diritto negoziale vero e proprio. Tra i fatti sui quali si poggiava la domanda di rescissione, la caratteristica fondamentale era il fatto che la cosa valesse il doppio del corrispettivo pattuito e riscosso al tempo del contratto.
L’istituto della rescissione nel passaggio all’epoca moderna ha subito numerosi cambiamenti, assumendo le caratteristiche che ha nell’attuale impianto codicistico.
Giocò in tal senso un ruolo fondamentale la giurisprudenza, la quale, subendo in parte le influenze del Code Civil napoleonico, e, per altra parte, elaborando il proprio pensiero in autonomia, giunse a definire i caratteri peculiari dell’istituto. Dalla summa delle sentenze dell’epoca si ricava che la giurisprudenza aveva isolato due tratti caratteristici della rescissione, uno soggettivo e l’altro oggettivo: il tratto soggettivo era costituito dalla posizione della parte che, pressata dal bisogno, addivenisse a concludere patti svantaggiosi, pur in assenza di violenza o coercizione; il tratto oggettivo era, invece, costituito dal negozio posto in essere in condizioni di squilibrio tra le parti. Dunque, il vizio che rendeva rescindibile il contratto non era tanto un vizio di consenso, ma un difetto della causa del negozio, costituito dalla parziale mancanza di questo, e manifestantesi nella sproporzione tra valore della cosa e prezzo. Infatti, va aggiunto che, in detto contesto, il Codice civile del 1865, partendo proprio dall’idea dell’equivalenza soggettiva delle prestazioni, e disinteressandosi al tempo stesso delle situazioni che portavano i contraenti a concludere il contratto, a meno che non si traducessero in uno dei vizi del consenso espressamente previsti dalla legge, non colpiva il contratto lesivo o ingiusto, salvo il caso specifico della vendita di immobili a prezzo inferiore alla metà di quello di mercato, in cui il venditore era legittimato alla rescissione per il solo fatto oggettivo della sproporzione dei valori contenuti e senza riguardo alcuno alla ragione che lo aveva indotto a vendere. Non solo, poiché la valutazione comparata degli interessi confliggenti era di interesse pubblico, in quanto espressione di un valore che la legge considerava preminente, la disciplina era inderogabile: restava, pertanto, inefficace la rinuncia all’azione, sia che fosse contestuale, sia che fosse successiva rispetto al contratto. Un ultimo tratto è quello per cui la rescissione acquista il carattere della specialità, essendo applicabile solamente a specifiche e circostanziate ipotesi contrattuali.
Invero, nel XIX secolo, l’avvertita esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e il principio della signoria della volontà, in virtù del quale ogni determinazione relativa alla congruità dello scambio è rimessa alla libertà negoziale delle parti, hanno imposto un restringimento dell’ambito di applicazione dell’istituto. In particolare, il Code Napoleon, nel tentativo di conciliare quest’ultimo con le necessità della pratica commerciale e con i dogmi della concezione individualistica all’epoca dominante, ne limitò la portata, prevedendo la rescindibilità soltanto delle vendite immobiliari e della divisione.
Anche il Codice civile italiano del 1865 si indirizzò in tal senso, introducendo la rescissione per lesione ultra dimidium della vendita immobiliare (artt. 1529 ss.) e per lesione oltre il quarto della divisione (art. 1038, comma 2).
Il Codice civile del 1942 ha, invece, generalizzato l’operatività del rimedio, estendendola a tutti i contratti a prestazioni corrispettive, a eccezione dei contratti aleatori (art. 1448, comma 4) e della transazione (la quale, più precisamente, ai sensi dell’art. 1970 c.c. non è impugnabile per lesione). A ben vedere, però, ha posto, comunque, condizioni piuttosto restrittive all’esercizio dell’azione di rescissione, richiedendo, oltre allo squilibrio tra le prestazioni contrattuali, anche, come vedremo, la ricorrenza di determinate circostanze o condotte inerenti alla fase di formazione. Nel corso dei lavori preparatori erano emersi, in realtà, due orientamenti: uno restrittivo (in parte recepito, poi, dai compilatori del Codice vigente) teso a ridurre l’ambito di applicazione della rescissione per lesione alle sole ipotesi di lesioni ultra dimidium collegate a una situazione di indebolimento della volontà della parte danneggiata; e un altro orientamento (il quale riecheggiava l’art. 1133 del Codice civile per l’Eritrea e l’art. 22 del Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti del 1927) che attribuiva rilievo allo squilibrio in sé tra i vantaggi o tra le prestazioni ricavandone la presunzione di una non libera esplicazione della volontà negoziale.
Il legislatore del 1942 ha previsto due specifiche cause di rescissione del contratto: lo stato di pericolo (art. 1447 c.c.) e lo stato di bisogno (art. 1448 c.c.). Nella Relazione al Codice civile si legge che “si è denominata azione di rescissione quella con cui una delle parti reagisce contro l’iniquità e la sproporzione del vantaggio conseguito dall’altra per effetto di una condizione subiettiva anormale in cui si trovava la prima”, conformemente all’assunto per cui l’equilibrio tra le prestazioni delle parti o l’equità del vantaggio conseguito da una di esse costituisce l’ideale di una sana circolazione dei beni, rappresenta la giustificazione e il presupposto della tutela data dal diritto all’autonomia contrattuale, costituisce la condanna dello spirito egoistico penetrato nei rapporti in violazione del dovere di solidarietà. Al contempo, si evidenzia che “una norma generale che avesse autorizzato il riesame del contenuto del contratto per accertare l’equità o la proporzione delle prestazioni in esso dedotte, sarebbe stata, non soltanto esorbitante, ma anche pericolosa per la sicurezza delle contrattazioni; tanto più che avrebbe reso necessaria una valutazione obiettiva delle situazioni contrapposte, là dove spesso, nella determinazione dei vantaggi di ciascuna parte, operano imponderabili apprezzamenti soggettivi, non suscettibili di un controllo adeguato”. Proprio per tali ragioni, nella ricerca di una formula da utilizzare per i casi più gravi di squilibrio o di iniquità, si è fatto capo ai risultati che la dottrina aveva raggiunti a proposito dei contratti conclusi in stato di pericolo e in tema di contratti usurari e “si sono così ricavati gli estremi di figure giuridiche generali, a contorni compatibili con l’esigenza di non attenuare la forza obbligatoria dei contratti”.
La rescissione: natura giuridica
In dottrina ancora oggi si discute circa la natura giuridica del rimedio rescissorio.
Alcuni Autori dubitano che la rescissione sia una forma di invalidità del contratto, in quanto il contratto rescindibile ex artt. 1447 e 1448 c.c. non difetterebbe di alcun elemento strutturale e non sarebbe inficiato da alcun vizio (vedi anche Cap. 1, §6.2). Si propone, dunque, di ricostruire, in via interpretativa, un’autonoma categoria dogmatica, ovvero l’impugnabilità, nel cui ambito ricomprendere, oltre alla risoluzione e alla revocatoria (ordinaria e fallimentare), la rescissione medesima.
Tale orientamento si è sviluppato, muovendo dalla considerazione che la disciplina positiva della rescissione è, sotto alcuni aspetti, addirittura opposta a quella dell’annullabilità.
Innanzitutto, il contratto annullabile può essere convalidato (art. 1444 c.c.) dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento; al contrario, per espressa previsione normativa (art. 1451 c.c.), il contratto rescindibile non può essere convalidato.
Inoltre, la sentenza che accoglie la domanda di annullamento del contratto, per causa diversa dalla incapacità legale di una delle parti, non pregiudica i diritti acquistati sul bene a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (artt. 1445 e 2652, n. 6, c.c.). Ciò implica che la sentenza di annullamento travolge i diritti dei terzi almeno in tre casi: in presenza di acquisti a titolo gratuito; qualora risulti la mala fede del terzo al momento della conclusione del contratto di cui è parte; e, infine, laddove l’annullamento dipenda dalla minore età, interdizione o inabilitazione di uno dei contraenti. Viceversa, ai sensi dell’art. 1452 c.c., la sentenza di rescissione non pregiudica mai i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (art. 2652, n. 1, c.c.).
Anche la disciplina della prescrizione presenta divergenze. Mentre l’azione di annullamento è sottoposta a prescrizione quinquennale, l’azione di rescissione si prescrive in un anno decorrente dal momento della conclusione del contratto (art. 1449 c.c.). Inoltre, prescritta l’azione di rescissione, il contraente leso non può opporre in via di eccezione la rescindibilità del contratto per contrastare l’altrui richiesta di adempimento del contratto. Al contrario, l’eccezione di annullamento è imprescrittibile e può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.
I due rimedi contrattuali appaiono, dunque, assimilabili solo sotto alcuni profili processuali. Infatti, sia l’azione di annullamento sia l’azione di rescissione sono prescrittibili e possono essere esperite solo dal contraente nel cui interesse l’annullabilità o rescindibilità del contratto è prevista (c.d. “legittimazione ad agire relativa”).
La dottrina prevalente, tuttavia, sostiene che le innegabili differenze esistenti sul piano disciplinatorio tra annullabilità e rescindibilità non sono di rilevanza tale da giustificare un diverso inquadramento dogmatico dei due istituti. Ne consegue che annullabilità e rescindibilità sono entrambe forme di invalidità del contratto. A sostegno dell’assunto si invoca, innanzitutto, la collocazione sistematica delle norme in tema di rescissione, inserite, senza soluzione di continuità, dopo le disposizioni relative alla nullità e annullabilità del contratto. Si evidenzia, inoltre, che anche il contratto rescindibile è inficiato da un vizio genetico, ovvero coevo e non sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del medesimo. In particolare, l’elemento viziato è la volontà di uno dei contraenti, posto che stato di bisogno e stato di pericolo inquinano, seppur in modo diverso rispetto ai vizi del consenso, il procedimento di formazione del contratto. Colui che stipula un contratto trovandosi in una delle situazioni descritte dagli artt. 1447 e 1448 c.c. non è, infatti, libero di valutare la convenienza della stipulazione contrattuale.
È, però, necessaria una precisazione. Mentre il contraente il cui consenso è dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, perviene alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, colui che versa in stato di bisogno o di pericolo vuole stipulare il contratto, ma è indotto per la pressione psicologica cui è soggetto da tali circostanze, estranee alla volontà intimidatrice dell’altro contraente, ad accettare un programma prestazionale iniquo per sé e vantaggioso per la controparte.
Nella prospettiva maggioritaria, la rescindibilità è un vizio genetico del contratto, ma diverge dall’annullabilità sotto il profilo del fondamento giuridico.
Gli artt. 1447 ss. c.c. non sono, infatti, diretti a tutelare la volontà del soggetto, ma ad accordargli uno strumento processuale contro le iniquità contrattuali accettate in stato di pericolo o di bisogno. In altri termini, in presenza di un vizio del consenso il contratto è annullabile a prescindere dalla congruità o meno del regolamento di interessi in esso delineato; viceversa, colui che stipula un contratto in stato di pericolo o di bisogno è legittimato a chiederne la rescissione solo laddove il contratto risulti contenutisticamente squilibrato. L’azione di rescissione è, dunque, uno dei primi rimedi predisposti dal nostro ordinamento giuridico per consentire il sindacato giudiziale sul contratto proceduralmente iniquo, ovvero iniquo per effetto di anomalie, connesse alla posizione di debolezza di una delle parti, che ne abbiano inficiato il procedimento di formazione.
In tale ottica, appare più agevole comprendere la ratio del divieto di convalida espressamente sancito dall’art. 1451 c.c. Posto, infatti, che il contraente leso generalmente persiste in una condizione di vulnerabilità nel breve periodo di tempo concessogli per l’esercizio dell’azione di rescissione, probabilmente il legislatore ha inteso prevenire eventuali condotte abusive, tese a ottenere una stabilizzazione di programmi contrattuali squilibrati.
In disparte la questione della natura giuridica, l’inquadramento concettuale e sistematico dell’istituto della rescissione richiede una premessa di carattere generale: la normale insindacabilità negli atti negoziali dell’equilibrio economico tra le attribuzioni patrimoniali, in conformità con la tutela del libero mercato e della libertà di autonomia privata. La rescissione si apprezza, pertanto, come eccezionale impugnativa del contratto congegnata per ovviare a uno squilibrio genetico del sinallagma, indotto dal contesto circostanziale in cui avviene la formazione del contratto.
Infatti, per effetto di specifiche circostanze esterne (lo stato di pericolo e quello di bisogno), la determinazione volitiva della parte lesa non è libera, ma indotta ad accettare delle condizioni inique. Si parla in dottrina di volontà obnubilata da fatti esterni che esita in uno squilibrio tra prestazioni, classificabile come difetto genetico della causa (Amadio-Macario). Lo stato soggettivo di costrizione non è indotto dalla controparte, la quale, piuttosto, ne approfitta, allo scopo di lucrare un vantaggio sproporzionato. Da qui una disciplina che, se prossima a quella della annullabilità, per molti aspetti se ne distacca.
Invero, come l’annullabilità, il contratto rescindibile è efficace sin quando non interviene una sentenza che ne caduca retroattivamente gli effetti: allo stesso modo, la rescissione è un rimedio che postula la domanda della parte lesa. Ma, a differenza dell’annullabilità, il contratto rescindibile non è convalidabile, la relativa azione si prescrive in un anno (e non in cinque), per di più con un differente momento di decorrenza (art. 1442, comma 2, c.c.) e la relativa eccezione non è imprescrittibile; ancora, la tendenziale inopponibilità ai terzi rende difficile il suo inquadramento nell’area dell’invalidità.
Secondo la dottrina prevalente, tramite la rescissione, l’ordinamento intende soccorrere la determinazione negoziale di quella parte che, impedita da fatti esterni a contrarre responsabilmente, non è addivenuta alla pattuizione di un giusto prezzo di mercato.
Così intesa, la disciplina si pone come garanzia di una contrattazione secondo logiche di mercato, e cioè non come quarto vizio della volontà ma quale strumento per neutralizzare forme di abusi nel procedimento formativo del contratto, ostative al corretto svolgersi dell’autonomia contrattuale.
A tal proposito, va ricordato che lo squilibrio economico tra le prestazioni non è rilevante, di regola, nel momento della formazione del contratto, vigendo, in questa fase, il principio generale dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), per cui le parti sono libere di concordare le condizioni economiche del contratto senza che lo scambio risponda a requisiti oggettivi di equivalenza delle prestazioni. In conseguenza di ciò, l’ordinamento non prevede, almeno di regola, un rimedio che consenta al giudice di valutare la congruità originaria dello scambio contrattuale. Tuttavia, al generale principio di intangibilità dell’autonomia negoziale fanno eccezione le due ipotesi di rescissione del contratto (artt. 1447 ss. c.c.).
La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
La prima ipotesi di rescissione del contratto è prevista dall’art. 1447 c.c., che accorda il rimedio alla parte che abbia assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota all’altro contraente, di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Dunque, la rescissione del contratto è subordinata al ricorrere di tre requisiti: lo stato di pericolo, lo squilibrio contrattuale in danno della parte in pericolo, la mala fede della controparte.
Quanto al pericolo, la norma in esame lo descrive definendolo in relazione a uno “stato di necessità” (così richiamando la terminologia usata in altre parti dell’ordinamento: art. 2045 c.c.; art. 54 c.p.), che deve essere causalmente connesso al contratto: nel senso che il soggetto in stato di pericolo si serve del contratto al solo scopo di neutralizzare il pericolo. In particolare, la norma richiede che ricorra la necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale (quindi non futuro) di un danno grave alla persona; non sarebbe, invece, sufficiente un pericolo riguardante esclusivamente cose. Il danno al patrimonio potrà semmai rilevare, ove ne ricorrano tutti i presupposti, alla stregua dello “stato di bisogno” (art. 1448 c.c.). Peraltro, il contratto è rescindibile anche qualora il pericolo sia stato determinato volontariamente dalla stessa vittima o qualora fosse evitabile: in ciò lo stato di pericolo si distingue dallo stato di bisogno sopra richiamato. Inoltre, il danno deve essere grave e tradursi in un pregiudizio tale che la necessità di evitarlo funga da motivo determinante del consenso. Con riferimento al concetto di “danno grave alla persona”, di cui testualmente all’art. 1447 c.c., ci si è chiesti in dottrina se esso debba riguardare il bene vita o possa interessare anche qualsiasi altro diritto della personalità. Sul punto si è fatto strada un orientamento (Roppo) che tende a espandere le maglie del rimedio in questione riferendolo a tutte le ipotesi in cui sia in pericolo un bene presidiato dall’ormai variegata gamma dei diritti della personalità.
Quanto alle condizioni inique, si allude a uno squilibrio tra le prestazioni che il legislatore, diversamente da quanto prescritto nel caso di rescissione per lesione, rimette alla valutazione discrezionale del giudice.
Quanto alla malafede della controparte, la terminologia usata nella norma (in cui si fa ricorso al termine “noto”, invece che “riconoscibile”) induce a ritenere che debba ricorrere la conoscenza effettiva dello stato di necessità.
La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno
La seconda ipotesi di rescissione riguarda il contratto stipulato a condizioni gravemente inique, in dipendenza dello stato di bisogno di una parte, bisogno di cui la controparte ha approfittato per trarne vantaggio. L’art. 1448 c.c. individua, quali presupposti dell’azione di rescissione, lo stato di bisogno di una parte e l’approfittamento dell’altra; specifica, inoltre, che l’azione è ammissibile solo ove il valore della prestazione eseguita o promessa superi il doppio dell’altra (c.d. lesione ultra dimidium).
Lo stato di bisogno è identificabile con la contingente difficoltà economica della parte vittima dell’abuso e deve porsi come causa efficiente della determinazione volitiva a contrarre, nel senso che il bisogno deve rappresentare la ragione determinante l’accettazione di condizioni economicamente sperequate. Rileva altresì il motivo del bisogno, che deve essere serio e non futile. Secondo la giurisprudenza prevalente, la nozione di stato di bisogno è molto ampia. L’ipotesi sintomatica è l’impellente necessità di denaro, ma non occorre l’indigenza o la povertà: a integrarlo basta, dunque, una condizione anche transeunte di difficoltà economica (Minervini). Inoltre, il bisogno può essere stato procurato dalla stessa vittima.
Affinché sia esperibile l’azione è, poi, necessario che ricorra una lesione, inderogabilmente quantificata dalla legge in una sproporzione di oltre la metà (ultra dimidium) tra le rispettive prestazioni. Il parametro di riferimento è il valore di mercato delle prestazioni riferito al momento della stipula del contratto, non rilevando la sproporzione prodottasi per effetto di successive oscillazioni di mercato nel corso dell’esecuzione. Inoltre, è necessario che la lesione permanga sino al momento della proposizione della domanda, donde l’escludersi della rescissione se il valore reale della prestazione che la vittima dell’abuso ha ricevuto è aumentato ovvero se è diminuito quello della prestazione che la stessa ha eseguito.
L’ultimo requisito è l’approfittamento, che, secondo l’impostazione più recente, non postula un’attività operosa mirata proprio a indurre la parte lesa a concludere l’affare. L’approfittamento si sostanzia nella spinta psicologica a lucrare un vantaggio ingiusto e ricorre ogniqualvolta si abbia conoscenza dello stato di bisogno della controparte.
Rescissione e usura
La condotta tenuta da colui che, approfittando dell’altrui stato di bisogno, perviene alla stipula di un contratto rescindibile per lesione ex art. 1448 c.c. può integrare gli estremi del reato di usura.
I rapporti tra usura e rescissione per lesione sono da sempre oggetto di dibattito dottrinale.
Fino al 1996, parte della dottrina riteneva che nel nostro ordinamento giuridico fossero compresenti due diverse concezioni di usura: l’una civilistica e l’altra penalistica.
In particolare, ai sensi dell’art. 644 c.p. (testo originario), commetteva il reato di usura chiunque, “approfittando dello stato di bisogno di una persona”, si faceva dare da questa o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari. L’unico esplicito riferimento all’usura nell’ambito del Codice civile era, invece, contenuto in una norma di diverso tenore, ovvero l’art. 1815 c.c., che sanciva la nullità della pattuizione usuraria inserita in un contratto di mutuo, prevedendo la riduzione nella misura legale degli interessi dovuti.
In tale contesto si era giunti a ritenere che le due norme avessero un diverso ambito di applicazione. In particolare, si riteneva che la clausola con cui si convenivano interessi usurari fosse nulla ex se in virtù del disposto dell’art. 1815 c.c., a prescindere dall’accertamento della responsabilità in sede penale e, dunque, anche in mancanza di una condotta integrante un approfittamento dell’altrui stato di bisogno.
La stessa Relazione al Codice civile evidenzia una vicinanza tra la condotta descritta nell’art. 644 c.p. e i presupposti richiesti dall’art. 1448 c.c.
Tale impostazione è stata definitivamente superata dopo l’entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, che ha sostanzialmente riscritto l’art. 644 c.p. La norma va letta in combinato disposto con l’art. 2 della L. 108/1996 che attribuisce al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti in appositi elenchi e, al comma 4, fissa la soglia della usurarietà degli interessi nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, aumentato della metà.
Alla luce di tali innovazioni legislative che hanno determinato un’oggettivazione dell’usura penale, la dottrina prevalente ritiene che l’usurarietà sia divenuta un concetto unitario, abbandonando conseguentemente la tradizionale distinzione tra l’usura civile rilevante ai sensi dell’art. 1815 c.c. e quella penale che trova fondamento nell’art. 644 c.p. In tal modo, peraltro, il mutamento del quadro normativo ha inciso sull’ambito applicativo del rimedio rappresentato dalla rescissione per lesione, il quale ha perso la centralità acquisita sotto il vigore del testo originario dell’art. 644 c.p.
L’art. 1815 c.c. costituisce, infatti, oggi, il rimedio civilistico all’usura pecuniaria a interessi. L’attuale versione del medesimo sancisce la nullità della pattuizione usuraria e la conversione del contratto di mutuo in cui essa è inserita da oneroso a gratuito. Mentre, fino a un recente passato l’ambito di applicazione della norma era, però, esteso ai contratti di finanziamento in genere, ora si tende a circoscriverlo ai contratti di mutuo. L’azione di rescissione per lesione è, viceversa, esperibile laddove non operi l’art. 1815 c.c., e dunque a fronte di un’usura pecuniaria non a interessi (arg. ex art. 644, comma 3, c.p.), oppure di un’usura reale. Riguardo ai contratti usurari cui non è applicabile l’art. 1815 c.c., rimane peraltro aperta la questione di quale sia il rimedio civilistico esperibile, laddove, pur essendo integrati gli estremi del reato di usura, non ricorrano i presupposti per esercitare l’azione di rescissione, per esempio perché la lesione è infra dimidium e/o non vi è stato approfittamento dello stato di bisogno.
Più in particolare, può dirsi che la riscrittura del reato di usura ha ridimensionato l’ambito di applicazione della rescissione. Per effetto della L. 108/96, si hanno tre forme di usura:
a) pecuniaria in astratto: prescinde da qualsiasi rimando alla condizione del soggetto leso, configurabile automaticamente nel caso gli interessi convenuti oltrepassino il tasso soglia determinato ex lege;
b) pecuniaria in concreto: gli interessi pattuiti, pur se contenuti entro i limiti di legge, sono sproporzionati e la vittima si trova in una condizione di difficoltà economica o finanziaria;
c) reale: configurabile quando i vantaggi, diversi dagli interessi, siano sproporzionati e risulti che il contraente leso versava in uno stato di difficoltà economica o finanziaria all’atto di effettuarli o di prometterli.
Per il contratto di mutuo, è prevista una specifica disciplina dall’art. 1815, comma 2, c.c., in forza della quale la relativa clausola è nulla e – in luogo della sostituzione con il tasso legale – non sono più dovuti interessi.
Ora, visto che è usurario (sub b) e sub c)) qualsiasi contratto sinallagmatico ove, in corrispettivo di una somma di denaro o di un’altra utilità, è convenuta una prestazione sproporzionata, il risultato è il dilatarsi delle fattispecie contrattuali integranti il reato di usura. Fattispecie che dovrebbero chiamare in causa il rimedio della nullità, per illiceità della causa o contrarietà con norme imperative; ma, a ragionar così, siccome è usurario l’interesse o il vantaggio sì sproporzionato però infra dimidium, pur non applicandosi l’azione generale di rescissione, il contratto sarebbe nullo, mentre per il contratto usurario con lesione ultra dimidium, sebbene fattispecie più grave, dovrebbe paradossalmente applicarsi il rimedio della rescissione.
Sul tema dell’usura vedi, più ampliamente, Parte II, Cap. 3, §10.6 e ss.
Il regime dell’azione
La rescissione può essere fatta valere, in via di domanda o di eccezione, da chi abbia stipulato in stato di pericolo o di bisogno; non è rilevabile d’ufficio; l’azione si prescrive in un anno dalla stipula del contratto (art. 1449 c.c.).
La sentenza che dispone la rescissione è costitutiva e cancella ex tunc gli effetti del contratto, sicché, ove si tratti di obbligazioni di dare, il regime delle restituzioni sarà quello dell’indebito (art. 2041 c.c.).
Si tratta di una retroattività obbligatoria, che dispiega i suoi effetti solo tra le parti: infatti, con riguardo ai terzi, sia di buona sia di mala fede, la rescissione non pregiudica i diritti che costoro abbiano acquistato, anche a titolo gratuito, medio tempore, salvi gli effetti della trascrizione. Sicché la rescissione è opponibile al terzo nel caso in cui costui abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione della domanda di rescissione (artt. 1452 e 2652, n. 1, e 2690).
Ai sensi dell’art. 1451 c.c., il contratto rescindibile, diversamente da quello annullabile, non può essere convalidato. Ciò in quanto la ratio della rescissione si rinviene non tanto nella tutela di un’integrità della volizione contrattuale, quanto nell’ottica di garantire l’equilibrio dello scambio. Sebbene sia vero che il mancato esercizio dell’azione per un anno sia prossimo a una convalida per omissione (art. 1444 c.c.), nel divieto di convalida è inclusa ogni forma di rinuncia all’azione.
Offerta di modificazione del contratto
L’art. 1450 c.c., in applicazione del principio di conservazione del contratto, prevede che la rescissione possa essere evitata se il contraente contro il quale è domandata offre di modificare il contratto in modo sufficiente da ricondurlo a equità. La natura giuridica di questa facoltà è quella del diritto potestativo (Amadio-Macario). La legittimazione a offrire la riconduzione a equità è del solo contraente autore dell’abuso: per il principio di immodificabilità unilaterale del contratto, alla parte lesa non è, infatti, consentito imporre la riduzione.
L’offerta deve essere adeguata, nel senso di idonea a ristabilire l’equilibrio sinallagmatico. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che deve trattarsi altresì di un’offerta puntuale, ovvero con un grado minimo di specificità, dovendosi indicare quali sono le clausole da modificare ed entro quali limiti. Non è ammessa, quindi, un’offerta generica, dovendo il giudice solo accertare se l’offerta sia o meno idonea a riequilibrare il sinallagma. Nel compiere questo accertamento rileva il valore venale oggettivo delle prestazioni al momento della pronuncia, di talché non c’è un vero e proprio giudizio di equità, tantomeno può parlarsi di equità con funzione integrativa.
Si tratta di una norma analoga a quella degli artt. 1467 e 1468 c.c. in tema di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità (vedi Sez. IV, Cap. 7, §3.1.2). È evidente la ratio della norma: se la parte lesa rifiuta l’offerta di riduzione a equità, nonostante questa sia effettivamente idonea a ripristinare l’equilibrio, il giudice, in conformità col principio di conservazione del contratto, ha comunque il potere di conformare il contratto, di evitare la rescissione e di mantenere la stipulazione contrattuale.
Con riguardo alla natura giuridica dell’offerta di riduzione a equità, non è pacifico se si tratti di un istituto sostanziale, equiparabile a una vera e propria proposta, revocabile fino alla sua accettazione; se, invece, ci si trovi in presenza di un negozio giuridico unilaterale recettizio ex art. 1334 e 1335 c.c.; ovvero se sia qualificabile come istituto processuale, come una contro-domanda o domanda riconvenzionale; o, ancora, se abbia natura sostanziale o processuale a seconda che la parte rivolga la sua domanda alla parte o al giudice e, soprattutto, a seconda che la proposta venga effettuata extra giudizialmente o all’interno del giudizio.
Rispetto all’ampiezza del potere officioso a fronte dell’offerta di riduzione all’equità, può rilevarsi che il giudice abbia unicamente il potere di valutare l’idoneità dell’offerta ai fini della reductio ad aequitatem e il potere di modificarla se questa sia inadeguata.
Nell’ipotesi in cui il giudice si limiti ad accertare, sul piano dell’an, se l’offerta è stata idonea a ridurre a equità, egli pronuncerà una sentenza dichiarativa, perché la riduzione a equità è provocata dall’atto di parte; al contrario, se si ammette il potere del giudice di valutare proposte alternative rispetto a quella reputata inidonea alla realizzazione del fine dell’equità e il conseguente potere di integrare la proposta con le opportune modifiche, allora la pronuncia giudiziale avrà carattere costitutivo.
*Contributo estratto dal Manuale ragionato di diritto civile di Francesco Caringella – Dike Giuridica 2023