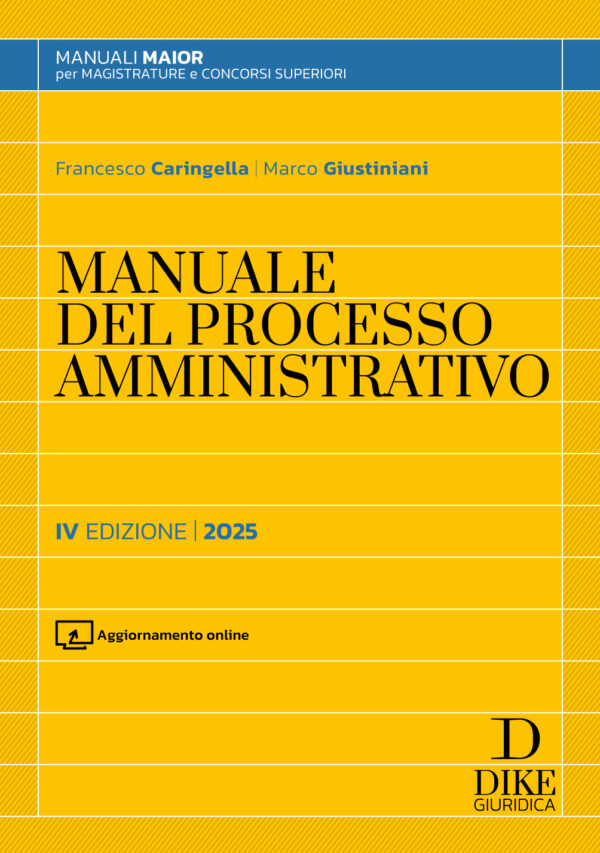Tipologia degli atti impugnabili dinanzi al Giudice amministrativo. Esaminati in linea generale i presupposti processuali e le condizioni dell’azione dinanzi al Giudice amministrativo, occorre ora soffermarsi in particolare sull’azione caducatoria esperibile in sede di giurisdizione generale di legittimità ai sensi dell’art. 29 c.p.a., individuando i caratteri dell’atto impugnabile e le molteplici categorie enucleate nell’esperienza giurisprudenziale.
Il tema assume rilievo anche per le ipotesi di giurisdizione esclusiva, ove sia dedotta una situazione soggettiva di interesse legittimo, dovendosi in tal caso osservare i principi (e i termini decadenziali) del giudizio impugnatorio.
L’indagine deve essere condotta alla luce del parametro costituzionale di cui all’art. 113 Cost. – secondo cui “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi” (comma 1), che “non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti” (comma 2) – onde devono privilegiarsi le soluzioni interpretative atte ad ampliare le possibilità di impugnazione, così garantendo la pienezza ed effettività della tutela.
L’esegesi deve peraltro muoversi, al contempo, nel rispetto dei limiti derivanti dal carattere di giurisdizione soggettiva proprio del processo amministrativo, e quindi verificare con rigore la sussistenza delle condizioni della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.
Secondo le definizioni correnti, l’atto amministrativo si individua nella compresenza di due requisiti, di ordine soggettivo l’uno ed oggettivo l’altro.
Tipologia degli atti impugnabili dinanzi al Giudice amministrativo. Sotto il profilo soggettivo, l’atto deve promanare da una Pubblica Amministrazione. Nella logica delle “geometrie variabili”, secondo cui la definizione di Pubblica Amministrazione non è assoluta ed univoca, ma relativa e funzionale agli obiettivi di volta in volta perseguiti dal legislatore, l’esigenza di assicurare al massimo grado una tutela effettiva impone di fare riferimento ad una nozione ampia e tendenzialmente omnicomprensiva, qual è quella contenuta nell’art. 7, comma 2, c.p.a. (“per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”).
Quanto al profilo oggettivo, l’atto deve essere adottato nell’esercizio della funzione amministrativa. Solo gli atti autoritativi sono dunque suscettibili di impugnazione, e non anche gli atti paritetici, o iure privatorum, o negoziali[1].
Come rilevato trattando della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, l’atto deve essere altresì idoneo a produrre la lesione attuale di una situazione soggettiva di interesse legittimo.
Ne deriva, in primo luogo, che – salve talune eccezioni, di cui si darà conto in prosieguo – è impugnabile soltanto l’atto conclusivo del procedimento amministrativo (provvedimento) e non anche gli atti intermedi (c.d. “endoprocedimentali”).
Ne discende, inoltre, che deve trattarsi di atto efficace. Non sono dunque impugnabili con l’azione costitutiva ex art. 29 c.p.a. gli atti nulli, in quanto improduttivi di effetti.
Ai sensi del successivo art. 31, comma 4, la nullità è sempre rilevabile d’ufficio dal Giudice amministrativo e può essere fatta valere attraverso una specifica azione dichiarativa, assoggettata al termine decadenziale di centottanta giorni.
Tipologia degli atti impugnabili dinanzi al Giudice amministrativo. Non è invece necessario che l’atto sia altresì “definitivo”, ovvero che avverso lo stesso risultino esauriti o non siano proponibili i rimedi amministrativi, come prescriveva l’art. 34 R.D. 1054/1924, avendo la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, reso facoltativo il previo esperimento dei suddetti rimedi.
Si deve rilevare come non risulti sempre agevole, nella molteplicità delle fattispecie concrete, rinvenire i connotati dell’atto impugnabile, dovendosi caso per caso coniugare il principio di effettività della tutela con il rispetto dei termini decadenziali che improntano l’azione caducatoria.
Di seguito saranno esaminate le figure più consolidate nell’elaborazione giurisprudenziale.
2.1 Atti politici e atti di alta amministrazione
Tuttora controversa e dagli incerti confini è la categoria dei c.d. “atti politici”.
Si tratta degli “atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”, sottratti al controllo giurisdizionale dall’art. 7, comma 1, c.p.a. (che riproduce testualmente il previgente art. 31 R.D. 1054/1924).
Tipologia degli atti impugnabili dinanzi al Giudice amministrativo. Tradizionalmente, i requisiti dell’atto politico sono individuati nella provenienza dal Governo (requisito soggettivo) e nella riconducibilità alle supreme scelte di indirizzo politico dell’ordinamento (requisito oggettivo). Solo soggettivamente e formalmente, dunque, detto atto si caratterizza quale atto amministrativo, costituendo invece, nella sostanza, espressione della discrezionalità politica (si pensi, ad esempio, alle decisioni assunte in materia di relazioni internazionali), ex se inidonea ad incidere sulla sfera giuridica dei singoli e, quindi, a radicare pretese azionabili.
Secondo un più recente orientamento giurisprudenziale, ai fini della valutazione circa l’impugnabilità dell’atto assume rilevanza centrale la sussistenza o meno di un vincolo giuridico all’esercizio del potere discrezionale, in quanto ciò che rileva “non è tanto che esso promani da un organo di vertice della pubblica amministrazione e che concerna le supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri, ma che sussista una norma che predetermini le modalità di esercizio della discrezionalità politica o che, comunque, la circoscriva”[2].
Sulla scorta di tali rilievi viene generalmente affermata la compatibilità dell’art. 7 c.p.a. con l’art. 113, comma 2, Cost., che – nel vietare ogni limitazione di tutela giurisdizionale “per determinate categorie di atti” – si riferisce unicamente a quelli riconducibili alla funzione amministrativa, onde evitare indebite interferenze del potere giudiziario nell’esercizio della funzione politica.
Tuttavia, anche in considerazione delle difficoltà di rinvenire nelle multiformi fattispecie concrete i connotati dell’atto politico, la giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto la disposizione eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, limitandone fortemente le concrete occorrenze applicative[3].
Risponde a tale esigenza la creazione pretoria della categoria di confine degli “atti di alta amministrazione”, caratterizzati anch’essi da un elevato livello di discrezionalità ma, a differenza degli atti politici, funzionalmente volti all’attuazione dei fini posti dalla legge e, pertanto, assoggettati al sindacato giurisdizionale amministrativo[4]. Anche la giurisprudenza costituzionale si è più volte pronunciata nel senso della necessità di un’interpretazione estremamente rigorosa della norma, chiarendo tra l’altro che, secondo una lettura costituzionalmente orientata della stessa, non ricorre la fattispecie dell’atto politico in presenza di una norma giuridica che ponga vincoli all’azione del potere politico governativo, indirizzandone l’esercizio[5].
[1] Si osserva come, con riferimento agli atti negoziali, la giurisprudenza più recente abbia individuato la categoria degli “atti prodromici”, distinti sul piano logico-giuridico dai successivi atti negoziali. Si tratta degli atti in cui si esplicita “il compimento di un processo decisionale ossia la formazione della volontà di compiere un atto di diritto privato, di cui l’ente abbia valutato ed approvato il contenuto”, sempre che “ciò risulti verificabile in base al procedimento seguito. In tal caso l’atto assume dignità provvedimentale e può essere autonomamente valutato sul piano della legittimità, e formare oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale ovvero di autotutela” (così Cons. Stato, Ad. Plen., 5 maggio 2014, n. 13, nonché 10/2011). Da ultimo, v. Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2022, n. 4770.
[2] Cons. Stato, sez. I, parere 19 settembre 2019, n. 2483. Cfr. Corte cost. 5 aprile 2012, n. 81.
[3] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 808; Id., sez. V, 27 novembre 2012, n. 6002, in Giur. it., 2013, 6, p. 1420, con nota di A. Giusti, Atipicità, effettività della tutela giurisdizionale e sostituzione dell’“atto politico” della pubblica amministrazione. Il caso delle elezioni nella Regione Lazio; Id., 6 maggio 2011, n. 2718, secondo cui non sono, “per i loro caratteri intrinseci, soggetti a controllo giurisdizionale solo un numero estremamente ristretto di atti in cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico, atti che non sono qualificabili come amministrativi e in ordine ai quali l’intervento del Giudice determinerebbe un’interferenza del potere giudiziario nell’ambito di altri poteri”.
[4] Chiarisce Tar Lazio, Roma, sez. I, 5 marzo 2012, n. 2223, che detti atti “svolgono un’opera di raccordo fra la funzione di governo e la funzione amministrativa e rappresentano il primo grado di attuazione dell’indirizzo politico nel campo amministrativo; essi costituiscono manifestazioni d’impulso all’adozione di atti amministrativi, funzionali all’attuazione dei fini della legge e sono pacificamente ritenuti soggetti al regime giuridico dei provvedimenti amministrativi”. Più recentemente, anche Tar Lazio, Roma, sez. IIter, 30 maggio 2016, n. 6267.
Per giurisprudenza costante, sono ascritti a tale categoria i provvedimenti di concessione della cittadinanza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2024, n. 2414); le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura di conferimento di incarichi direttivi ai magistrati: v. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 852. Sul tema, F. Taormina, Il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati: il processo di impugnazione e la fase dell’ottemperanza al giudicato. L’esperienza giurisdizionale amministrativa, in www.giustizia-amministrativa.it. Anche l’atto di revoca dell’assessore comunale è pacificamente considerato di atto di alta amministrazione: v. Cons. Stato, sez. I, parere 20 maggio 2021, n. 936, e 16 dicembre 2019, n. 3161. Si aggiunga che, anche nell’ambito di crescente rilevanza economica e giuridica rappresentato dal golden power, Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289, ha qualificato i provvedimenti di veto a operazioni societarie “atti di alta amministrazione”. V. anche Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 aprile 2022, n. 4486.
[5] Sent. 81/2012: “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate”. Del medesimo avviso sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sent. 28 giugno 2013, n. 16305, hanno riconosciuto carattere di atto amministrativo al diniego dell’apertura di trattative volte alla stipulazione di un’intesa tra lo Stato ed una confessione religiosa.
[…]
*Contributo estratto dal “Manuale del processo amministrativo” di Francesco Caringella, Marco Giustiniani – IV edizione – Dike giuridica editrice – Febbraio 2025