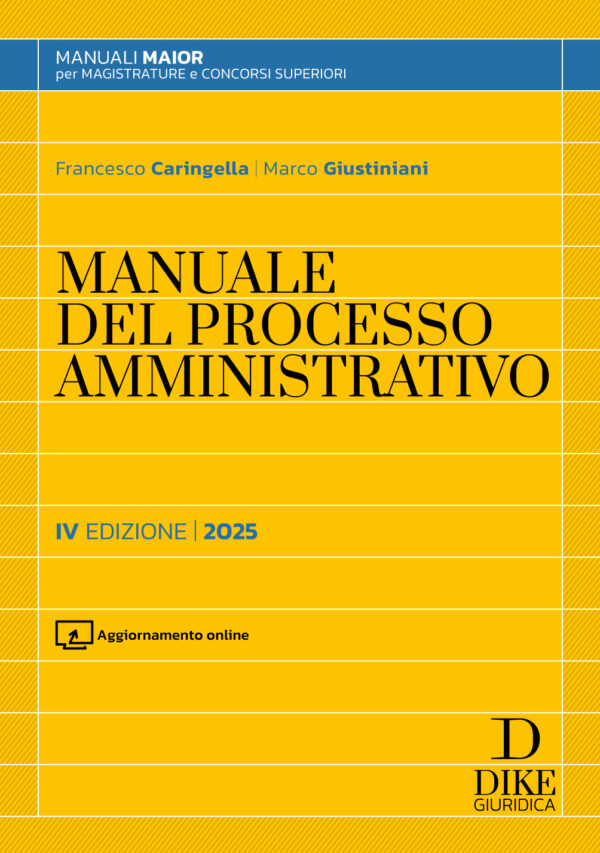A sette anni dall’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico (PAT), che ha imposto nuove regole in ordine alla notificazione del ricorso (e alla notificazione degli atti processuali in generale) e una nuova modalità di deposito degli atti processuali stessi e dei documenti[1], oltre che l’acquisizione di conoscenze e competenze tecnico-informatiche da parte dell’operatore giuridico, prende corpo l’iniziativa di esaminare e confrontare le fasi evolutive del processo digitale, a partire dalla sua complessa genesi fino ai numerosi provvedimenti adottati per governare lo svolgimento dell’attività giudiziaria durante l’emergenza epidemica da COVID-19 e alle misure che il Consiglio di Stato, da ultimo, con decreto 12 aprile 2022, n. 187, ha ritenuto di dover confermare anche dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria, ovvero sino al 31 dicembre 2022[2].
La riforma digitale che ha interessato negli ultimi tempi la giustizia amministrativa rientra nel piano di interventi attuato dal Governo con l’obiettivo di promuovere l’informatizzazione e la digitalizzazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione. In questo contesto di profonda trasformazione e innovazione tecnologica, la transizione digitale della giustizia amministrativa, regolamentata attraverso l’adozione di norme e disposizioni tra loro consequenziali, ha cambiato radicalmente il modo di operare di tutti gli attori del processo.
In linea con la continua e costante innovazione tecnologica, è in corso la predisposizione del nuovo portale della giustizia amministrativa che dovrebbe portare al superamento del caricamento mediante trasmissione degli atti via PEC e nel perfezionamento dei depositi immediatamente all’esito del caricamento on-line dei ricorsi e degli atti secondo la procedura guidata. L’accesso al portale dell’avvocato, anche finalizzato alla mera consultazione dei fascicoli, sarà modificato e sarà possibile accedere, dopo il superamento di una fase sperimentale di coesistenza del vecchio e del nuovo sistema, solo mediante l’utilizzo di sistemi di identità digitale (SPID) e non più attraverso le credenziali.
È con il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico”), poi confluito nel D.P.C.S. 22 maggio 2020, n. 134, ed ora regolato dal D.P.C.S. 28 luglio 2021,che si è dato il via al processo di digitalizzazione della giustizia amministrativa, in attuazione della disposizione di cui all’art. 13 dell’Allegato 2 del Codice del Processo Amministrativo[3], aprendo i battenti a un primo periodo di libera sperimentazione guidata dai Tar e dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Lo stesso Codice del Processo Amministrativo aveva previsto una prima informatizzazione del processo all’art. 136, commi 2 e 2bis.
Come accennato, cospicua è stata la produzione di contributi normativi e giurisprudenziali che si sono resi decisivi per giungere ad una efficiente e organica regolamentazione del PAT.
Pertanto, si proverà a passare sinteticamente in rassegna il panorama normativo di riferimento (incluse le proroghe dell’entrata in vigore), prima di analizzarne in dettaglio gli istituti e le novità.
La prima “bozza” del regolamento inviata alle rappresentanze forensi il 25 agosto 2015 fissava l’entrata in vigore del PAT al 1° gennaio 2016.
Il testo definitivo del Regolamento, adottato con D.P.C.M. 40/2016, ne ha prorogato l’entrata in vigore al 1° luglio 2016, a seguito degli inconvenienti tecnici e delle osservazioni espresse dagli utenti e dallo stesso Consiglio di Stato con parere del 20 gennaio 2016, n. 66.
Diverse le questioni esaminate dal Consiglio di Stato nella sede del richiamato parere, alcune tutt’ora dibattute, sulle quali ci si soffermerà più avanti. Tra queste: l’esclusione dal PAT del ricorso straordinario al Capo dello Stato (considerata anche la sua graduale “giurisdizionalizzazione”[4]), l’orario ultimo del deposito telematico (entro le ore 24 o le ore 12 dell’ultimo giorno utile ai fini del deposito), la prova telematica della notifica con modalità cartacea.
Il Regolamento introdotto con il decreto 40/2016 ha previsto, come si diceva, un periodo di sperimentazione limitato, dall’11 aprile al 20 maggio 2016, tale da consentire agli utenti la familiarizzazione con i nuovi strumenti informatici.
Il PAT, nel modo in cui è stato concepito dal decreto 40/2016, si struttura su tre componenti principali: il SIGA (Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa) inteso come “l’insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell’attività processuale” (art. 1, lett. d) del Decreto); la firma digitale in modalità PAdES; l’utilizzo dei moduli di deposito formato PDF reperibili nell’apposita sezione del sito istituzionale (non è previsto l’utilizzo di software gestionali come per il processo civile telematico) e fruibili attraverso il programma Acrobat Reader DC.
La necessità di una ulteriore messa a punto del sistema informativo e l’aggiornamento dei moduli utilizzati per il deposito hanno, tuttavia, nuovamente comportato la proroga dell’entrata in vigore del PAT al 1° gennaio 2017, con D.L. 30 giugno 2016, n. 117.
Ulteriori modifiche sono intervenute con la legge di conversione 12 agosto 2016, n. 161 che, con la previsione di cui all’art. 2, comma 1bis, ha inizialmente introdotto un “doppio binario”: vale a dire, la possibilità di procedere facoltativamente, fino alla data del 31 marzo 2017, al deposito cartaceo o telematico dei ricorsi e dei successivi atti, con le conseguenze del caso di cui si dirà in seguito.
Si segnala che la norma ha avuto vita breve perché abrogata dal successivo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.
Da ultimo, l’intervento del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 ha profondamente modificato l’originale fisionomia del PAT, con l’obiettivo di renderlo operativo ed efficace fin dalla prefigurata data di relativa entrata in vigore. Molte le novità che saranno analizzate nei paragrafi successivi.
Sul principio, ormai affermato, secondo cui nel processo amministrativo tutti gli atti e i documenti delle parti e degli ausiliari del giudice devono necessariamente essere depositati con modalità telematiche, il D.L. 168/2016 ha ulteriormente precisato le eccezioni in cui il deposito può avvenire con modalità cartacea, stabilendo anche un procedimento con cui può essere richiesta la dispensa dal deposito telematico. Se l’art. 136 c.p.a.[5], fa genericamente riferimento a “casi eccezionali”, il D.L. 168/2016 ribadisce e sottolinea che tali casi possono essere legati a particolari ragioni di riservatezza connesse alla posizione delle parti o alla natura della controversia. Qualora ricorrano tali casi eccezionali, le parti possono essere dispensate dal deposito telematico, su provvedimento motivato, dal Presidente dell’autorità giudiziaria adita (Consiglio di Stato, Consiglio di Giustizia Amministrativa, Tar, Sezione se il ricorso è già incardinato o Collegio se in udienza). Lo stesso dicasi per i provvedimenti del giudice.
Indicando nel 1° gennaio 2017 il nuovo termine per l’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico, il D.L. 168/2016 ha stabilito che i ricorsi depositati antecedentemente a tale data avrebbero seguito la disciplina previgente fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale erano pendenti e comunque non oltre il 1° gennaio 2018.
Abrogato il cosiddetto “doppio binario” temporaneo previsto nel precedente D.L. 117/2016, come convertito dalla L. 161/2016, il D.L. 168/2016 ha optato per una diversa modalità. Il nuovo regime, infatti, ha previsto che dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2019, per i giudizi introdotti con modalità telematiche dovesse essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico (successivamente resa permanente in sede di conversione del D.L. 113/2018).
La L. 25 giugno 2020, n. 70, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 aprile 2020, n. 28[6], ha tuttavia decretato la fine dell’obbligo di deposito della copia cartacea.
Un’altra novità di carattere pratico-operativo contenuta nel D.L. 168/2016 stabiliva che, sino al 31 dicembre 2017, i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione potessero essere effettuati via PEC o, nei casi previsti, mediante upload dai domiciliatari, anche se non iscritti all’Albo degli Avvocati. Sempre il D.L. 168/2016 si è occupato delle modalità concrete del deposito telematico, specificando i termini entro i quali questo può essere considerato “tempestivo”. Secondo quanto disposto, il deposito degli atti in scadenza è tempestivo se il depositante riceve la ricevuta di accettazione entro le ore 24:00. Mentre agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il termine ultimo per il deposito di atti e documenti in scadenza è delle ore 12:00.
Con l’art. 7, comma 2, lett. e) del medesimo decreto-legge, è stato peraltro introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il nuovo art. 13bis all’Allegato 2 del c.p.a. che ha attribuito, per un periodo di tre anni, la possibilità per il Collegio di primo grado – cui fosse stato assegnato il ricorso – la possibilità di rimettere, su richiesta di parte o d’ufficio, all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato eventuali contrasti giurisprudenziali o dubbi circa l’applicazione e l’interpretazione delle norme inerenti il Processo Amministrativo Telematico e che possano incidere, in modo rilevante, sul diritto di difesa di una parte. Se la richiesta è accolta, l’udienza è sospesa sino all’esito della decisione dell’Adunanza Plenaria. Si prevedeva, inoltre, che quest’ultima fosse convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta.
Al fine di garantire un ottimale avvio del Processo Amministrativo Telematico si è prevista l’istituzione di una Commissione di monitoraggio e dei cosiddetti uffici per il processo amministrativo o, semplicemente, uffici per il processo.
La prima, presieduta dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, ha il compito di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del Processo Amministrativo Telematico, di garantire la disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti, nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio.
Gli uffici per il processo sono, invece, strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dei Tribunali Amministrativi Regionali, che hanno il compito di supportare le attività dei magistrati amministrativi.
Inoltre, per garantire la funzionalità del servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l’attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, l’art. 9 del D.L. 168/2016 prevede nuove assunzioni di personale qualificato, in specie, dotato di competenze tecnico-informatiche necessarie al buon andamento del nuovo processo.
La legge di conversione del 25 ottobre 2016, n. 197[7] ha contribuito a definire il processo di adeguamento della giustizia amministrativa alle esigenze degli operatori del nuovo processo, recependo, con ulteriori aggiunte e modifiche, le novità già inserite nel D.L. 168/2016.
Una di queste consiste nell’estensione del potere di attestazione di conformità del difensore a tutti gli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico[8], con conseguente esonero dal pagamento dei diritti di copia (fatta eccezione per la copia autentica della sentenza richiesta con formula esecutiva che, ancora oggi, rimane di competenza delle segreterie degli uffici giudiziari). Nell’operare l’attestazione di conformità, il difensore assume a ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
Un’altra importante novità, soprattutto riguardo alle implicazioni che questa può avere sul diritto di difesa, è la possibilità che il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa introduca, con proprio decreto, limiti dimensionali ai depositi effettuati mediante upload o PEC (decreto 23 dicembre 2016, n. 154 del Segretario Generale della giustizia amministrativa).
La legge di conversione ha altresì esteso, in linea con quanto previsto dall’art. 136, comma 2bis, c.p.a. e dal D.P.C.M. 40/2016 per gli atti e i provvedimenti del giudice, l’obbligo di sottoscrizione con firma digitale anche per i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e per gli atti delle segreterie relativi all’attività consultiva.
La stessa norma ha poi introdotto una nuova disciplina in ordine al versamento del contributo unificato, sostituendo l’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e disponendo che, per i ricorsi proposti dinanzi al Giudice amministrativo, il contributo unificato è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Così, con decreto del 27 giugno 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in conformità all’ormai intrapresa digitalizzazione del processo amministrativo, si dispone che il contributo unificato sia versato, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con l’utilizzo del modello F24 presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari.
Infine, il decreto del 18 ottobre 2017, n. 211 del Segretario Generale della giustizia amministrativa, vista anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2017, n. 123/E[9], stabilisce che “dal 1° novembre 2017 il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana deve essere versato con l’apposito modello F24 Elide, presentato esclusivamente con modalità telematiche”.
Analizzando la fase di avviamento del Processo Amministrativo Telematico, non può sfuggire una rilevante modifica apportata in sede di conversione del D.L. 168/2016, perfettamente allineata con il principio di semplificazione e di celerità dell’attività giudiziaria amministrativa.
Si tratta dell’introduzione di nuove disposizioni in merito alla sinteticità e chiarezza degli atti di parte, con conseguente rafforzamento dell’obbligo di cui all’art. 3 del Codice del Processo Amministrativo.
In proposito, il nuovo art. 13ter del Titolo IV dell’allegato 2 del c.p.a., specifica che le parti devono redigere il ricorso e gli altri atti difensivi rispettando i criteri e i limiti dimensionali da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocato Generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti, e da adottare entro il 31 dicembre 2016.
In osservanza a quanto disposto, viene pubblicato il decreto del 22 dicembre 2016, n. 167 del Presidente del Consiglio di Stato (c.d. decreto Pajno), che chiarisce e fissa in alcuni punti fondamentali i criteri di redazione e i limiti dimensionali entro cui vanno contenuti gli atti processuali[10], indicando nello specifico: gli elementi strutturali e formali dell’atto che sono esclusi dai limiti dimensionali; le deroghe ai limiti dimensionali; il procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali e di autorizzazione successiva del giudice (su istanza della parte interessata) in caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente; le specifiche tecniche. Entrato in vigore il 2 febbraio 2017, è stato modificato con successivo D.P.C.S. 16 ottobre 2017, n. 127.
Nell’applicazione dei limiti dimensionali, afferma l’art. 13ter, si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
Degno di nota è anche il comma 5 dell’art. 13ter, in base al quale il giudice è tenuto a esaminare solo le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti prescritti.
L’esame delle questioni contenute nelle pagine successive ai suddetti limiti diviene per il giudice una mera facoltà, al punto che qualora si decidesse di non procedere all’esame delle stesse, tale omissione non potrebbe essere considerata motivo d’impugnazione.
La più grande opera di revisione, che ha imposto importanti modifiche ad alcune regole tecnico-operative del Processo Amministrativo Telematico, è avvenuta a seguito della crisi sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, che ha condizionato in maniera rilevante le relazioni sociali, al punto da rendere necessaria l’adozione di misure straordinarie.
Proprio per garantire il regolare svolgimento del processo, evitando situazioni di assembramento nelle cancellerie e nelle aule di udienza, si è scelto di intervenire integrando alcune procedure giudiziarie telematiche e sperimentando le udienze a distanza, cioè celebrate mediante collegamento da remoto.
Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28[11], con le nuove “misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”, oltre a completare il processo di dematerializzazione degli atti e dei documenti processuali, mediante la sospensione dell’obbligo della copia cartacea (poi sostituita da una soppressione definitiva di tale obbligo), ha disposto all’art. 4 che: “A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza”.
In altre parole, pur preservando il principio di oralità dell’udienza, seppur con l’impiego di strumenti informatici, le nuove misure urgenti hanno contemplato per la fase emergenziale più acuta, “in alternativa” all’udienza telematica, la facoltà per i difensori di optare per un iter processuale “cartolare”, che prevede il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti depositati.
Al riguardo, in forza del comma 1 dell’art. 4 del D.L. 28/2020, era data agli avvocati la facoltà di depositare delle note di udienza o cosiddette “brevi note” fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa. Diversamente, era possibile richiedere – mediante deposito telematico – il passaggio in decisione della causa. In ogni caso, entrambe le strategie processuali garantivano al difensore di essere considerato “presente a ogni effetto in udienza”.
Superata la fase emergenziale, si è tornati alle udienze in presenza. Ad ogni buon conto, un’eccezione è prevista in relazione alle c.d. udienze straordinarie per lo smaltimento dell’arretrato di cui all’art. 87, comma 4bis, del c.p.a. Esse sono state istituite dall’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 – recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”[12] – e sono destinate ad alleggerire i ruoli dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato. Ebbene, con decreto del 28 luglio 2021, n. 192[13], il Presidente del Consiglio di Stato ha previsto la modalità telematica per tale tipologia di udienze.
Nuove linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della giustizia amministrativa sono state, peraltro, definite nel decreto dell’8 febbraio 2022 del Presidente del Consiglio di Stato, che mirano a regolare e rafforzare la struttura e l’attività del cosiddetto Ufficio per il Processo[14] (UpP), il monitoraggio periodico dell’attività da esso svolta, teso a verificare l’andamento dell’abbattimento dell’arretrato, la predisposizione con cadenza quadrimestrale degli atti per la rendicontazione dei compiti svolti e, non ultimo, le udienze straordinarie, che si svolgono sempre da remoto e prevedono la partecipazione su base volontaria, senza trattamento di missione per i magistrati.
Il D.P.C.S. 28 luglio 2021, all’art. 14, detta inoltre specifiche disposizioni in ordine alle “Notificazioni per via telematica”, già introdotte nel processo amministrativo dal D.P.C.M. 40/2016, ora abrogato. Nel suindicato articolo, in cui si interviene appunto per razionalizzare la procedura della notifica a mezzo PEC, si legge fra i principali dettami, di cui si approfondirà più avanti, che qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, ai fini del deposito nel fascicolo informatico, è fatto obbligo ai difensori procedere all’asseverazione degli atti relativi alla notificazione, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del CAD[15], da effettuare con l’inserimento della dichiarazione di conformità all’originale nel medesimo o in un documento informatico separato.
A conclusione di questa nota introduttiva, con cui si è cercato di ripercorrere rapidamente l’eccezionale produzione normativa che ha caratterizzato il primo quinquennio di vita del Processo Amministrativo Telematico, per gran parte attribuibile al complesso compito di gestione del contenzioso a fronte dell’emergenza sanitaria, si sottolinea l’importanza del sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, con la sua sezione dedicata al PAT, che costituisce uno strumento di supporto sicuro ed essenziale per i riferimenti normativi e le istruzioni operative.
Sin dal principio, infatti, al fine di facilitare la transizione al telematico, è stata predisposta un’area del sito web riservata alla pubblicazione di alcune F.A.Q. informative, contenenti le risposte alle domande più frequenti poste sul nuovo rito, oltre che di un video dimostrativo.
[1] L’art. 7 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 “Disposizioni sul processo amministrativo telematico” ha disposto l’obbligatorietà del deposito di tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche a decorrere dal 1° gennaio 2017.
[2] Il D.P.C.S. 12 aprile 2022, n. 187, ha confermato fino al 31 dicembre 2022 le prescrizioni, di cui al “Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle Camere di Consiglio in presenza presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza”, stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, “dal punto 1) al punto 7), in relazione a: chiamate preliminari, richiesta di passaggio in decisione, fasce orarie, rinvio prosecuzione udienza al giorno successivo, misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.
[3] Art. 13 Allegato 2 del c.p.a: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico – operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali”.
[4] Sul punto si v. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 maggio 2024, n. 11.
[5] Come modificato dall’art. 20, D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132.
[6] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 30 aprile 2020, n. 111, con entrata in vigore al 1° maggio 2020 il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, reca “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”.
[7] La L. 25 ottobre 2016, n. 197, che converte con modificazioni, il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, è pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 29 ottobre 2016, n. 254, in vigore dal 30 ottobre 2016.
[8] L’art. 7, comma 2ter del D.L. 168/2016 affermava già che “Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento”.
[9] Con la risoluzione del 12 ottobre 2017, n. 123/E dell’Agenzia delle Entrate, vengono istituiti i cosiddetti “codici tributo” – GA01 – GA02 – GA03 – GA04 – GA05 – da indicare nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE) in sede di compilazione, e resi operativi a decorrere dal 1° novembre 2017 (sito internet della Giustizia Amministrativa alla pagina “Processo Amministrativo Telematico”)”. Alle sopraindicate disposizioni, seguono la risoluzione del 21 dicembre 2017, n. 159/E dell’Agenzia delle Entrate, che introduce ulteriori tre “codici tributo” – GA0T – GA0S – GA0Z – per il versamento delle somme dovute nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato a seguito dell’invito al pagamento da parte degli uffici della Giustizia Amministrativa, e la risoluzione del 25 gennaio 2018, n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate, che provvede ad estendere l’utilizzo dei “codici tributo” al modello di pagamento F24 Enti pubblici (c.d. F24 EP).
[10] Con decreto del 16 ottobre 2017, n. 127 del Presidente del Consiglio di Stato, al decreto 167/2016 (c.d. decreto Pajno) sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I limiti dimensionali di cui al comma 1 si applicano anche alle memorie di replica”; b) all’art. 6, comma 2, le parole: “A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in calce allo schema di ricorso, istanza motivata” sono sostitute con le seguenti: “A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula istanza motivata, allegando ove possibile lo schema di ricorso”.
[11] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2020, n. 111.
[12] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della L. 6 agosto 2021, n. 113.
[13] Recante “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 2 agosto 2021, n.183.
[14] Istituito con la L. 221/2012, modificata dal D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014), l’Ufficio per il Processo è concepito come una struttura organizzativa preposta a garantire la ragionevole durata del processo, promuovendo l’innovazione dei modelli organizzativi e un maggiore utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
[15] Codice dell’Amministrazione Digitale, istituito con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217.
[…]
*Contributo estratto dal “Manuale del processo amministrativo” di Francesco Caringella, Marco Giustiniani – IV edizione – Dike giuridica editrice – Febbraio 2025