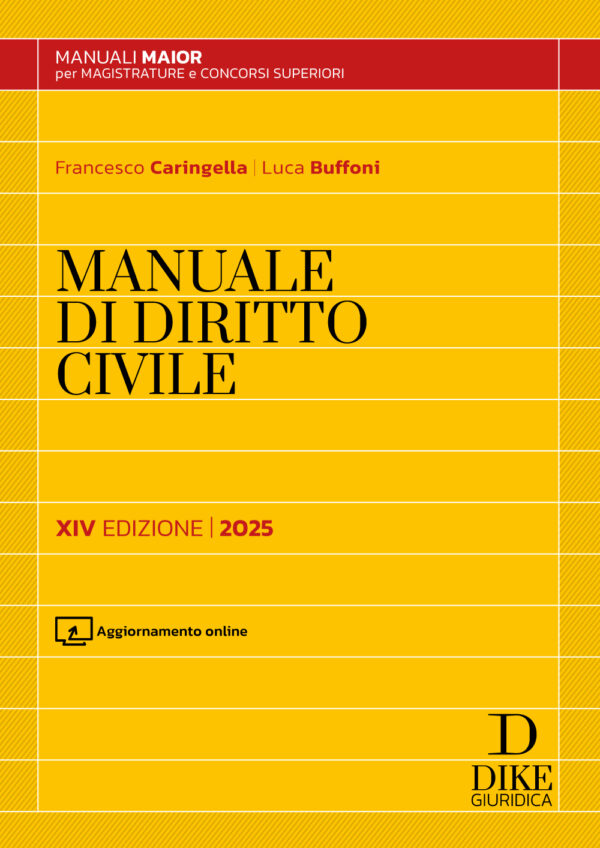L’invalidità del testamento – Il testamento può essere nullo o annullabile.
Del regime dell’annullabilità, applicabile in caso di vizi della volontà (art. 624 c.c.), di incapacità di disporre per testamento (art. 591, c.c.) e di vizi formali non determinanti (art. 606, comma 2, c.c.), si è già detto (cfr. supra, §3.3 e 4).
– La più grave sanzione della nullità priva il testamento di efficacia giuridica, travolgendo l’acquisto dell’eredità o del legato da parte dell’istituito, nonché gli acquisti dei terzi da costoro, salva l’applicabilità della disciplina in tema di erede apparente (art. 534 c.c.).
La nullità viene comminata, innanzitutto, in caso di contrarietà della disposizione testamentaria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, contrasto che emerge in modo speciale in tema di motivo illecito determinante, ai sensi dell’art. 626 c.c.
Altre cause generali di nullità sono poi il modus o la condizione illeciti o impossibili, anch’essi se determinanti (artt. 647 e 634 c.c.), la disposizione in incertam personam (art. 628 c.c.) o rimessa all’arbitrio del terzo (art. 631 c.c.) o, ancora, a favore di persona incapace di succedere ai sensi degli artt. 569 ss. c.c.
Sul piano formale, inoltre, determina la nullità la sussistenza di gravi vizi di forma, ossia tali da far dubitare della stessa provenienza del testamento dalla persona del de cuius. Rileva in tal senso la mancanza di autografia o sottoscrizione in caso di testamento olografo, l’inosservanza delle forme richieste dagli artt. 604 e 605 c.c. per il testamento segreto (salvo che esso non valga come olografo), la mancanza di redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione dell’uno o dell’altro, in caso di testamento pubblico (art. 606, comma 1, c.c.).
Causa specifica di nullità è, poi, la condizione di reciprocità (art. 635 c.c.).
– In ossequio al generale principio della conservazione del testamento, tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità di sanare le disposizioni affette da nullità mediante la conferma e l’esecuzione volontaria.
Ai sensi dell’art. 590 c.c. infatti, “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione”.
In base all’opinione tradizionale la fattispecie di cui all’art. 590 c.c. non integrerebbe una sanatoria in senso tecnico del negozio nullo, in deroga al principio generale di cui all’art. 1423 c.c., bensì un’ipotesi di denegazione dell’azione di nullità, privando l’autore della conferma della possibilità di agire in giudizio. Secondo questa tesi la perdita della legittimazione all’azione di nullità implicata dalla conferma non sarebbe idonea a rendere valido il testamento: la conferma o l’esecuzione, infatti, lo renderebbero solo relativamente efficace per il beneficiario, ferma restando l’invalidità nei confronti degli altri soggetti non confermanti, legittimati ad agire per un successivo e definitivo accertamento giudiziale della nullità.
Secondo altra tesi, autorevolmente sostenuta, la conferma ex art. 590 c.c. integrerebbe invece un’ipotesi di sanatoria in senso tecnico di un precedente negozio nullo, configurando un negozio autonomo avente causa propria consistente nell’eliminazione dei vizi da cui è inficiata la disposizione testamentaria che si intende sanare (Santoro-Passarelli; Torrente-Schlesinger). L’opinione in esame, sebbene coerente con il dato testuale (l’art. 1423 c.c. fa salva la possibilità di sanatoria del negozio nullo nelle ipotesi previste dalla legge, tra le quali rientrerebbe quella di cui all’art. 590 c.c.), si scontra con il fatto che il nuovo negozio proviene da soggetti diversi (eredi o legatari) dall’autore del negozio che intende sanare (testatore). Tale inconveniente, tuttavia, non pare dirimente ove si consideri che l’effetto giuridico finale non discende né dall’originario testamento nullo, né dal nuovo negozio di conferma, bensì da una fattispecie complessa che li ricomprende entrambi.
Non manca, infine, chi in dottrina ha ricondotto conferma ed esecuzione volontaria ad un’ipotesi di esecuzione di obbligazione naturale (Oppo).
Sebbene l’art. 590 c.c. nulla dica in proposito, si ritiene comunemente che i soggetti legittimati alla conferma della disposizione testamentaria siano gli stessi legittimati alla conferma della donazione (eredi o aventi causa dal testatore) stante il parallelismo tra le due norme e la loro comune derivazione dall’art. 1311 del codice civile del 1865 (così Capozzi). La conferma o esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla acquisterà conseguentemente efficacia sanante, ove proveniente dall’erede legittimo (o anche testamentario, ove l’erede abbia titolo alla successione in base ad un precedente testamento), o dall’onerato in caso di legato nullo (ma anche dal legatario designato con testamento precedente a quello oggetto di conferma).
La conferma può rivestire qualsiasi forma e, pertanto, può essere integrata da una dichiarazione negoziale (espressa) o da un comportamento concludente (tacita).
L’art. 590 c.c. non indica i requisiti del negozio di conferma espressa, ma dottrina e giurisprudenza ritengono analogicamente applicabile la disciplina della convalida del negozio annullabile (art. 1444 c.c.): l’atto di conferma dovrà pertanto contenere menzione del negozio che intende sanare, della causa di nullità e dell’intenzione di confermare.
La conferma tacita risulta invece integrata dalla volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie nulle. L’esecuzione deve essere volontaria, e dunque fatta al preciso scopo di convalidare il testamento nullo. Secondo l’orientamento preferibile anche la conferma tacita costituisce un negozio giuridico, e più precisamente un negozio di attuazione che realizza immediatamente la volontà dell’agente senza porlo in relazione con altri soggetti (Capozzi).
Nonostante l’ampia formulazione dell’art. 590 c.c., a tenore del quale la conferma del testamento è possibile quale che sia la causa da cui dipende la nullità, dottrina e giurisprudenza sovente si sono interrogate sulla effettiva portata della norma, domadandosi in particolare se tutte le disposizioni testamentarie nulle (per quelle annullabili, suscettibili di convalida secondo la disciplina generale del negozio giuridico, il problema non si pone) siano suscettibili di sanatoria.
Il problema è particolarmente delicato con riferimento alle disposizioni testamentarie illecite in quanto contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Secondo la tesi preferibile in tali casi più che un problema di sanatoria della disposizione testamentaria nulla (che come si è detto la legge ammette indipendentemente dalla causa da cui dipende la nullità), si pone la questione di verificare la liceità dello stesso negozio di conferma nella sua autonomia. La soluzione individuata dalla dottrina è quella di ritenere sanabili le sole disposizioni che derivino l’illiceità dal mezzo tecnico impiegato (testamento) – e così ad es. le ipotesi di nullità del testamento congiuntivo, del testamento a favore degli incapaci a ricevere, del testamento a condizione di reciprocità, delle disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo ecc. – mentre di contro saranno insuscettibili di conferma quelle disposizioni testamentarie che attingano la propria illiceità non dal mezzo tecnico utilizzato, bensì dal risultato che si intende raggiungere (si pensi ad es. ad un negozio confermativo di un legato disposto per favorire attività crimonose, alle sostituzioni fidecommissarie e alle disposizioni a favore dell’indegno – queste ultime contrarie all’ordine pubblico). Viene, inoltre, dai più esclusa la possibilità di confermare le disposizioni testamentarie inesistenti, false, revocate, lesive della quota di legittima, nonché contrarie al divieto dei patti successori, all’ordine pubblico o al buon costume.
*Contributo estratto dal “Manuale di diritto civile” di Francesco Caringella, Luca Buffoni – XIV edizione – Dike giuridica editrice – Febbraio 2025