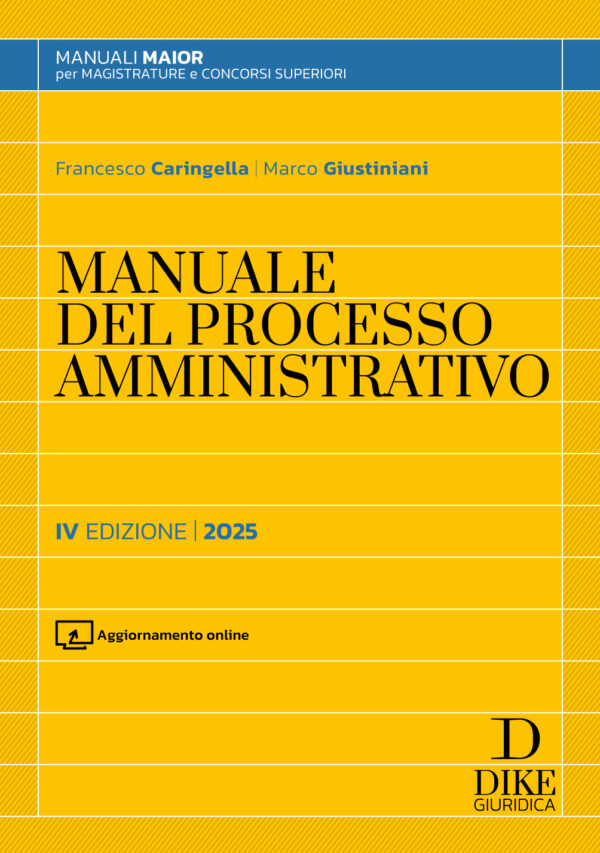L’appello in Consiglio di Stato – L’art. 100 del Codice del Processo Amministrativo recita testualmente: “Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”[1].
Nel sistema processuale amministrativo, dunque, il Consiglio di Stato rappresenta il giudice di seconda istanza, salvo i casi specifici in cui tale organo ha competenza in unico grado (È il caso, ad esempio, del giudizio di ottemperanza ai suoi stessi giudicati).
L’appello in Consiglio di Stato – La genesi del giudizio d’appello è del tutto peculiare.
Prima dell’entrata in vigore della legge Tar, invero, il Consiglio di Stato era giudice in unico grado della legittimità degli atti amministrativi; solo in relazione ad un ristretto numero di materie di competenza delle Amministrazioni locali il Consiglio di Stato fungeva da giudice di secondo grado, innanzi al quale era possibile proporre ricorso avverso le decisioni delle Giunte Provinciali Amministrative (breviter, G.P.A.)[2].
Tale sistema di giustizia amministrativa è stato notevolmente modificato dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (legge Tar), la quale ha attuato, a più di vent’anni di distanza dall’entrata in vigore della Costituzione, il principio del doppio grado di giudizio, a mezzo dell’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali quali giudici amministrativi di prima istanza[3].
L’appello in Consiglio di Stato – Il giudice di secondo grado è investito del riesame dell’intera materia del contendere, pur nei limiti in cui essa è fatta rivivere dalle parti tramite i motivi di gravame proposti a mezzo del ricorso in appello. Non va trascurato, infatti, che i capi di sentenza che non formano oggetto di appello (principale o incidentale) passano in giudicato allo scadere del termine per impugnare.
L’appello in Consiglio di Stato – Le decisioni suscettibili di impugnazione, stando ad un’interpretazione letterale dell’art. 100 c.p.a., sembrerebbero essere soltanto le sentenze dei giudici di prima istanza; in sede interpretativa, tuttavia, sembra preferibile ritenere che, al fine della proposizione dell’appello, si debba aver riguardo non già al nomen della decisione adottata dal giudice di primo grado, ma al suo contenuto. Ne deriva, pertanto, che possono essere oggetto di appello tutte le decisioni del Tar che, indipendentemente dalla loro qualificazione in termini di “sentenza”, presentino un contenuto decisorio; per converso, non sono appellabili le decisioni che, ancorché denominate “sentenze”, non ne presentino il contenuto tipico[4].
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, dunque, si pone il problema di discernere le pronunce del giudice di prime cure che presentano un contenuto decisorio da quelle che ne sono prive.
Sul punto va chiarito che l’appello ha per oggetto le sentenze, anche parziali, dei Tar di merito e di rito non passate in giudicato, le ordinanze cautelari, e più in generale tutte le pronunce del giudice di primo grado aventi natura decisoria, indipendentemente dalla loro veste esteriore. Non sono invece appellabili le sentenze passate in giudicato (che possono essere oggetto dei rimedi revocatori ex art. 106 c.p.a.), le pronunce istruttorie e quelle ordinatorie[5].
Si discute circa l’appellabilità dei decreti monocratici recanti misure cautelari provvisorie (v. infra), trattandosi di misure sottoposte, ai sensi dell’art. 56, comma 4, c.p.a., ad un sindacato collegiale di prime cure che, logicamente e sistematicamente, precluderebbe l’ammissibilità del parallelo rimedio dell’appello.
L’appello in Consiglio di Stato – Tra le decisioni appellabili, inoltre, il Codice del Processo include espressamente le ordinanze cautelari (oggetto di uno specifico strumento di appello, c.d. “cautelare”: art. 62, v. Cap. 3 della Parte IV); le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (cfr. art. 79, comma 3, c.p.a.) e l’ordinanza che dichiara il difetto di competenza derogabile ex art. 16 c.p.a.
L’appello in Consiglio di Stato – Quanto alle sentenze emesse in sede di giudizio di ottemperanza (v. Cap. 2 della Parte VIII), la giurisprudenza ne esclude pacificamente l’appellabilità solo quando esse contengano statuizioni meramente attuative del giudicato, ovvero semplici modalità per l’esecuzione del medesimo, essendo in questo caso evidente che tali pronunce presentano un carattere meramente servente alla sentenza passata in giudicato; a contrario, si ritiene che dette decisioni siano soggette al normale gravame quando recano un contenuto decisorio, il che si verifica allorché sia contestata la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive necessarie per l’esperimento dell’azione o la mancata pronuncia sulla fondatezza della pretesa azionata. L’impugnabilità delle sentenze emesse in sede di giudizio di ottemperanza pare ora implicitamente ammessa dall’art. 114, commi 8 e 9, c.p.a.
[1] Secondo Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 2014, n. 12, si tratta di una “competenza funzionale inderogabile”. Le relative norme, “avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale, con la conseguenza che non è possibile estendere le norme che, in primo grado, disciplinano la riassunzione del processo avanti al giudice competente”.
Il Cons. Stato, Ad. Plen., 14 marzo 2023, n. 10, ha chiarito inoltre, recentemente, che, in forza del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654 e dell’art. 6 c.p.a., spetta al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ogni decisione in rito e nel merito sull’appello erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (sede di Palermo o sezione staccata di Catania), ivi compresa l’eventuale declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ha altresì chiarito che, per evitare il differimento della definizione del giudizio, la Presidenza del Consiglio di Stato deve de plano trasmettere alla segreteria del C.g.a. l’appello erroneamente proposto al Consiglio di Stato avente sede in Roma avverso una sentenza del Tar per la Sicilia e che, qualora detto appello sia stato già assegnato dalla Presidenza ad una delle sezioni del Consiglio di Stato, la sezione avente sede in Roma non può, in ogni caso, decidere la causa (neppure in sede cautelare, ostandovi il divieto di cui all’art. 15 c.p.a.) ma deve dichiarare la propria incompetenza affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla sezione staccata.
[2] La Costituzione repubblicana ha confermato sostanzialmente le linee cui s’ispirava la precedente legislazione, stabilendo all’art. 103 che: “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”, e all’art. 113 che: “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa”.
Il sistema della giustizia amministrativa ha subìto successivamente notevoli modifiche per effetto della sentenza della Corte cost. 22 marzo 1967, n. 30, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, perché in contrasto con gli artt. 101 e 108, comma 2 (sull’indipendenza e imparzialità del giudice) delle norme sulla composizione in sede giurisdizionale delle Giunte provinciali amministrative, in quanto in esse la maggioranza dei componenti (tre su cinque: il prefetto e due funzionari di prefettura della carriera direttiva) si trovava in condizioni di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo.
Con la soppressione delle Giunte provinciali amministrative, cioè dell’unico organo di giustizia amministrativa locale, che, sebbene con attribuzioni limitate, esisteva nel nostro ordinamento, il Consiglio di Stato rimase Giudice amministrativo di primo e unico grado. Il vuoto provocato dalla soppressione delle Giunte provinciali amministrative è stato colmato con l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali (v. L. 6 dicembre 1971, n. 1034), dando in tal modo attuazione al disposto dell’art. 125, comma 2, Cost., il quale stabilisce che: “Nelle Regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione”.
[3] Il principio del doppio grado di giurisdizione, che non ha rilevanza costituzionale rispetto alla giurisdizione ordinaria ed a quelle speciali, trova copertura nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 125, comma 2, Cost. che prevede tribunali amministrativi di primo grado (soggetti come tali al giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato).
Esso non riguarda soltanto il processo di merito, ma anche quello incidentale cautelare, stante la generalità della dizione della norma costituzionale e la necessità che le opposte posizioni del privato e della P.A. trovino la più completa valutazione da parte del Giudice amministrativo (essendo la sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo impugnato suscettibile di incidere in maniera decisiva sulle conseguenze delle pronunce di merito del giudice, e quindi, sia pure indirettamente, sulla tutela degli interessi che entrano nel processo amministrativo). L’art. 28 L. 1034/1971, che menziona come appellabili soltanto le sentenze di Tar, viene riferito dalla giurisprudenza (in coerenza con il principio del doppio grado) a tutti i provvedimenti decisori, fra i quali va annoverata l’ordinanza che pone termine al procedimento cautelare (Corte cost. 1° febbraio 1982, n. 8).
[4] Si aggiunga che di recente il Consiglio di Stato (sez. IV, 13 maggio 2016, n. 1933; sez. III, 31 marzo 2016, n. 1262) ha affermato che, nel giudizio amministrativo, l’appello concernente esclusivamente le spese (benché formalmente legittimo ed ammissibile), deve essere in linea di massima respinto in quanto concernente una valutazione ampiamente discrezionale di equilibrio processuale che riguarda ogni singola fase del giudizio e spetta al Giudice che la svolge tranne il caso di manifesta e diretta violazione dei criteri fissati da norme di legge tale da configurare gli estremi di una decisione aberrante (quale quella che ponga le spese a carico della parte vincitrice in diretta violazione dell’art. 91 c.p.c.).
[5] I provvedimenti del Giudice amministrativo di primo grado sono appellabili quando, pur avendo forma esteriore di ordinanza e non di sentenza, abbiano reale contenuto decisorio della controversia, cioè quando esplicitamente o implicitamente risolvano in tutto o in parte la questione che oppone le parti ovvero un punto pregiudiziale di essa. Difatti, al fine di stabilire se un provvedimento abbia la natura di sentenza o di ordinanza, quindi se sia o meno appellabile, è decisiva non già la forma adottata, ma il suo contenuto in base al principio della prevalenza, in materia, della sostanza sulla forma (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 15 luglio 2014, n. 3688).
L’appello avverso l’ordinanza istruttoria è inammissibile, atteso che, per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. all’art. 177, comma 2, c.p.c., è possibile chiedere, sussistendone i presupposti, la revoca, anche parziale, dell’ordinanza stessa (cfr. anche Cons. Stato, Ad. Plen., 24 gennaio 2023, n. 4). Non opera, invece, estensivamente il principio declinato in via pretoria, in tema di ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, ord. 1° marzo 2024, n. 2018).
[…]
*Contributo estratto dal “Manuale del processo amministrativo” di Francesco Caringella, Marco Giustiniani – IV edizione – Dike giuridica editrice – Febbraio 2025