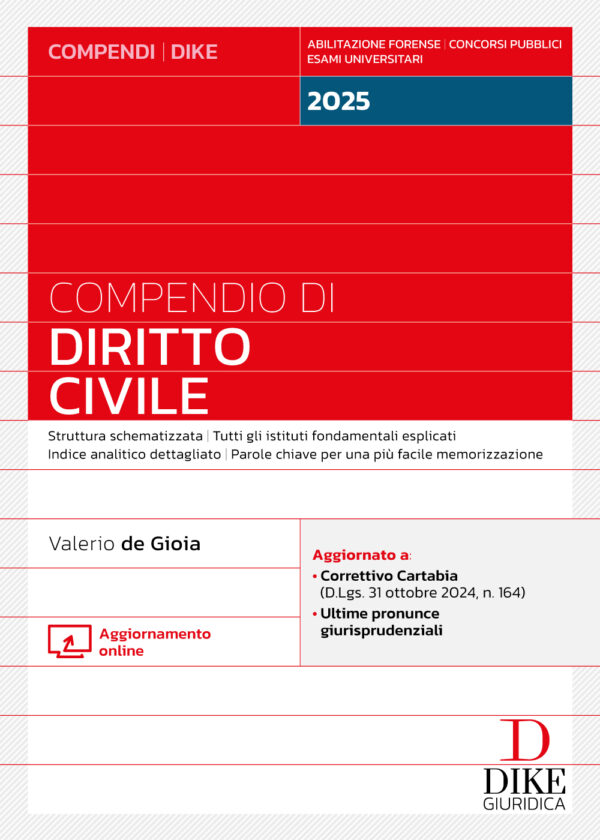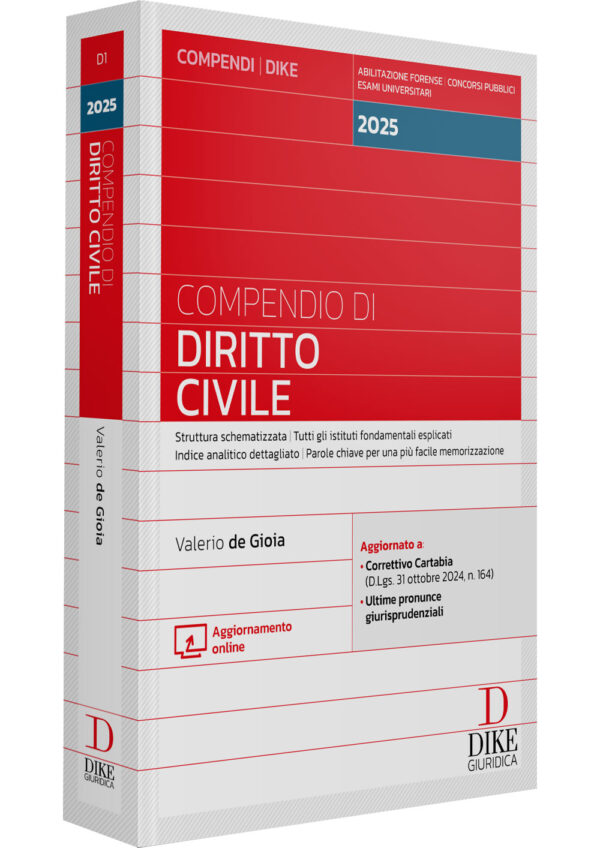[…] La presunzione di patenità. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c., come novellato dal D.Lgs. cit.).
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
Secondo l’art. 234 c.c., anch’esso novellato dal D.Lgs. 154/2013, ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni:
1) dalla pronuncia di separazione giudiziale;
2) dalla omologazione di separazione consensuale;
3) dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.
Ai sensi dell’art. 236 c.c., come novellato dal D.Lgs. 154/2013, la filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile; basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio.
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere (art. 237 c.c.).
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti che:
a) il genitore abbia trattato la persona come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa;
b) la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
c) sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
La Corte costituzionale, con sent. 21 dicembre 2016, n. 286, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
L’art. 238 c.c. (irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita) prevede che, salvo quanto disposto dagli artt. 128, 234, 239, 240 e 244 c.c., nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso.
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso (art. 239 c.c.).
L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. Può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.
In base all’art. 240 c.c., lo stato di figlio può essere contestato nei casi di:
1) supposizione di parto o di sostituzione di neonato;
2) figlio nato nel matrimonio ma iscritto come figlio di ignoti.
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo (art. 241 c.c.).
L’art. 243bis c.c., inserito dal D.Lgs. 154/2013, regolamenta il disconoscimento di paternità: l’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
[…]
*Contributo estratto dal “Compendio di diritto civile” di Valerio de Gioia – Dike giuridica editrice – Gennaio 2025