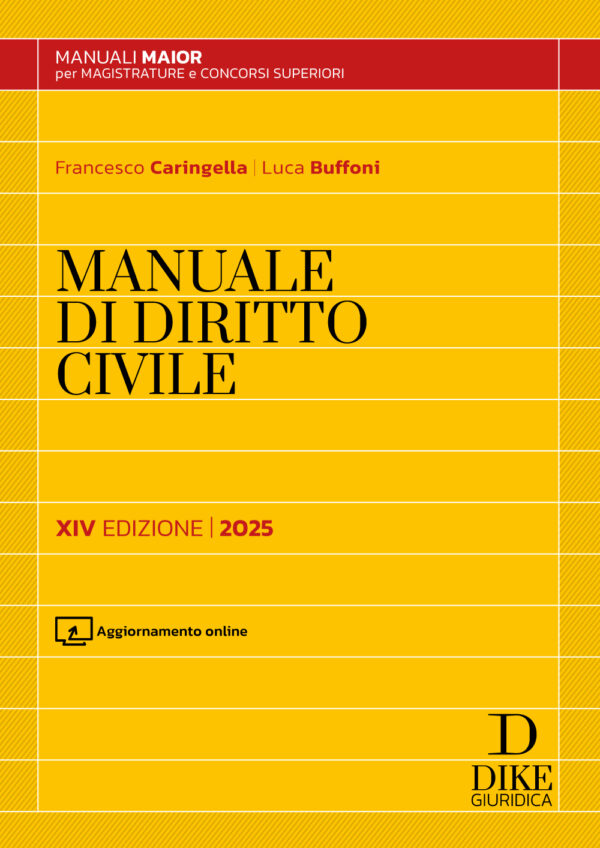[…] La prescrizione è l’estinzione di un diritto causata dal mancato esercizio dello stesso da parte del suo titolare per il tempo determinato dalla legge (art. 2934, comma 1, c.c.).
La formulazione dell’art. 2934 c.c. (“Ogni diritto si estingue per prescrizione […]”) sembra risolvere definitivamente la vexata quaestio se la prescrizione estingua il diritto soggettivo, la posizione sostanziale, ovvero l’azione diretta a far valere detto diritto. Il Codice del 1942, infatti, innovando rispetto all’art. 2135 del Codice previgente (“tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono […]”) riferisce l’effetto estintivo al diritto e non all’azione. Il problema si poneva sul piano pratico nel vigore del vecchio codice, per il fatto che non sussistendo una norma corrispondente all’attuale art. 2940 c.c., sorgeva il problema dell’ammissibilità della soluti retentio nell’ipotesi di pagamento di un debito prescritto. Infatti ove la prescrizione avesse estinto il diritto di credito e non l’azione, l’adempimento del debito prescritto avrebbe dovuto configurare un indebito, suscettibile di ripetizione. L’art. 2940 c.c. tuttavia, a tenore del quale “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”, relega la questione su un piano prettamente teorico “la cui soluzione dipende dal concetto che si accolga della c.d. obbligazione naturale (art. 2034), nella quale si trasformerebbe l’obbligazione precedente” (Santoro-Passarelli). In dottrina la soluzione sostanzialistica, che sembrerebbe accolta dall’attuale formulazione dell’art. 2934 c.c., non è unanimemente condivisa. Si osserva infatti che nel corpo del Codice residuano una serie di disposizioni che continuano a riferire la prescrizione all’azione (es. artt. 948, 1422, 1442, 1449, 1495 c.c.), ovvero all’eccezione (cfr. art. 1442, u.c. in tema di azione di annullamento, ma anche l’art. 1495, comma 3, c.c.) e si pone in evidenza la sostanziale difformità tra la disciplina della prescrizione e quella dell’estinzione del rapporto obbligatorio osservandosi in particolare che a differenza di quest’ultima la prescrizione non è rilevabile d’ufficio (art. 2938 c.c.) non potendo il giudice tenerne conto se non viene eccepita; si osserva ancora che la prescrizione opera non solo quando il diritto è sorto e viene esercitato tardivamente, ma anche quando il diritto non è mai sorto, ovvero è sorto ed è già stato estinto diversamente, ad es. per adempimento (Panza, Gazzoni).
Il fondamento della prescrizione risiede da un lato nella richiamata opportunità di adeguamento della situazione di diritto alla situazione di fatto, essendo inopportuno dal punto di vista sociale ed economico distogliere risorse dalla collocazione che esse hanno spontaneamente trovato mentre durava l’inerzia del titolare; e dall’altro in una fondamentale esigenza di certezza dei rapporti giuridici, in ragione del fatto che il mancato esercizio del diritto determina nei consociati la convinzione che esso non esista o sia stato abbandonato, e che comunque in caso di contestazioni il decorso del tempo renderebbe eccessivamente gravoso e fondato su elementi labili un giudizio in merito alla sussistenza del diritto stesso.
La prescrizione estintiva è dunque stabilita per ragioni di interesse generale, dovendosi conseguentemente considerare un istituto di ordine pubblico. Ciò spiega l’inderogabilità pattizia della relativa disciplina positivamente sancita dall’art. 2936 c.c. a tenore del quale “è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”.
Per le stesse ragioni è nulla la rinuncia (preventiva o durante il corso della prescrizione) ad una prescrizione non ancora compiuta, che tuttavia può valere come riconoscimento del diritto soggetto a prescrizione con conseguente effetto interruttivo (cfr. infra).
Qualora, peraltro, il termine di prescrizione sia decorso, la legge consente al soggetto di disporre degli effetti della stessa, rinunziando a farla valere. Ciò in quanto una volta che la prescrizione abbia adempiuto la sua funzione, che è quella di garantire una conformazione della situazione di fatto a quella diritto contribuendo alla certezza dei rapporti giuridici, pare opportuno garantire al soggetto che ne beneficia una sfera di libertà nella decisione di profittare o meno degli effetti favorevoli che ad essa conseguono. Come autorevolmente osservato, infatti, il servirsi della prescrizione estintiva non sempre può risultare conforme all’etica, posto che in definitiva la prescrizione può produrre un ingiustificato profitto a scapito d’altri. Ai sensi dell’art. 2937 c.c. la rinunzia alla prescrizione può risultare anche da un fatto incompatibile con la volontà di valersene (ad es. richiesta di una dilazione per il pagamento del debito prescritto) e deve provenire da un soggetto che abbia la capacità di disporre (non come dice la legge con formulazione infelice, il potere di disporre del diritto, poiché il diritto che si estingue con la prescrizione appartiene non già al rinunziante bensì all’altra parte; in tal senso Messineo e Santoro-Passarelli).
In base al principio della disponibilità degli effetti si spiega anche la regola di cui all’art. 2938 c.c. che vieta al giudice la rilevabilità d’ufficio della prescrizione, che deve dunque essere opposta con eccezione di parte.
La regola della disponibilità degli effetti della prescrizione non può tuttavia operare in pregiudizio dei creditori o più in generale dei terzi che abbiano interesse ad opporla (ad es. gli aventi causa dal debitore). Per questo la legge attribuisce a questi ultimi una legittimazione surrogatoria (art. 2900 c.c.) ad opporre la prescrizione anche nell’ipotesi in cui l’interessato vi abbia rinunziato (art. 2938 c.c.).
La regola generale sancita dall’art. 2934 c.c. (“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”) non è applicabile a quei diritti la cui appartenenza al soggetto non dipenda dalla volontà del medesimo.
Così ai sensi dell’art. 2934, comma 2, c.c. non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili (dei quali il soggetto non può disporre mediante atti di volontà) posto che, in caso contrario, egli potrebbe disporne e perderli astenendosi dall’esercitarli (Santoro-Passarelli). Devono inoltre considerarsi imprescrittibili, quei poteri attribuiti alla persona a tutela di un interesse superiore o di un interesse altrui (ad es. responsabilità genitoriale), nonché, come si è già avuto modo di osservare, le facoltà, che non godono di autonoma rilevanza rispetto al diritto cui accedono (Parte I, Sez. IV, Cap. 1, §2).
L’art. 2934, comma 2, c.c. prevede inoltre, con una formula di chiusura, che non sono soggetti a prescrizione gli altri diritti indicati dalla legge, tra i quali spicca il diritto di proprietà che è il solo diritto disponibile che non si estingua per prescrizione. Merita osservare che l’imprescrittibilità del dominio, pur non essendo testualmente prevista dalla legge, si argomenta con sicurezza dall’assoggettamento a prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, 970, 1014, 1073, 2880 c.c.) nonché dall’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione (art. 948, comma 3, c.c.).
Tale scelta legislativa (peraltro contestata da autorevole dottrina) può essere compresa ponendo mente alla funzione conformativa della prescrizione: “invero, mentre all’estinzione del diritto personale segue quella liberazione del soggetto passivo dal vincolo, all’estinzione del diritto su cosa altrui quell’espansione della proprietà, che sono conformi alla preesistente situazione di fatto, invece con la prescrizione della proprietà verrebbe a crearsi una situazione nuova, anche di fatto, perché la cosa diventerebbe di nessuno; la prescrizione inoltre non servirebbe un interesse già in stato di soddisfazione, al quale provvede invece l’usucapione” (Santoro-Passarelli; ma cfr. anche nello stesso senso Torrente-Schlesinger).
Non sono infine soggette a prescrizione l’azione di nullità (art. 1422 c.c., cfr. infra, Parte V. Sez. II, Cap. 11, §2) e l’azione di petizione di eredità (art. 533, comma 2, c.c., cfr. infra, Parte VII, Cap. 2, §5).
Si è detto che l’estinzione del diritto per prescrizione non è effetto del mero decorso del tempo, bensì dell’inerzia nell’esercizio del diritto durata per un certo lasso temporale. È dunque evidente che alcune circostanze che escludono la ravvisabilità di un’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto influiscono sul corso della prescrizione, rispettivamente impedendolo, sospendendolo, ovvero interrompendolo.
In primo luogo non può ravvisarsi inerzia quando il diritto non può essere fatto valere (actio nondum nata non praescribitur, art. 2935 c.c.). Non impediscono, di regola il decorso del termine di prescrizione gli eventuali ostacoli materiali che si dovessero frapporre fra il titolare e il diritto da esercitare; così, mentre non impedisce il decorso del termine il fatto che il titolare ignori l’esistenza del diritto, a meno che l’ignoranza non derivi dal dolo del debitore, che abbia celato l’esistenza del debito (art. 2941, n. 8, c.c.) invece, all’opposto, il termine non decorre nell’eventualità che l’ostacolo all’esercizio sia di natura legale, come nel caso del contratto sottoposto a condizione o termine.
Può inoltre accadere che il diritto possa astrattamente farsi valere, ma il suo esercizio sia in concreto ostacolato o reso difficile da una speciale condizione giuridica in cui si trovi il titolare (cfr. art. 2942 c.c.) o da una speciale relazione giuridica tra il titolare e il soggetto passivo (cfr. art. 2941 c.c.). In tali ipotesi vale la regola per cui contra non valentem agere non currit praescriptio, e il corso della prescrizione si sospende. I casi di sospensione sono tassativamente previsti dagli artt. 2941-2942 c.c., cui va aggiunto quello introdotto dalla Corte costituzionale, nelle cause fra datore e lavoratore per il diritto alla retribuzione, in costanza del rapporto di lavoro.
Per la Suprema Corte (2 novembre 2022, n. 32212), tuttavia, con riferimento al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative a un immobile in comproprietà con l’altro, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1, c.c. Ciò in quanto si ritiene che in tal caso debba prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, che va individuata considerando l’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, valorizzando le posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, è considerata insussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, essendo già subentrata una crisi conclamata e già esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.
Il corso della prescrizione si interrompe nell’ipotesi in cui l’inerzia del titolare venga meno. La prescrizione è dunque interrotta nell’ipotesi di domanda giudiziale proposta dal titolare del diritto, ancorché a giudice incompetente, nonché nell’ipotesi di comunicazione alla controparte della volontà di promuovere un procedimento arbitrale (artt. 2943 c.c.). Nella prima ipotesi la prescrizione non corre finché non passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, e, se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo (art. 2945, commi 2 e 3, c.c.); nel caso di arbitrato, invece, la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.
La prescrizione è altresì interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, comma 4, c.c.; cfr. Parte V, Sez. I, Cap. 6, §6), e dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).
In ragione della diversità della rispettive cause (nell’ipotesi di sospensione l’inerzia del titolare perdura ma è giustificata; nel caso dell’interruzione essa viene a mancare “o perché il diritto è stato esercitato, o perché – e ciò agli effetti giuridici è equivalente – esso è stato riconosciuto dall’altra parte”; Torrente-Schlesinger) le discipline della sospensione e della interruzione della prescrizione sono profondamente diverse. In particolare la sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo in cui l’inerzia è giustificata (ad es. tra i coniugi la prescrizione resta sospesa per tutto il periodo in cui perdura lo stato di coniugio), ma non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza (ad es. prima del matrimonio), che dunque si somma con il periodo successivo alla cessazione della causa sospensiva (come efficacemente osservato la sospensione può dunque paragonarsi ad una parentesi; Torrente-Schlesinger). L’interruzione invece, facendo venir meno l’inerzia, toglie ogni valore al tempo trascorso prima del verificarsi dell’evento interruttivo, con la conseguenza che dal verificarsi di detto evento decorre un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 c.c.). L’interruzione della prescrizione, infine, a differenza della sospensione, opera anche rispetto agli altri creditori o debitori in solido o al fideiussore (artt. 1310, 1957 c.c.).
Rispetto alla durata si distingue la prescrizione ordinaria dalle prescrizioni brevi.
La prescrizione ordinaria è applicabile in tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente, ed è pari a dieci anni.
Un termine ventennale, parallelo a quello previsto in tema di usucapione, è tuttavia stabilito per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui (cfr. artt. 954, 970, 1014, 1073 c.c.).
Termini prescrizionali di minor durata sono previsti dal Codice in relazione alla natura di determinati rapporti. Così sono soggette ad una prescrizione quinquennale l’azione di annullamento del contratto (art. 1442 c.c.), l’azione revocatoria (art. 2903 c.c.), e l’azione di risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947 c.c.). Rispetto a tale ultima azione deve tuttavia tenersi conto della disposizione di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. a tenore del quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”. Peraltro qualora il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. In cinque anni si prescrivono inoltre i diritti a prestazioni periodiche (come ad es. le annualità delle rendite o delle pensioni alimentari, le pigioni ed in generale i corrispettivi di locazioni, gli interessi), le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, i diritti che derivano dai rapporti sociali (artt. 2947 e 2948 c.c.). Termini ancor più brevi (biennali, annuali) sono previsti per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli, per i diritti derivanti dai contratti di spedizione o trasporto e per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (artt. 2950 ss. c.c.).
Qualora sopravvenga una nuova norma che prolunga un termine di prescrizione originariamente previsto, essa è applicabile se il termine risulta già avviato ma non ancora consumato, mentre non opera rispetto a un termine già consumato; qualora invece sopravvenga una nuova norma che abbrevia un termine prescrizionale, la sua applicazione a un termine già in atto integra una retroattività non consentita dall’art. 11 prel. (Cass. 27015/2022).
Qualora il diritto sottoposto a prescrizione breve sia stato oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato, l’azione diretta all’esecuzione del giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.). La ratio di questa disposizione sta in ciò che “al rapporto giuridico originario, sottoposto a prescrizione breve, si è sostituito il diritto di credito nascente dalla sentenza, e rispetto a tale diritto non valgono le ragioni che giustificano, secondo il legislatore, un periodo prescrizionale più breve” (Torrente-Schlesinger).
*Contributo estratto dal “Manuale di diritto civile” di Francesco Caringella, Luca Buffoni – XIV edizione – Dike giuridica editrice – Febbraio 2025