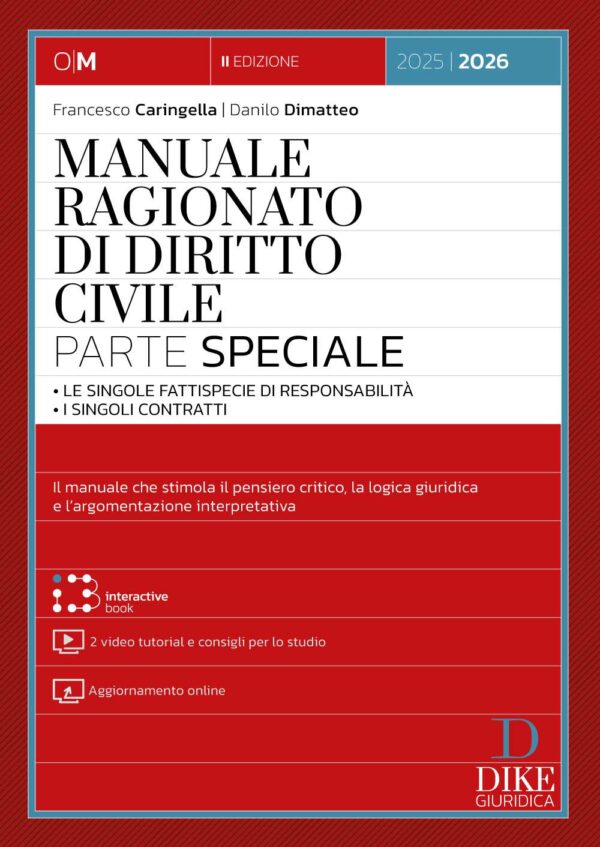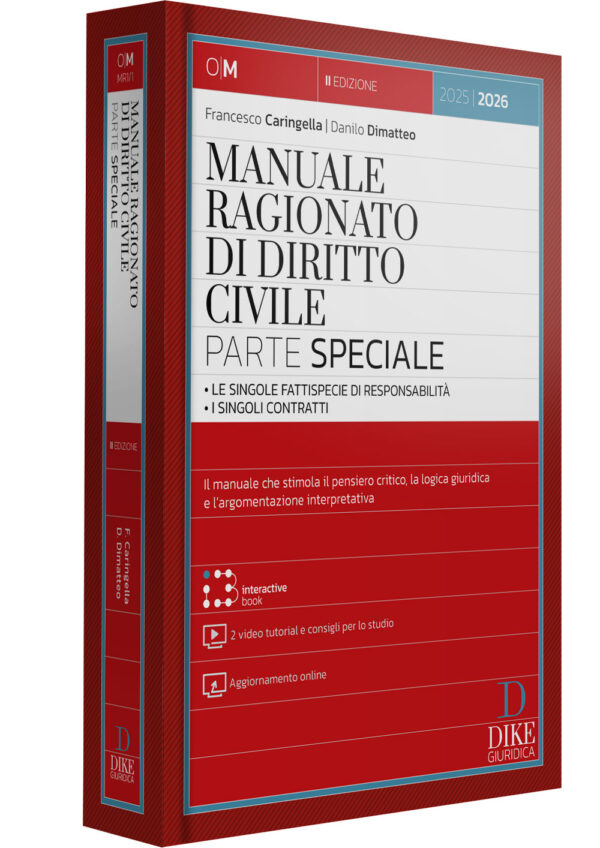Il leasing costituisce un contratto atipico, non esistendo una disciplina compiuta e organica dell’istituto in esame.
Il leasing può essere definito, da un punto di vista economico, come quella operazione negoziale, avente struttura trilaterale, in cui il soggetto utilizzatore (o concessionario) si rivolge ad una società di leasing, affinché questa acquisti da un fornitore un bene individuato dal concessionario, mobile o immobile, per poi concederlo in godimento allo stesso, dietro versamento di un corrispettivo periodico.
La funzione del leasing consiste, dunque, nel consentire all’utilizzatore di acquisire la disponibilità di beni, normalmente utilizzati nel ciclo produttivo e dall’elevato costo, senza doversi privare in un’unica soluzione della liquidità necessaria al loro acquisto, grazie all’apporto economico del concedente, il quale, con le proprie risorse finanziarie, consente all’utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l’utilità di realizzare.
Occorre soffermarsi sulla sequenza di atti che conduce alla nascita del rapporto: posta la complessità dell’operazione, l’utilizzatore individua il fornitore idoneo a procurargli il bene oggetto di leasing e concorda con questo le modalità di acquisto del bene da parte del futuro concedente. Ciò posto, l’utilizzatore si rivolge alla società di leasing e predispone una proposta contrattuale, sulla falsa riga dell’accordo con il fornitore. Si tratta, in specie, di proposta unilateralmente predisposta, attraverso l’utilizzo di formulari, sicché si rende necessaria una specifica sottoscrizione delle eventuali clausole vessatorie, in conformità agli artt. 1341 e 1342 c.c. Una volta stipulato il contratto, il concedente procede all’acquisto del bene dal fornitore: a decorrere da tale momento, ha inizio il periodo di godimento del bene da parte dell’utilizzatore, secondo le modalità e i tempi individuati dal contratto.
Da un punto di vista giuridico, detta operazione si compone di due distinti contratti bilaterali: il leasing vero e proprio, stipulato tra concedente ed utilizzatore, e il contratto di compravendita o di appalto, stipulato tra fornitore e concedente.
La dottrina si è interrogata circa l’esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti declinati. Secondo una prima ricostruzione, risulterebbe possibile individuare un collegamento negoziale in senso tecnico, sotto il profilo funzionale. I fautori di tale tesi, ad ogni modo, affermano l’autonomia delle sorti dei contratti. Ne deriva l’inapplicabilità del principio simul stabunt simul cadent, salva espressa volontà delle parti di creare tale dipendenza. Secondo un differente orientamento non vi sarebbero, piuttosto, gli estremi per presumere l’esistenza di un collegamento giuridicamente volto a indirizzare i due negozi verso uno scopo comune.
Il contratto in analisi può, infine, costituirsi in base ad uno schema alternativo. È quanto accade con il leasing c.d. operativo, costituito, invece, da un’operazione a struttura bilaterale, in cui lo stesso produttore, verso corrispettivo, concede in godimento il bene, standardizzato, al conduttore. Si tratta, secondo un ormai consolidato orientamento dottrinale, di istituto avente forma e sostanza locatizie. Altra figura teorizzata dalla dottrina si inquadra nel leasing al consumo. Il contratto è stipulato da persona fisica “che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, sicché il contratto è, altresì, sottoposto alla disciplina di cui al Capo II del Titolo VI, dedicata al credito al consumo (art. 121 T.U. bancario). L’utilizzatore può, pertanto, avvalersi degli strumenti ivi previsti.
Il leasing finanziario è un contratto consensuale: si perfeziona a seguito del solo consenso manifestato dalle parti. La consegna del bene oggetto di leasing dà luogo all’adempimento di un contratto già perfezionatosi, determinando anche il momento a partire dal quale inizia a decorrere il diritto di godimento sul bene da parte dell’utilizzatore.
Il richiamo operato dall’art. 1, comma 2, T.U. bancario al contratto di leasing finanziario comporta la soggezione dell’attività di intermediazione alla disciplina ivi prevista. In specie, l’art. 106 e ss. prescrive che lo svolgimento delle attività del concedente siano riservate a determinate categorie di soggetti, ossia istituti creditizi, intermediari finanziari e, più in generale, a coloro i quali siano iscritti nell’elenco della normativa (gli elenchi di riferimento si distinguono in: elenco generale, di cui art. 106 T.U., se l’attività finanziaria è esercitata nei confronti del pubblico; l’elenco speciale di cui art. 107 T.U. che ricomprende le società finanziarie di maggiori dimensioni; la sezione speciale dell’elenco generale di cui art. 113 T.U., che include i soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico). Al contrario, la legge nulla stabilisce in merito alle caratteristiche dell’utilizzatore, pertanto si presume che possa trattarsi anche di persona fisica.
Ha effetti eventualmente reali: dal contratto in esame emergono, in primis, effetti obbligatori in capo ad ambo le parti, dal momento che l’utilizzatore si obbliga a corrispondere i canoni periodici dietro l’obbligo del concedente di fornirgli il bene e di consentirgli il diritto di godimento su quest’ultimo.
Può, però, ravvisarsi anche un effetto traslativo, secondo lo schema elaborato per la prima volta dalla Suprema Corte di Cassazione 1987, che opera diversamente, a seconda che si verta nel leasing finanziario o in quello operativo.
Nel primo, l’effetto traslativo è immediato con riguardo al concedente, che acquista il bene, scelto dall’utilizzatore, da dare in leasing, mentre con riguardo all’utilizzatore è subordinato all’esercizio dell’opzione di acquisto, al termine del contratto. Nel leasing operativo, invece, l’effetto traslativo si verifica in capo all’utilizzatore, sempre che egli, alla scadenza del contratto, decida di acquistare il bene.
Dal leasing derivano obbligazioni a carico di entrambe le parti, il concedente e l’utilizzatore: a seguito della stipulazione del leasing su entrambe le parti gravano prestazioni reciproche. Il concedente si impegna a consegnare il bene e a consentire all’utilizzatore di goderlo, mentre quest’ultimo si obbliga a corrispondere i canoni di leasing, come pattuito nel contratto.
È’ un contratto a titolo oneroso: il diritto di godimento sul bene oggetto di leasing viene concesso dietro pagamento di un corrispettivo, il cui ammontare viene pattuito nel contratto con cadenze periodiche; è commutativo, essendo le prestazioni delle parti predeterminate al momento della conclusione del contratto.
Dà vita a un rapporto di durata: il contratto di leasing è necessariamente destinato a durare per un certo lasso di tempo, stabilito dalle parti, in cui l’utilizzatore si vede riconoscere il pieno godimento del bene oggetto del leasing.
Nell’ambito del leasing finanziario, prima della novella del 2017, di cui si riferirà infra, si era soliti distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo, in base allo scopo pratico che le parti mirano a realizzare. Il leasing “tradizionale” (o leasing di godimento) si caratterizza per il fatto che ha ad oggetto un bene che esaurisce le utilità economiche di cui è capace entro un dato periodo di tempo, normalmente coincidente con la durata del contratto.
In questa ipotesi lo scopo dell’utilizzatore non è tanto quello di acquistare la proprietà del bene, quanto di assicurarsene il godimento per tutto il periodo in cui il bene stesso è idoneo ad apportare le sue utilità economiche. Nel leasing traslativo, invece, la res è destinata a conservare un valore residuo apprezzabile per l’utilizzatore alla scadenza del contratto. In tal caso, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non trovano la loro ragion d’essere solo nel godimento del bene, ma costituiscono anche il corrispettivo di una parte di prezzo.
Tale distinzione non era priva di rilevanza pratica: il precipitato consiste nell’applicabilità di una diversa disciplina. La dottrina, dunque, si è interrogata circa il rimedio esperibile nell’ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore della propria prestazione, consistente, come già evidenziato, nel pagamento dei canoni periodici di godimento.
A ben vedere, i formulari predisposti ricorrono al rimedio della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, azionabile anche a seguito del mancato pagamento di un solo canone, con conseguente diritto del lessor a richiedere la restituzione del bene, a trattenere i canoni fino a quel momento percepiti, nonché a vedersi corrispondere una penale precedentemente pattuita. La dottrina si è interrogata circa la fondatezza di tale soluzione, posto il sacrificio contrattuale che impone all’utilizzatore. Le perplessità esposte sono state raccolte dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale si è fatta portavoce di due opposti orientamenti.
Secondo un primo orientamento, la causa contrattuale si indirizzerebbe non già all’acquisto del bene, quanto piuttosto al finanziamento volto ad ottenere la sua immediata disponibilità. La finalità di godimento si evincerebbe, secondo tale ricostruzione, dalla consumabilità del bene in un breve lasso di tempo, sicché il corrispettivo periodico del canone si comporrebbe dei rimborsi rateali delle somme anticipate dal finanziatore, maggiorato dagli interessi e della remunerazione del capitale per il rischio dell’operazione. Posta la meritevolezza degli interessi perseguiti, la riconosciuta atipicità contrattuale consente l’applicazione dell’art. 1323 c.c., che dispone l’estensione dei principi in materia contrattuale del Codice civile alle rappresentazioni atipiche. Ne discenderebbe, di conseguenza, l’applicabilità della normativa della risoluzione dei contratti di durata ex art 1458 c.c., con conseguente esclusione dell’obbligo, per il concedente, di restituire i canoni percetti.
[…]
*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto civile – parte speciale” di F. Caringella, D. Dimatteo – Dike giuridica editrice – Settembre 2025