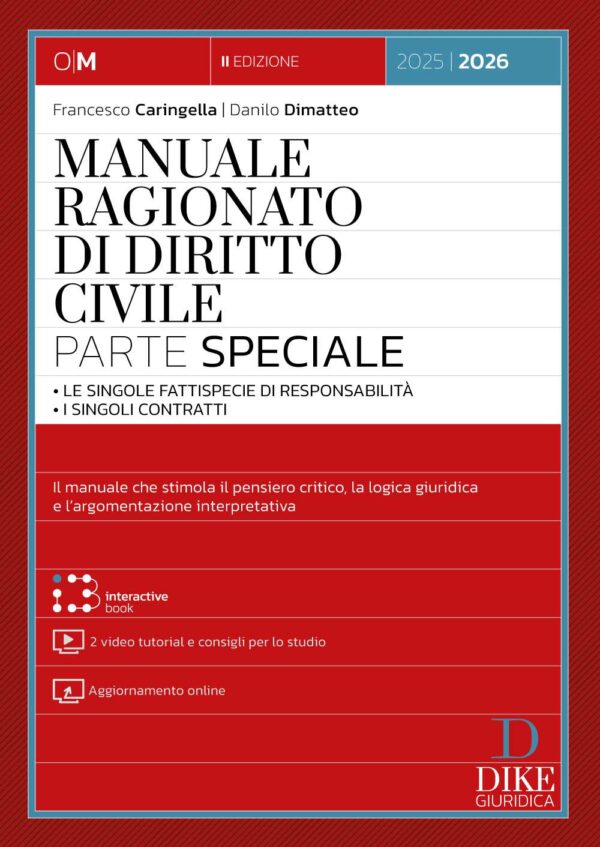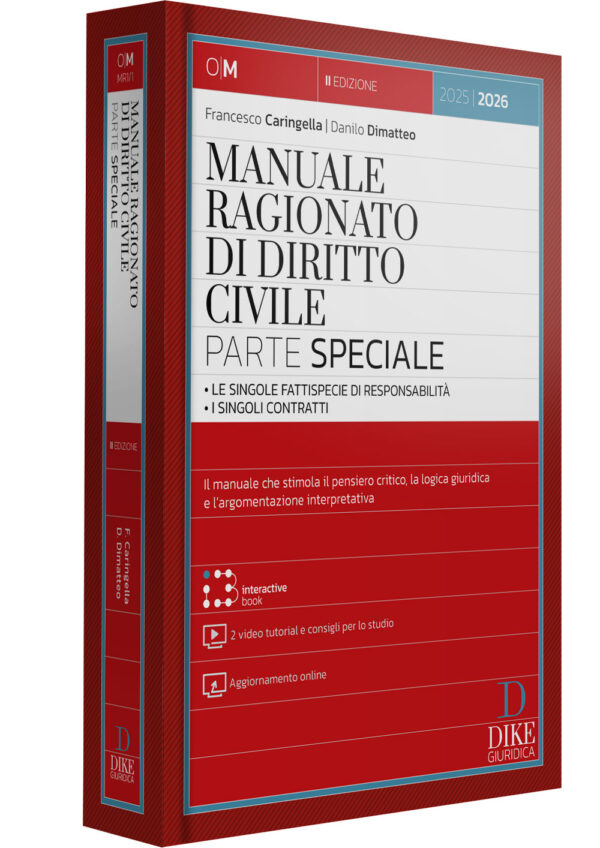Il contratto di factoring costituisce l’operazione negoziale attraverso la quale un imprenditore, nelle vesti di cedente-fornitore, cede i crediti che derivano, o che deriveranno, dalla sua attività d’impresa, ad altro imprenditore, c.d. factor, il quale, dietro corrispettivo, si impegna al compimento di prestazioni gestorie e, eventualmente, di garanzia, del credito ceduto.
Si tratta, a bene vedere, di un contratto consensuale, a titolo oneroso, i cui effetti si modulano a seconda che l’oggetto della cessione sia costituito da un credito attuale, ovvero futuro: nella prima ipotesi la cessione del credito produce effetti traslativi immediati nella sfera giudica del cessionario, sì da costituire un contratto ad effetti reali; nella seconda, invece, la convenzione di factoring origina effetti esclusivamente obbligatori, a ragione dell’impossibilità di cedere un credito non ancora sorto.
Le parti del contratto di factoring, infine, devono rivestire delle qualifiche particolari, in quanto il factor deve essere una banca o un intermediario finanziario, mentre il cedente deve necessariamente essere un imprenditore.
Il negozio in esame, di derivazione anglosassone, soggiace alla disciplina della L. 52/1991. Ciononostante, è opinione pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, la persistenza della parziale atipicità del contratto di factoring: per tale ragione, si registra l’esistenza di contrasti circa aspetti di taluni elementi, sia essenziali che accessori, del contratto.
Il contratto di factoring prevede uno schema di perfezionamento progressivo tale per cui, alla stipulazione della convenzione di factoring, quale accordo base, seguono singole cessioni di crediti. La dottrina si è interrogata circa la natura del perfezionamento del contratto. Secondo una prima ricostruzione, la serie progressiva di cessioni imporrebbe di sostenere il carattere plurale dei negozi e, dunque, la loro rispettiva autonomia. Nell’ambito dei fautori della tesi pluralista, occorre distinguere tra: coloro che sostengono che l’obbligo del fornitore di cedere i propri crediti al factor formi un pactum de contrahendo, nei confronti del quale le singole operazioni di cessione si atteggerebbero a meri negozi di attuazione, la cui causa esterna si incardinerebbe nella convenzione di factoring; coloro che, invece, inquadrano il suddetto obbligo nell’alveo di un contratto preliminare; coloro che, infine, ricorrono, contestualmente, alle figure dell’accordo normativo e del preliminare.
All’opposto, altra parte della dottrina ha sostenuto l’unitarietà dell’operazione di cessione, traendone la conseguenza per cui il factoring costituisce un contratto definitivo da cui origina l’effetto traslativo dei crediti di impresa, mentre le singole cessioni, lungi dal rappresentare autonomi negozi, integrerebbero meri atti esecutivi degli obblighi dettati dalla convenzione iniziale.
Proseguendo sul fronte delle modalità di stipulazione, occorre evidenziare che le parti concludono il contratto attraverso la sottoscrizione di moduli generali. Questi ultimi appaiono strumenti di peculiare importanza, in forza dei quali il factor ha il potere di compiere una previa valutazione della solvibilità dei debitori dei crediti ceduti: il cessionario ha, infatti, ricorrendo ai moduli succitati, accesso all’elenco dei clienti dell’imprenditore cedente, sì da poter selezionare i crediti che intende accettare in cessione. Il cedente si vincola, a sua volta, a non modificare i termini contrattuali inseriti nei moduli, nonché a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti delle condizioni economiche dei debitori.
La valutazione della solvibilità dei debitori dei crediti ceduti, da parte del cessionario, appare di rilevanza ancor più dirimente, alla luce del contenuto dei servizi che il factor offre in controprestazione al cedente, dietro corrispettivo. Posto che, infatti, il factoring è un contratto a prestazioni corrispettive, il cessionario è tenuto all’erogazione, in primo luogo, dei servizi gestionali. Questi ultimi ricomprendono le operazioni di contabilizzazione dei crediti, attraverso cui il factor si occupa della contabilità dei crediti del proprio cliente, oltre che della presentazione a quest’ultimo di un prospetto analitico, o sintetico, che tenga informato il cedente dell’andamento dei propri affari.
Inoltre, il cessionario adempie ad una funzione di incasso e recupero dei crediti, con ciò intendendo la loro riscossione, nonché sollecito al pagamento dei crediti non adempiuti spontaneamente dai debitori.
In second’ordine, il factor svolge una funzione, lato sensu, assicurativa, ciò in quanto il contratto di factoring produce, quale effetto naturale, in capo al cessionario, l’assunzione del rischio dell’insolvenza del credito ceduto: a differenza di quanto avviene nella cessione del credito ordinaria, disciplinata dall’art. 1267 c.c., secondo cui il trasferimento del credito vincola il cedente alla garanzia della sola esistenza del credito, non anche al suo effettivo adempimento, salvo diversa pattuizione, la configurazione della cessione pro soluto costituisce effetto normale nel contratto di factoring, ex art. 4, L. 52/1991. Infine, il cessionario può predisporre l’erogazione di servizi finanziari, attraverso cui persegue la funzione di anticipare all’impresa, in tutto o in parte, l’importo dei crediti acquistati.
L’erogazione dei servizi del cessionario delinea la controprestazione al pagamento effettuato dal cedente. L’art. 1 della L. 52/1991 ricorre, in specie, al termine “corrispettivo”. Parte della dottrina ne ha tratto una lettura schiettamente economica, sovrapponendo il concetto di “corrispettivo” con quello di prezzo. Accogliendo tale ricostruzione restrittiva, la cessione dovrebbe intendersi quale operazione vendendi causa. Al contrario, altra parte della dottrina sostiene che il termine “corrispettivo” risulti espressione del più generico principio di onerosità, sicché la cessione risulta suscettibile di ricomprendere un più ampio genere di operazioni (solvendi causa, cavendi causa). Ciò che appare, invece, evidente, è costituito dall’esclusione dei trasferimenti a titolo gratuito dall’ambito di applicazione della legge.
1.1 Figure a confronto: contratti di credito, assicurazione del credito, sconto, contratto di mandato
La difficoltà riconnessa all’individuazione della causa del contratto di cui di tratta ha determinato lo spiegarsi di una serie di accostamenti a figure analoghe. In specie, alcuni autori riconducono il factoring alla categoria dei contratti di credito, identificando nel godimento di somme di denaro, attraverso il sistema delle cosiddette anticipazioni, quale effetto primario del contratto. Altri autori hanno tentato di accostare la fattispecie in esame all’assicurazione del credito, riferendosi, cioè, al contratto mediante il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato della potenziale perdita, totale o parziale, del valore del credito, discendente dal definitivo inadempimento del debitore.
Tali ricostruzioni, ad ogni modo, soggiacciono ad una serie di appunti critici: in primo luogo, si è osservato che i contratti di factoring, pur se caratterizzati dall’effetto di garanzia del credito ceduto, che sorge in capo al cessionario, non esclude, per ciò solo, l’apposizione di una clausola pro solvendo, potendo, dunque, la cessione dei crediti avvenire sia senza che con rivalsa.
In ogni caso, anche limitandosi a considerare l’effetto normale di cessione pro soluto, si determinerebbe comunque un contrasto con la causa propria del contratto di assicurazione, costituita dal trasferimento dell’alea economica; diversamente, infatti, il factoring si incardina sul trasferimento della titolarità di uno o più crediti verso corrispettivo e prevede normalmente la prestazione di servizi ulteriori. La garanzia predisposta dall’art. 1916 c.c., in altri termini, non contempla il trasferimento della proprietà del credito.
Altro orientamento dottrinale ha sostenuto la sovrapponibilità con la fattispecie dello sconto, il contratto con il quale la banca anticipa al cliente l’importo di un credito non ancora scaduto a fronte della cessione del credito stesso. Tuttavia, l’anticipazione ha carattere essenziale soltanto nel contratto di sconto, e non anche nel contratto di factoring, del quale costituisce solo un effetto normale, ma non necessario. Altri autori hanno qualificato il factoring alla stregua di un contratto di mandato, facendo leva sull’esistenza delle singole cessioni.
Tale inquadramento, ad ogni modo, è contraddetto dall’espressa incompatibilità tra le figure in parola, come si evidenzia dai formulari che, nel prevedere il rilascio al factor di un mandato all’incasso, escludono espressamente la cessione del credito. Inoltre, a differenza di quanto avviene abitualmente nel factoring, il mandante conserva la possibilità di ricevere il pagamento in luogo del mandatario all’incasso, di talché il debitore che paga al primo è liberato.
[…]
*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto civile – parte speciale” di F. Caringella, D. Dimatteo – Dike giuridica editrice – Settembre 2025