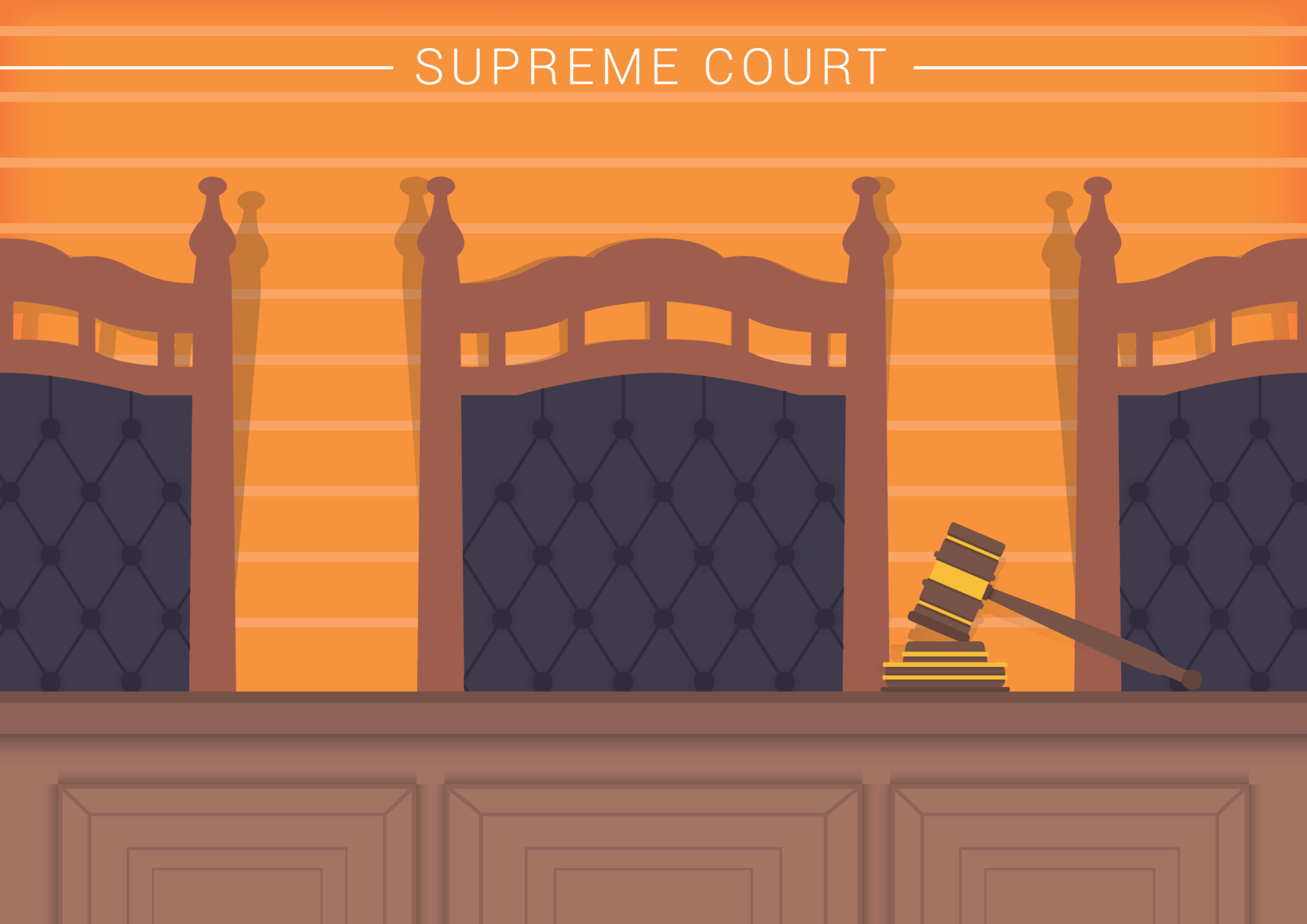Gli oneri reali sono prestazioni positive a carattere periodico dovute da un soggetto in quanto proprietario di un determinato bene immobile. Tali prestazioni positive consistono nel dare o fare qualche cosa a favore di un altro soggetto (es. canone enfiteutico, tributo fondiario ecc.), il quale, peraltro, non solo è titolare del diritto a riceverle, ma anche della facoltà di esproprio del fondo gravato dall’onere, potendo cioè soddisfarsi in via esecutiva sul bene in caso di inadempimento.
Il diritto romano non conosceva la figura degli oneri reali, né quella delle obbligazioni propter rem; gli unici casi di oneri reali segnalati nelle fonti sono riconducibili a rapporti pubblicistici di tributi o di canoni dovuti ad enti pubblici.
L’idea di vincoli obbligatori gravanti sui successivi proprietari dell’immobile era contraria alla concezione dei giuristi romani, come peraltro evidenziato dalla regola che escludeva le prestazioni positive dal contenuto delle servitù.
L’istituto dell’onere reale costituisce piuttosto una figura di origine medioevale, derivando da un’antica consuetudine delle popolazioni germaniche; esso si sarebbe infatti prestato a tradurre in forme giuridiche private il sistema feudale della pluralità di signorie concorrenti sulla proprietà immobiliare.
Caratteristiche dell’onere reale sono l’inerenza ad un fondo (c.d. qualitas fundi) e la sua insorgenza automatica per effetto della previsione legale una volta acquisita la titolarità del diritto reale.
Ciononostante, l’istituto in questione si distingue dal rapporto di servitù. In primo luogo, l’onere implica un dovere periodico, mentre le servitù implicano un peso continuativo; inoltre, nell’onere il contenuto in genere consiste in una prestazione personale (dare o fare), mentre nelle servitù il contenuto consiste in un pati o in un non facere; in ultimo, mentre l’onere può costituirsi anche a vantaggio di persone determinate, la servitù si costituisce soltanto a vantaggio di un fondo.
Del resto, nell’attuale sistema è la stessa configurabilità di oneri reali ad essere oggetto di discussione. Ed invero, se da un lato è diffusa l’opinione secondo la quale a tale figura sarebbe riconosciuto un ampio spazio nell’ambito della cornice codicistica (ad essa potrebbero essere ricondotte le fattispecie di cui agli artt. 860, 864, 850, 868, 920, 921 e 960 e ss. c.c., nonché il privilegio speciale sugli immobili e persino la rendita vitalizia garantita da ipoteca) d’altra parte autorevole dottrina ne afferma addirittura la scomparsa nell’odierna legislazione, specificando che le figure tradizionalmente qualificate come oneri reali altro non sarebbero che ipotesi di servitù prediali ovvero, qualora abbiano ad oggetto una prestazione di fare, semplici obbligazioni.
Non mancano tuttavia quanti, in posizione intermedia, sostengono la rilevanza meramente residuale nel nostro ordinamento della categoria in esame e ritengono che essa, costituendo solo il portato di passati riconoscimenti spesso derivanti dal dominio temporale della Chiesa e legati al problema delle rendite ecclesiastiche, si risolva in antichi rapporti non ancora aboliti né affrancati (in quest’ottica, le uniche figure giuridiche riconducibili entro il genus degli oneri reali sarebbero i contributi consortili).
Controversa è, parimenti, la natura giuridica degli oneri in parola, dal momento che gli stessi presentano una commistione di elementi di ordine al contempo reale e personale. Diverse le elaborazioni dottrinali.
Da un lato, la dottrina tradizionale riconduce la figura in questione alla categoria dei diritti reali, valorizzando l’elemento dell’inerenza del diritto alla cosa, che consente il soddisfacimento dell’interesse del titolare, stante l’automatico trasferimento del peso in capo all’acquirente del fondo; di qui l’opponibilità dello stesso erga omnes, proprio come avviene per i diritti reali.
D’altro canto, non manca chi ricostruisce la figura degli oneri reali come diritti di credito assistiti da una garanzia reale. In quest’ottica, da una parte si sottolineano le peculiari differenze rispetto alle servitù (di cui più sopra si diceva), dall’altra si evidenzia la mancanza di un potere immediato del titolare sulla res, laddove l’immediatezza connota invece il contenuto dei diritti reali.
Si aggiunge, ancora, l’impossibilità di accostare l’onere reale alla figura dell’ipoteca: se è vero, infatti, che in entrambi gli istituti il creditore gode di una posizione privilegiata in sede di distribuzione del ricavato della vendita forzata del bene, è altrettanto vero che mentre l’ipoteca è un diritto accessorio al credito garantito ed avente fonte in un titolo autonomo, nell’onere reale la prelazione sul bene ne connota il contenuto, pur in assenza di un titolo distinto.
Peraltro, è qui da avvertire come la questione relativa alla natura giuridica dell’onere reale non abbia un rilievo meramente teorico.
In primo luogo, essa è strettamente legata ad altra questione, altrettanto controversa e dibattuta, e cioè quella inerente l’ambito operativo dell’autonomia negoziale dei privati in materia: non sfugge all’attenzione come affermare la realità dell’istituto in esame significherebbe affermarne la tipicità, in omaggio al principio del numero chiuso dei diritti reali. Al contrario, riconoscerne la natura obbligatoria comporterebbe l’inoperatività di tale principio.
Autorevole dottrina, pur escludendone il carattere reale, ritiene in proposito che il principio di relatività del contratto, sancito dall’art. 1372 c.c., precluda comunque all’autonomia privata di prevedere nuove ipotesi di oneri reali. In secondo luogo, diversi sono i rimedi esperibili nel caso di lesione di un diritto reale o di inadempimento di una obbligazione: nel primo caso, fatto salvo il rimedio di cui all’art. 2043 c.c., è possibile esercitare erga omnes un’azione reale; nel secondo, è invece possibile far valere soltanto la responsabilità contrattuale del debitore ex art. 1218 c.c.
products skus=”9788858217092″ orderby=”date” order=”DISC”
*Contributo estratto da “Manuale di diritto civile” di F. Caringella, L. Buffoni – Dike giuridica editrice – Gennaio 2025