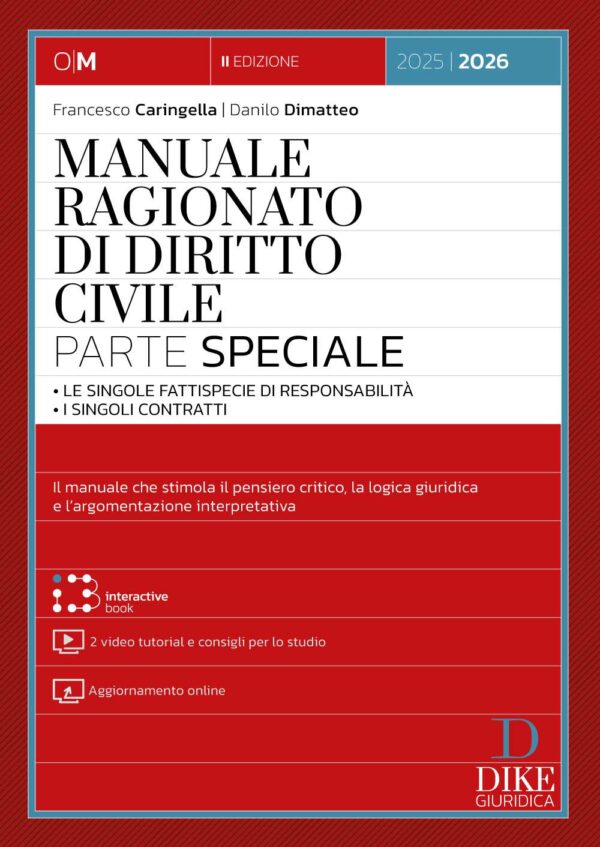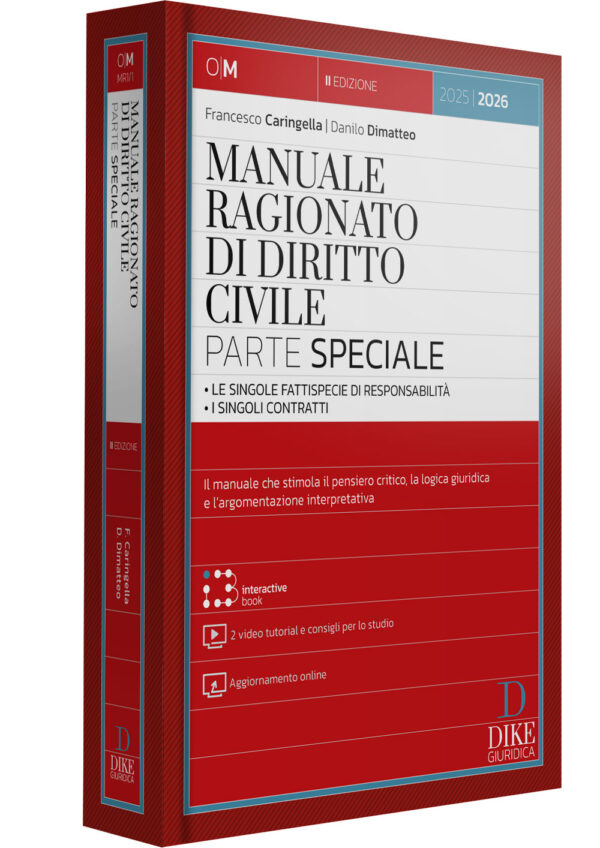Il contratto estimatorio è definito dall’art. 1556 c.c. come quel negozio in base al quale una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo, a meno che non preferisca restituirle nel termine stabilito.
Attraverso il modello contrattuale in esame, il tradens, che è in genere un produttore o un grossista, si avvale dell’organizzazione di altri imprenditori per far conoscere e vendere i suoi prodotti a un pubblico più vasto di quello che egli, con i suoi mezzi organizzativi soltanto, non potrebbe raggiungere.
In particolare, egli stabilisce il prezzo, l’aestimatio (da cui deriva il termine contratto estimatorio), e rinuncia alla vendita diretta eseguita dall’accipiens, assumendosi, però, il rischio della cosa invenduta. Dal suo canto l’accipiens potrà disporre della merce più varia ed evitare di pagare subito beni che potrebbe anche non vendere, non conoscendo a priori le capacità di assorbimento del mercato.
Il contratto estimatorio è noto nella prassi anche con i nomi di “pagamento a merce rivenduta”, “conto deposito” o “in sospeso” e viene largamente praticato in importanti settori commerciali caratterizzati da rapida obsolescenza e, per i quali, pertanto, il rischio dell’invenduto si pone in termini di maggiore criticità (beni di serie e numerosi, quali libri, dischi e giornali, o per gli articoli di moda, ma anche in ragione dell’elevato costo della merce posta sul mercato, come oggetti di oreficeria e preziosi).
3.1 Il momento traslativo della proprietà
Il tema centrale che si pone nell’esaminare il contratto estimatorio è quello di stabilire il momento traslativo della proprietà delle cose consegnate e, a tal proposito, ci si chiede se ciò avvenga all’atto della conclusione del contratto o successivamente.
Una parte della dottrina configura il contratto in esame come una compravendita, sia pure con due particolarità. Il negozio avrebbe carattere reale, perfezionandosi con la dazione della cosa, e si connoterebbe per l’attribuzione all’accipiens della facoltà di far venir meno gli effetti del contratto con la restituzione, da esercitare con un negozio unilaterale recettizio a carattere reale.
A sostegno della tesi si adduce, innanzitutto, la mancanza nel tradens della tipica azione a difesa della proprietà, ossia la rivendica, in quanto solo l’accipiens ha l’esclusività del potere dispositivo ex art. 1588, comma 2 c.c. Inoltre, si richiama l’art. 1557 c.c. che pone il fortuito a carico dell’accipiens, così qualificandolo proprietario in forza del principio res perit domino (Balbi, Cottino).
Al contrario la dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità sostengono che al momento della conclusione del contratto venga attribuito all’accipiens solo un potere di disposizione sulle cose consegnate, mentre la proprietà permanga in capo al tradens fino a quando l’accipiens non le abbia vendute o trattenute presso di sé, rimanendo obbligato, così, a pagarne il prezzo (Lordi, Dalmartello, Menti). Vi sono, invero, precisi e concordanti elementi testuali che dimostrano che il contratto estimatorio non sia una vendita, mancando l’efficacia traslativa immediata.
Innanzitutto, il raffronto tra l’art. 1556 c.c. “con il contratto estimatorio una parte consegna” e l’art. 1548 c.c. “il riporto è il contratto con il quale una parte trasferisce in proprietà” evidenzia che l’accipiens non acquista la proprietà dei beni consegnati e che il tradens non trasferisce tale diritto. Inoltre, il comma 1 dell’art. 1558 c.c. prevede non solo che l’accipiens abbia il potere dispositivo, ma anche che i suoi creditori non possano sottoporre le cose a pignoramento e a sequestro finché non ne sia pagato il prezzo, segno che egli non è ancora titolare del bene. Difetta, peraltro, una disposizione che, conformemente a quanto previsto per gli altri contratti reali traslativi, stabilisca espressamente il trasferimento della proprietà all’accipiens.
Alla critica mossa da una parte della dottrina, che denuncia che il diritto di proprietà del tradens venga fortemente limitato, la posizione prevalente replica osservando che tale situazione reale non venga completamente cancellata e che al tradens non spetti l’azione di rivendica solo nei confronti dell’accipiens, che è legittimato a disporre e possedere la res in base al contratto, potendo agire anche avverso coloro che detengano le cose oggetto dell’estimatorio illegittimamente.
Peraltro, la tesi prevalente osserva che la scelta di far grave il fortuito sull’accipiens ex art. 1557 c.c. sia un’eccezione alla regola res perit domino, giustificata dal fatto che la sfera di controllo e di disponibilità delle cose consegnate spetta, dopo la conclusione del contratto, non al tradens, ma all’accipiens.
Infine, si rileva come l’effetto traslativo si produca sempre a favore dell’accipiens. Ciò non solo quando egli utilizzi le cose o le trattenga presso di sé, non restituendole nel termine stabilito, ma anche nell’ipotesi ordinaria in cui i beni vengano venduti a terzi. In tal caso opera, infatti, un meccanismo analogo a quello della vendita di cosa altrui ex art. 1478, comma 2 c.c.: egli diviene proprietario, sia pure per un solo istante, al momento dell’alienazione.
Strettamente correlata alla soluzione esposta è la questione relativa alla definizione della natura giuridica del potere di disposizione di cui gode l’accipiens.
Secondo la posizione preferibile si tratta di un diritto reale su cosa altrui, del quale presenta i caratteri qualificanti di immediatezza, assolutezza e inerenza. (De Martini, Giannattasio, Visalli, D’Amato). Infatti, l’accipiens soddisfa il proprio interesse mediante l’esercizio di una signoria diretta sul bene, senza bisogno della cooperazione di altri soggetti. Inoltre, il potere dell’accipiens esclude ogni diritto eguale e concorrente sulle cose consegnate e la generalità dei consociati è gravata dal dovere di astenersi dall’impedire od ostacolare in qualsiasi modo il potere stesso.
L’inerenza è comprovata poi dal fatto che l’accipiens possa senza dubbio continuare l’esercizio del suo potere anche nel caso in cui il tradens abbia alienato a terzi la proprietà dei beni dedotti nel negozio. Infine, si osserva come la tesi in esame non contrasti con il principio del numerus clausus dei diritti reali perché tale posizione reale rinviene un’esplicita base normativa proprio all’art. 1558 c.c.
*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto civile – parte speciale” di F. Caringella, D. Dimatteo – Dike giuridica editrice – Settembre 2025