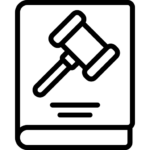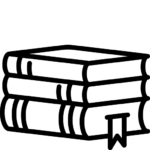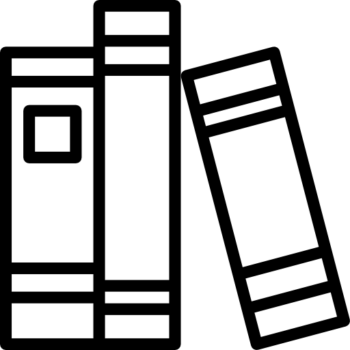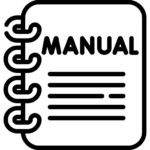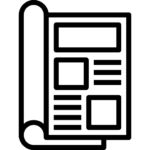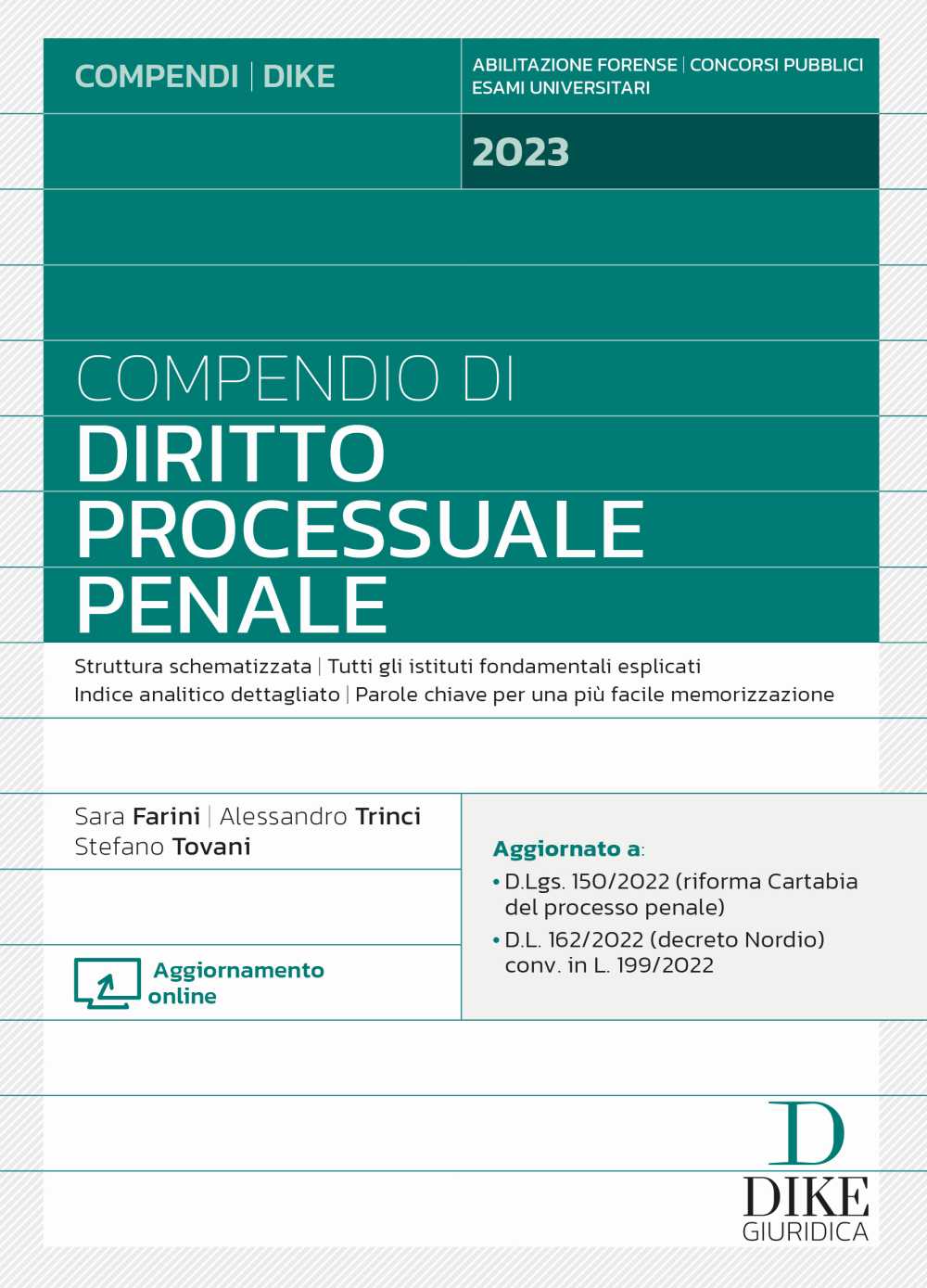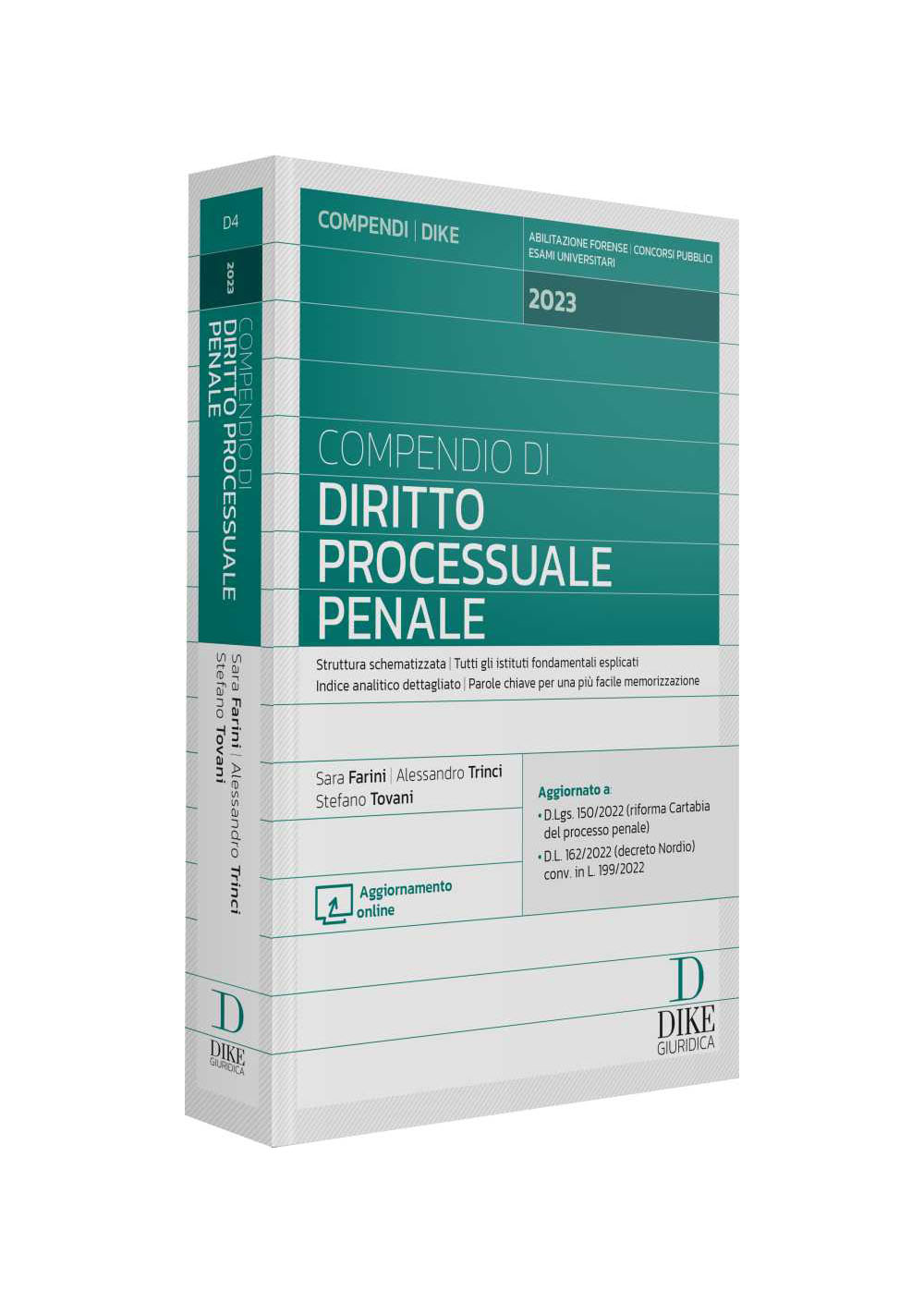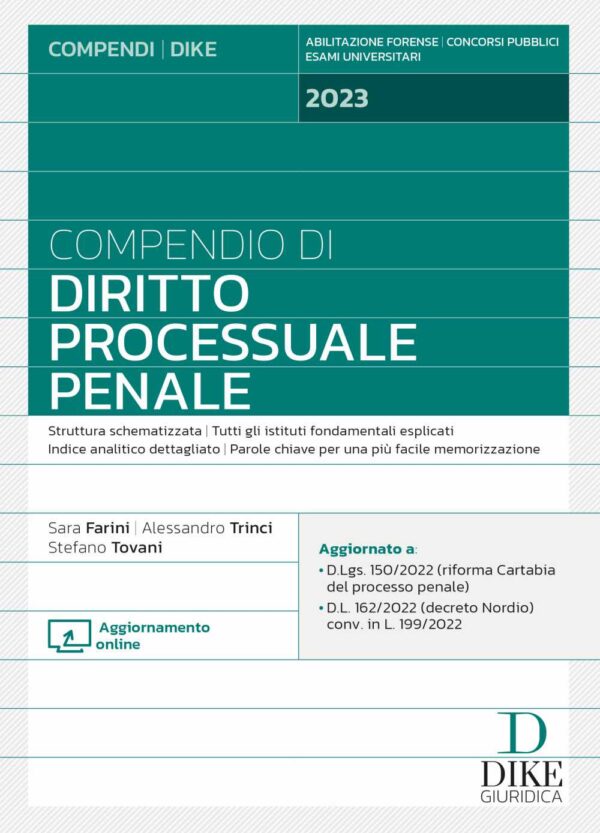Compendio di Diritto Processuale Penale 2023: Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel dare attuazione alle deleghe contenute nella L. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), ha operato la più vasta e sistematica riforma del processo penale (oltre a significativi interventi sul codice penale) dall’entrata in vigore, nel 1989, del “nuovo” codice di rito. La vastità della novella si coglie non soltanto nel numero di articoli modificati, abrogati o introdotti (oltre duecento), ma anche, e soprattutto, nello spirito delle innovazioni (si pensi, solo per fare degli esempi, alla digitalizzazione del procedimento, al nuovo giudizio in assenza, al controllo sulle iscrizioni nel registro degli indagati e ai rimedi contro l’inerzia del pubblico ministero, alla nuova regola di accesso al dibattimento non più informata al favor actionis, alla sostituzione delle pene principali, affidata al giudice del merito con un innovativo sistema bifasico e all’introduzione della giustizia riparativa). L’intento che anima l’ambizioso progetto è quello di imprimere efficienza ad una giustizia penale ormai cronicamente incapace di dare adeguate risposte ai protagonisti del processo e alla collettività in tempi ragionevoli.
L’ampiezza e la capillarità degli interventi normativi ha reso necessaria una sostanziale riscrittura del volume, la cui lunghezza è lievitata, sia pure in modo contenuto, anche per dare spazio a raffronti con la vecchia disciplina che consentano al lettore di cogliere ratio, scopo e funzionamento di ciascuna modifica.
Il testo dà conto anche dell’articolata disciplina transitoria che regola l’entrata in vigore novella, come modificata dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto Nordio), convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Oltre alla rivoluzione copernicana attuata dalla riforma Catabia, nell’ultimo anno non sono mancati interventi giurisprudenziali che hanno inciso in modo significativo sulla disciplina del processo penale. Fra questi, meritano una segnalazione le seguenti pronunce della Corte costituzionale: la sent. 10 novembre 2022, n. 243, con la quale la Consulta si è pronunciata sui rapporti fra termine a difesa e accesso ai riti premiali nel giudizio direttissimo; la sent. 23 giugno 2022, n. 174, con la quale la Consulta si è pronunciata sulla possibilità di concedere una seconda volta la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sent. 16 giugno 2022, n. 149, con la quale la Consulta si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 649 c.p., con specifico riferimento al doppio binario sanzionatorio previsto dalla disciplina sul diritto d’autore; la sent. 25 maggio 2022, n. 173, con la quale la Consulta si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 538 c.p.p. con specifico riferimento ai rapporti fra sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, la sent. 5 maggio 2022, n. 111, con la quale la Consulta si è pronunciata sull’interesse a impugnare la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Volgendo uno sguardo alla giustizia ordinaria, deve segnalarsi, fra le altre, la sent. 27 ottobre 2022 con la quale le Sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla legittimazione del procuratore generale ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova.
Presentazione della collana
Il compendio di Diritto Processuale Penale è uno strumento operativo indispensabile per coloro che si preparano all’esame di avvocato, per gli studenti universitari, per i candidati ai concorsi pubblici.
I testi della collana Compendi e quindi anche il Compendio di Diritto Processuale Penale 2023:
• offrono un’esposizione sistematica, in forma chiara e sintetica, di tutti gli istituti
• presentano una trattazione completa, attenta a tutti gli argomenti sensibili per le prove d’esame
• permettono una rapida memorizzazione attraverso mirate tecniche di paragrafazione e l’evidenziazione in grassetto dei concetti-chiave
• propongono un percorso lineare, completo e approfondito
• analizzano la materia in modo semplice ed esaustivo
• sono sempre aggiornati all’ultimo dato normativo
• espongono i principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza
• sono dotati di un utilissimo indice analitico che consente una rapida individuazione delle tematiche di studio
Tutti i Compendi aggiornati Dike