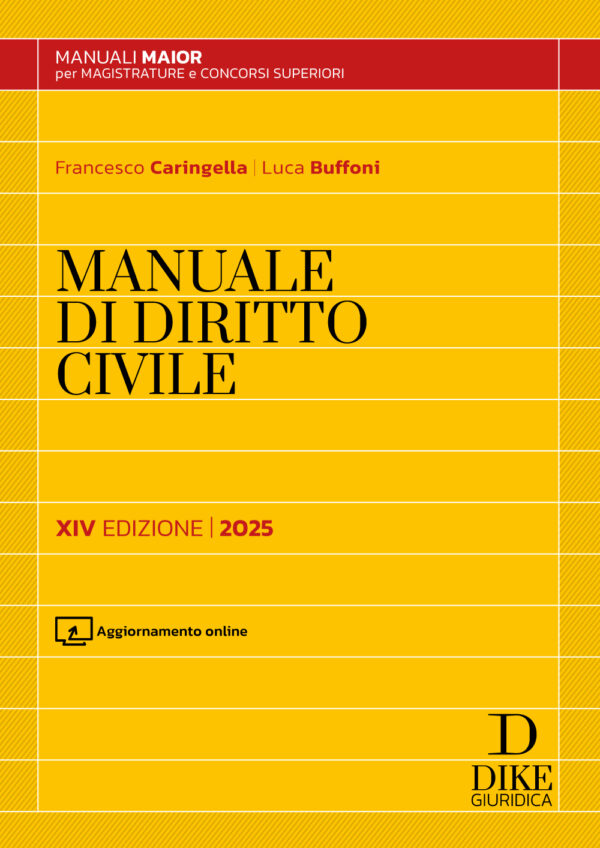Il Manuale di Diritto Civile Maior 2025 propone un filo conduttore sistematico coniugando le nozioni istituzionali con le novità normative e giurisprudenziali e analizza i principali arresti giurisprudenziali dell’ultimo anno, tra i quali si segnalano le pronunce a Sezioni Unite in tema di cogenitorialità in caso di maternità surrogata. Francesco Caringella presenta la nuova edizione del suo celebre manuale, scritto in collaborazione con Luca Buffoni. Un’opera aggiornata e completa, pensata per rappresentare un punto di riferimento imprescindibile nel panorama giuridico. Grazie a un approccio sistematico e innovativo, il Manuale Maior unisce solide basi teoriche alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, offrendo uno strumento di studio chiaro, approfondito e sempre aggiornato.
Il Manuale, pensato per la preparazione dei concorsi nelle magistrature e nelle alte fasce dirigenziali e delle forze dell’ordine, tiene conto di tutte le pronunce a Sezioni Unite dell’ultimo anno, attraverso un’esposizione chiara e fluida che guida il lettore attraverso le principali tematiche del diritto civile, con un’analisi critica delle novità in continua evoluzione.
Il Manuale di Diritto Civile Maior è aggiornato alle più recenti novità normative, tra cui:
- La Direttiva n. 1799/2024 sul diritto alla riparazione nella vendita dei beni di consumo.
- La Legge 193/2023 sull’oblio oncologico.
- La Legge 169/2024 che criminalizza la maternità surrogata, qualificandola come reato universale.
Contenuti aggiornati fino a dicembre 2024.
Grazie alla sua precisione e completezza, il Manuale Maior si conferma un alleato insostituibile per affrontare con efficacia la prova scritta in magistratura e per aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali.


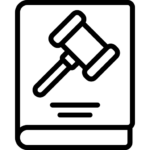
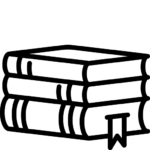
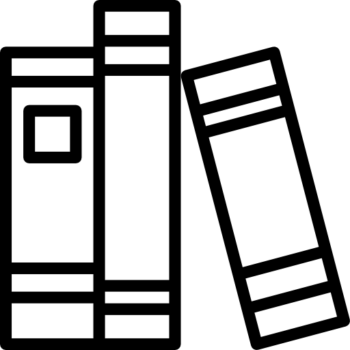
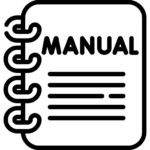
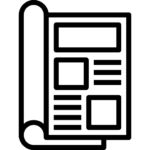
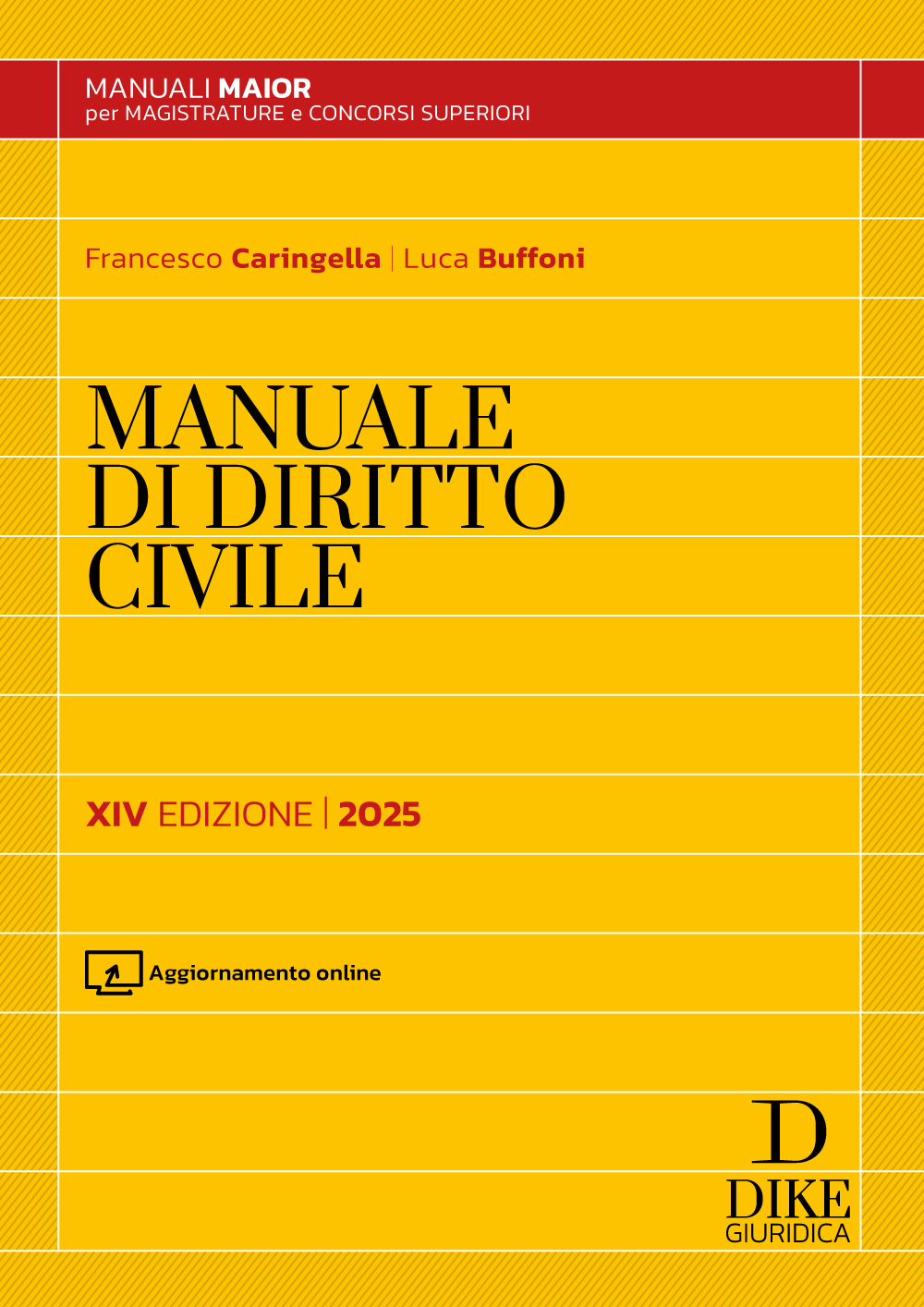
 Scarica Indice in Pdf
Scarica Indice in Pdf