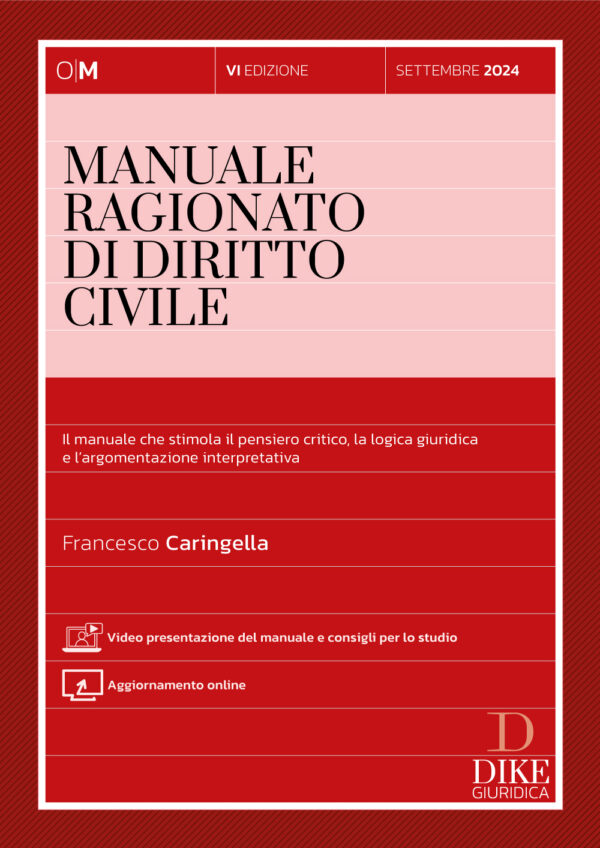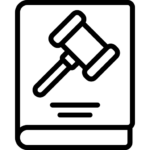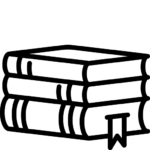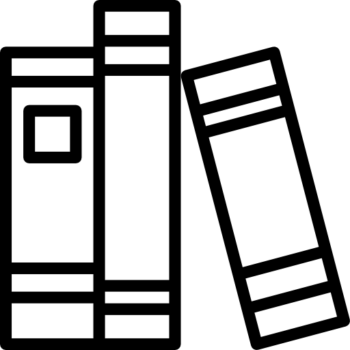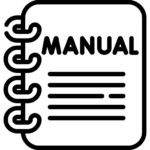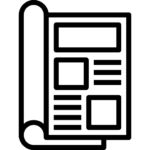Se le applicazioni del principio di buona fede finora evidenziate si caratterizzano “in positivo”, ossia per il fatto di imporre alle parti del rapporto obbligatorio obblighi di comportamento diversi e ulteriori rispetto a quelli negozialmente pattuiti, il fondamento solidaristico di tale principio conferisce allo stesso anche una dimensione “negativa”, quale limite generale alle pretese creditorie e, in generale, all’esercizio dei diritti.
Viene qui in rilievo la figura giuridica del divieto di abuso del diritto, che preclude al titolare di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio di esercitarla per finalità diverse da quelle per cui l’ordinamento l’ha riconosciuta (abuso cd. funzionale o causale) ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all’interesse perseguito con l’esercizio del diritto medesimo (abuso cd. modale).
Il canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui il principio di buona fede oggettiva è espressione, non svolge, in questo caso, una funzione integrativa di nuovi e diversi obblighi di condotta, ma all’opposto una funzione limitativa dell’esercizio di diritti, imponendo di selezionare fra tutti i comportamenti formalmente consentiti perché astrattamente compresi nel contenuto del diritto, quelli che risultino in concreto coerenti con la ratio dello stesso e non arrechino, nelle modalità di esercizio, un pregiudizio sproporzionato alla controparte.
Ne consegue che un diritto (e, più in generale, ogni posizione giuridica soggettiva di vantaggio) non può mai essere esercitato in modo illimitato ma conosce, oltre ai limiti specifici eventualmente previsti dalla legge e dal negozio, un generale limite funzionale e modale, che ne riprova un esercizio scorretto, estraneo allo scopo per il quale l’ordinamento lo riconosce ed inutilmente pregiudizievole.
Il divieto di abuso, pertanto, presuppone il rispetto formale della norma attributiva del diritto, stigmatizzandone, piuttosto, l’utilizzazione alterata e scorretta sul piano sostanziale, in senso funzionale ovvero modale.
7.1 Origine storica e profili comparatistici. Il silenzio del codice civile italiano
Storicamente, il principio del divieto di abuso del diritto nasce dalla elaborazione della giurisprudenza francese, come reazione all’assolutezza dei principi enunciati con la Rivoluzione e propugnati dalla neonata classe borghese. La proclamazione dei diritti e l’affermazione di un principio supremo di libertà fecero ben presto emergere il rischio di un esercizio del tutto incontrollato ed abusivo degli stessi. Ciò si avvertì particolarmente in tema di proprietà, che rappresenta, da sempre, l’archetipo del diritto soggettivo, estrinsecazione di un potere (sulla res) tradizionalmente ritenuto illimitato e sottratto ad ogni controllo da parte degli altri consociati e dello Stato. In quel contesto, si cominciò così, ad affermare che non ogni forma di esercizio del diritto può considerarsi legittima per il solo fatto di essere estrinsecazione del diritto, ma che, al contrario, la tutela dell’ordinamento dovesse essere negata ad atti del proprietario che, pur rientrando nei limiti del diritto, fossero sentiti dalla coscienza sociale come abusivi, perché dettati dalla intenzione di nuocere o comunque non rispondenti ad alcuna meritevole esigenza (Patti).
Sulla scia dell’elaborazione pretoria francese, il divieto di abuso del diritto ha trovato, poi, espressa positivizzazione in molteplici ordinamenti del continente europeo, quali quello svizzero (art. 2 c.c., ai sensi del quale il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge), quello spagnolo (art. 7, comma 2, c.c., ove è previsto l’obbligo di esercizio del diritto conforme alle esigenze della buona fede), quello greco (art. 248 c.c. ove si vieta l’esercizio del diritto quando si eccedano in modo manifesto i limiti imposti dalla buona fede e dal buon costume o le finalità socio-economiche del diritto), quello olandese (art. 13 c.c. che dispone che non si possono compiere atti di esercizio del diritto che si traducano in abuso) e soprattutto quello tedesco che reprime l’abuso del diritto (unzulässige Mißbrauch) al §226 BGB, ai sensi del quale “L’esercizio del diritto è inammissibile se può avere solo lo scopo di provocare danno ad altri”.
Del pari, il divieto di abuso del diritto trova esplicito riconoscimento nell’ordinamento comunitario che lo ha codificato in termini generali all’art. 54 della Carta di Nizza e, in termini più specifici, all’art. 102 TFUE, che, in tema di tutela della concorrenza, vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese della posizione dominante dalle stesse eventualmente rivestita sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a partire dalle note sentenze Halifax e University of Huddersfield (cause C-255/02, C-419/02 e C-223/039) rese in materia tributaria, riconosce il divieto di abuso del diritto come principio generale dell’ordinamento comunitario, affermando che i soggetti di diritto interni agli Stati membri non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle facoltà/libertà riconosciute dal diritto comunitario e dal diritto nazionale che vi dà applicazione, per conseguire scopi evidentemente contrastanti con la ratio della normativa comunitaria stessa.
A differenza di quanto accade nei predetti ordinamenti, nell’ordinamento italiano il divieto di abuso del diritto è un principio inespresso, di creazione essenzialmente dottrinale e pretoria.
Nel codice civile non mancano riferimenti linguistici e concettuali alla nozione di abuso, quali, ad esempio, il divieto di atti emulativi ex art. 833 c.c. (cfr. paragrafo successivo, per l’inidoneità di questa norma a fungere da fondamento normativo esplicito del divieto di abuso del diritto), l’art. 1059, comma 2, c.c. che impone al comproprietario, che agendo individualmente abbia concesso una servitù, di non impedirne l’esercizio, l’art. 330 c.c. in tema di abuso di responsabilità genitoriale, l’art. 2793 c.c. in punto di abuso della cosa da parte del creditore pignoratizio.
Del pari, alcune disposizioni di legge speciale hanno codificato fattispecie di abuso in ambiti del tutto settoriali: si pensi, all’art. 9 della L. 18 giugno 1998, n. 192 che, in tema di subfornitura, vieta – sanzionando con la nullità l’atto che ne sia derivato – l’abuso di dipendenza economica, ovvero al neo-introdotto art. 10bis dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), che in materia tributaria, stabilisce che configurano abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme di settore, mirano essenzialmente a realizzare vantaggi fiscali indebiti.
Nel codice vigente – come, del resto, in quello del 1865 – manca, tuttavia, una norma espressa che affermi il divieto di abuso del diritto in termini di principio generale dell’ordinamento, operante quale limite generale all’esercizio di qualsivoglia diritto, anche al di fuori delle norme che lo contemplino in riferimento a fattispecie specifiche.
Invero, l’introduzione di una norma atta a sancire espressamente il divieto di abuso in termini generali era stata discussa e, in un primo momento, favorevolmente considerata nel corso dei Lavori preparatori al codice del 1942. L’art. 7 della parte generale del Progetto ministeriale di c.c., infatti, disponeva che: “Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo gli è riconosciuto”, mentre l’art. 74 del Progetto del Libro V del c.c., che peraltro poneva l’accento non tanto sull’abuso bensì, più propriamente, sull’eccesso nell’esercizio del diritto, prevedeva che: “è egualmente tenuto al risarcimento colui che ha cagionato danno ad altri eccedendo nell’esercizio del proprio diritto”. Tali norme non sono, tuttavia, state infine trasfuse nella stesura definitiva del codice.
Il silenzio del legislatore del 1942 si spiega in primis alla luce della cultura giuridica degli anni ’30-’40 del secolo scorso, caratterizzata da una matrice di stampo illuministico-liberista, diretta espressione della rivoluzione francese e della classe borghese con essa affermatasi. Essa conduceva a ritenere che, in disparte limiti espressi e specifici fissati da norme puntuali, l’esercizio del diritto avrebbe dovuto ritenersi del tutto insindacabile sul piano giuridico, onde assicurare piena tutela al principio di libertà. L’impiego sostanzialmente scorretto o abusivo del diritto avrebbe così potuto essere valutato solo sul piano etico-morale, come fonte di biasimo, ma non già anche di sanzione giuridica da parte dell’ordinamento, per il quale avrebbe dovuto ritenersi sufficiente il rispetto della mera legalità formale.
Per altro verso, alla base della mancata positivizzazione del principio in esame vi era una forte preoccupazione per la certezza – o quantomeno prevedibilità – del diritto, in considerazione della grande latitudine di potere che una clausola generale come quella dell’abuso del diritto, sganciata da referenti normativi precisi, avrebbe attribuito al giudice.
Si temeva, in altri termini, che per effetto dell’introduzione di siffatto principio, si sarebbe finito per attribuire al giudice un potere di valutazione dai confini troppo ampi ed incerti, capace di tramutarsi in un sindacato generalizzato di scelte libere compiute dal soggetto nell’esercizio della propria autonomia privata.
Per queste stesse ragioni, la dottrina e la giurisprudenza del tutto maggioritarie fino agli anni ’60 del secolo scorso hanno recisamente negato l’esistenza di un principio generale di divieto di abuso del diritto, ritenendo che lo stesso assumesse rilevanza giuridica solo in relazione alle singole fattispecie per le quali fosse sanzionato da una norma esplicita e specifica.
7.2 C’è abuso in caso di modalità scorretta di esercizio del diritto, produttiva di un sacrificio sproporzionato e ingiustificato
È a partire dagli anni ’70 del secolo scorso che, progressivamente, dottrina e giurisprudenza, facendosi interpreti dello spirito della neonata Carta Costituzionale, hanno affermato l’immanenza nel nostro ordinamento giuridico del principio generale del divieto di abuso del diritto. A ciò sono pervenute facendo leva sul canone costituzionale di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. nonché sui principi di buona fede e correttezza che di tale canone sono estrinsecazione nei rapporti fra privati.
Siffatti principi traggono dal proprio radicamento costituzionale, una valenza direttamente precettiva sul piano giuridico, imponendo a chiunque sia titolare di una situazione giuridica di vantaggio di esercitarla non già in una prospettiva egoistica ed individualista, bensì in un’ottica solidaristica che prenda in considerazione e salvaguardi, nei limiti di un sacrificio non apprezzabile, la sfera giuridica dei soggetti con cui entra in relazione.
In ultima istanza, si è detto che poiché nessun uomo è solo, nessun diritto è, per l’effetto, senza limiti, ma trova sempre e comunque, in aggiunta a quelli specifici eventualmente previsti da norme puntuali, un limite generale ed esterno di carattere modale e funzionale che ne preclude l’esercizio incontrollato per finalità o con modalità tali da cagionare un pregiudizio ingiustificato e sproporzionato degli interessi altrui.
Il profondo radicamento del divieto di abuso del diritto nel principio generale di buona fede e nel canone costituzionale di solidarietà sociale emerge, del resto, anche sul piano comparatistico, ove si consideri che nell’ordinamento tedesco, benché, come anticipato, siffatto divieto sia contemplato in una norma ad hoc (§226 BGB), la giurisprudenza tende a individuarne il referente normativo principale nel §242, ossia nella disposizione in cui è codificata la buona fede (Treu und Glauben).
La compiuta affermazione in sede pretoria del divieto di abuso del diritto quale principio generale dell’ordinamento giuridico è tradizionalmente ricondotta a due importanti pronunce della Cassazione nelle quali la Suprema Corte ha dettato un vero e proprio “decalogo” degli elementi costitutivi della figura in esame.
Con la prima pronuncia 20 aprile 1994, n. 3775, nota come «caso Fiuggi», la Suprema Corte censurava la condotta del contraente scaltro che, attraverso un’abile macchinazione contrattuale, aveva impedito un aumento del canone dovuto alla parte pubblica per la concessione, conseguendo, al contempo, un lucro sproporzionato sulle vendite, ai consumatori finali, dell’acqua minerale imbottigliata.
Con la seconda ancor più rilevante sentenza 18 settembre 2009, n. 20106, nota come «caso Renault», la Corte di Cassazione stigmatizzava l’abuso del potere di recesso ad nutum dal contratto di concessione di vendita, da parte della casa madre Renault S.p.A. nei confronti di una pluralità di concessionari italiani, per essere stato, lo stesso, esercitato immediatamente dopo aver richiesto loro ingenti finanziamenti e, così, in modo arbitrariamente lesivo del legittimo affidamento in essi ingenerato in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale. Si è affermato, in particolare, che il diritto di recesso ad nutum eventualmente previsto a favore di una o entrambe le parti, se consente, senz’altro, a chi ne sia titolare di sciogliersi dal vincolo negoziale senza dover addurre una giusta causa, non conferisce, tuttavia, un potere incondizionato nei modi e nei fini, essendo consentito al giudice di verificare che lo stesso non sia stato esercitato in concreto per fini diversi ed ulteriori da quelli consentiti ovvero con modalità tali da arrecare alla controparte in posizione di soggezione un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato. In ultima istanza – precisa la Corte – si può recedere senza causa (ad nutum), ma non senza modi e, cioè, in modo arbitrario (ad libitum).
Nella risoluzione di tali casi paradigmatici, la Suprema Corte, portando a definitiva maturazione il processo di affermazione pretoria del principio in esame, ha enucleato – con un “vademecum” rimasto inalterato nella giurisprudenza e nella letteratura successive – gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto nel modo che segue: 1) la titolarità di un diritto in capo a un soggetto (diritto come sinonimo di situazione di vantaggio giuridicamente protetta); 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto, in sede sostanziale o anche processuale (abuso del processo) secondo modalità censurabili rispetto a un criterio di valutazione, giuridico o extra-giuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.
Ne consegue che l’abuso del diritto, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea, piuttosto, l’utilizzazione alterata e scorretta dello schema formale del diritto, preordinata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli per i quali il diritto è stato conferito ovvero con modalità tali da arrecare alla controparte un pregiudizio obiettivamente sproporzionato.
In questo senso, può concludersi che il divieto di abuso del diritto si atteggia a principio di chiusura del sistema che, in una prospettiva di giustizia sostanziale che assicuri l’equilibrio e la proporzione dei rapporti giuridici, garantisce l’“autocorrezione” dell’ordinamento evitando di ritenere lecito ogni comportamento non vietato e collocando al di fuori dei comportamenti autorizzati e tutelati dall’ordinamento quelle condotte che sia pur ossequiose della legalità formale, ne tradiscano, di fatto, l’anima.
Tanto premesso, emerge la sostanziale differenza fra abuso del diritto e atti emulativi ex art. 833 c.c. (vedi Parte VI, Cap. 2, §5), che ha impedito di rinvenire in quest’ultimo articolo la positivizzazione in termini generali del divieto di abuso del diritto e ne ha imposto la ricostruzione, sub specie di principio inespresso, a partire dal canone costituzionale di solidarietà sociale e dal principio di buona fede e correttezza. Sul piano soggettivo, mentre l’emulazione richiede la sussistenza dell’animus nocendi, fra gli elementi dell’abuso del diritto non compare il dolo, ossia la specifica intenzione di nuocere, esaurendosi la fattispecie sul piano esclusivamente oggettivo. Sullo stesso piano oggettivo, poi, mentre l’emulatio si caratterizza per la totale assenza di utilità dell’atto per il soggetto agente, l’abuso del diritto non è affatto incompatibile con la sussistenza di un interesse del soggetto agente, fondandosi, piuttosto, il giudizio di abusività su una valutazione comparativa fra l’interesse perseguito dal soggetto agente ed il sacrificio inferto a quello della controparte. In questo senso, il divieto di atti emulativi ex art. 833 c.c. può dirsi rappresentare un’applicazione peculiare della figura del divieto di abuso del diritto, con la quale, per la specialità degli elementi che la connotano sul piano sia soggettivo che oggettivo, si pone in un rapporto di species a genus.
7.3 La sanzione atipica è il rifiuto di tutela
Chiarita la nozione di abuso del diritto, la reazione dell’ordinamento alle diverse forme di estrinsecazione dello stesso è diversificata: a fronte di un principio generale dalle manifestazioni del tutto atipiche e non predeterminabili ex ante, atipica e mutevole non può che essere anche la sanzione per la sua violazione. Fermo restando, dunque, che la singola sanzione dovrà essere individuata volta per volta e in concreto, la regola generale che deve guidare il giudice nella determinazione della sanzione adeguata al caso di specie, è quella del diniego di tutela, quella, cioè, della negazione di qualsiasi tipo di protezione giuridica a quei poteri, diritti e interessi che siano stati esercitati in modo abusivo, al fine di evitare il conseguimento o, comunque, la conservazione dei vantaggi per tal via ottenuti.
A seconda dei casi, la reazione potrà essere il risarcimento del danno, l’inesigibilità del diritto, l’exceptio doli generalis, l’inammissibilità dell’azione, la statuizione sulle spese processuali, l’invalidità del negozio. In quest’ultimo caso, peraltro, l’orientamento tradizionale ritiene necessario che la sanzione dell’invalidità sia espressamente contemplata dalla legge. Viene qui in rilievo, infatti, la tradizionale distinzione fra norme di fattispecie e clausole generali, da un lato, regole sull’atto (o di validità) e regole di comportamento, dall’altro. Poiché la buona fede su cui si fonda il principio dell’abuso del diritto è una clausola generale ampia e indeterminata, deve ritenersi escluso che, in assenza di una previsione normativa espressa e specifica che eccezionalmente lo consenta (quali sono, ad esempio, l’art. 36 del Codice del Consumo in tema di nullità di clausole vessatorie, ovvero l’art. 9 della Legge sulla subfornitura, in tema di abuso di dipendenza economica) la sanzione per la sua violazione possa essere rappresentata dalla nullità dell’atto abusivo. Detta sanzione, infatti, per la gravità che la contraddistingue, può derivare soltanto dalla violazione di norme di fattispecie puntuali e specifiche.
Occorre peraltro rammentare che siffatta tradizionale distinzione fra regole di validità e regole di comportamento è stata radicalmente messa in discussione da alcune pronunce della Consulta e della Corte di Cassazione che, suscitando durissime critiche da parte della dottrina pressoché unanime, hanno attribuito alla clausola generale di buona fede il rango di vera e propria regola di validità. Si rinvia, in proposito, al successivo §8 del presente Capitolo.
7.3.1 L’exceptio doli generalis
In aggiunta all’obbligo risarcitorio (contrattuale o aquiliano), all’intervento correttivo del giudice sullo squilibrio negoziale e all’inefficacia o invalidità (nei casi di legge) dell’atto giuridico concretizzazione dell’abuso, assume particolare rilievo tra le varie forme di reazioni all’abuso, per la sua rilevanza generale e, per la sua estrema versatilità, il rimedio dell’exceptio doli generalis seu praesentis (da non confondere con l’exceptio doli specialis seu praeteriti ex art. 1439 c.c.).
Per exceptio doli generalis, si intende la possibilità di opporsi all’altrui pretesa o eccezione quando queste, pur formalmente impeccabili ed ossequiose della più stretta legalità, risultino, a un più approfondito esame, espressione di un esercizio scorretto o doloso di un diritto.
Più in particolare, secondo l’opinione maggioritaria, l’exceptio riassume due principali finalità: da un lato, il divieto di esercitare diritti e, più in generale, pretese giuridicamente tutelate per finalità e interessi non meritevoli secondo l’ordinamento o comunque diversi e non conformi a quelli che le norme invocate intendono tutelare; dall’altro, il divieto di venire contra factum proprium, che ricorre allorché nell’esercitare un diritto si tengano più comportamenti, tutti legittimi, ma fra loro intrinsecamente contraddittori, ledendo l’affidamento ingenerato nella controparte.
Sul piano pratico, l’eccezione di dolo comporta la disapplicazione delle norme illecitamente invocate e la conseguente reiezione della domanda. In questo senso, il rimedio in esame ha una finalità essenzialmente difensiva, risolvendosi in un diniego di effetti (Torrente).
L’istituto rinviene le sue antiche origini nel diritto romano, in particolare all’epoca del repubblicano Aquilio Gallo, al fine di ovviare a una rigida applicazione dello ius civile contrastante con l’equitas.
Il giurista Gaio ne fa menzione (Gai, 4.119, frammento del test. ad ed. urbicum) nell’ambito delle difese esperibili, in sede processuale, dal convenuto. Nel contesto del processo formulare romano, il convenuto che avesse ottenuto dal pretore, nella fase in iure, l’inserimento dell’eccezione in parola nel testo della formula, avrebbe vincolato lo iudex privatus, nella successiva fase apud iudicem, a verificare, sulla base delle allegazioni delle parti, che l’esercizio della pretesa attorea, pur formalmente conforme alle prescrizioni dello ius civile, non risultasse, in concreto, per effetto delle modalità del suo esercizio ovvero delle sopravvenienze medio tempore verificatesi, abusiva e scorretta, contraria a canoni di correttezza e giustizia sostanziale.
Orbene, la funzione di relativizzazione dello strictum ius svolta dalla exceptio doli generalis nel diritto romano ne ha suggerito la riscoperta da parte della giurisprudenza unitamente all’affermazione pretoria dell’abuso del diritto, quale strumento generale per rendere concretamente operativo, soprattutto là dove manchi una sanzione tipica, il diniego di tutela con cui l’ordinamento risponde alle violazioni del predetto divieto.
Anche in questo caso, in assenza di una norma specifica che espressamente contempli siffatto strumento processuale, la sua affermazione è stata pertanto frutto dell’opera interpretativa della giurisprudenza che ne ha ricostruito la vigenza quale rimedio di carattere generale facendo leva su una pluralità di istituti dell’attuale sistema delle obbligazioni e dei contratti che ne condividono la ratio e che ne rappresentano, secondo i più, specifiche applicazioni codificate. Al riguardo, si rammentano: l’istituto della compensazione (artt. 1241 ss., c.c.); l’effetto solutorio del pagamento effettuato all’incapace nei limiti dell’arricchimento (art. 1190 c.c.); l’effetto liberatorio derivante dalla mora del creditore (art. 1207, comma 1, c.c.); la limitazione del risarcimento dei danni evitabili dal creditore con l’ordinaria diligenza (art. 1227, capoverso, c.c.); la non opponibilità al cessionario in buona fede del patto che esclude la cedibilità del credito (art. 1260, capoverso, c.c.); la rilevanza della conoscenza da parte del debitore ceduto della cessione del credito anche prima della notificazione della cessione (art. 1264, capoverso, c.c.); la finzione di avveramento della condizione (art. 1359 c.c.); la non annullabilità del contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età (art. 1426 c.c.); la minaccia di far valere un diritto come causa di annullamento del contratto (art. 1438 c.c.); l’inefficacia della convalida se chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto (art. 1444 c.c.); l’impossibilità di rifiutare la prestazione all’inadempiente se il rifiuto è contrario alla buona fede (art. 1460, capoverso, c.c.); la rilevanza del patto che esclude la responsabilità in caso di mala fede del venditore (art. 1490, capoverso, c.c.); l’irrilevanza della riconoscibilità del vizio nel caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.) ecc.
Come emergerà dall’indagine casistica svolta nel prossimo paragrafo, negli ultimi anni, le corti sia di merito che di legittimità, contestualmente alla riscoperta delle clausole generali di buona fede e correttezza nonché del significato immediatamente precettivo (e non solo programmatico) delle disposizioni costituzionali, in primis, quella dell’art. 2 Cost., hanno impiegato l’exceptio doli generalis al di fuori dei casi espressamente regolati dal legislatore, ritenendole espressione di un rimedio di portata generale e atipica.
7.4 Indagine casistica
L’excursus, sin qui compiuto, consente di comprendere meglio i più recenti approdi giurisprudenziali.
Sebbene, negli ultimi anni, si sia registrata una generale tendenza della giurisprudenza a valorizzare la funzione precettiva della buona fede, tuttavia non può sottacersi come, in passato, la valenza valutativa di tale clausola abbia contribuito all’elaborazione di significativi principi di diritto. È in tale ottica, infatti, che la Suprema Corte ha risolto, positivamente, l’annosa questione afferente alla possibilità, per il debitore, di estinguere un’obbligazione pecuniaria tramite la consegna di un assegno circolare, trattandosi pur sempre di un mezzo di pagamento alternativo al denaro, la cui rifiutabilità da parte del creditore sarebbe ammissibile solo al ricorrere di un giustificato motivo, da valutarsi alla stregua degli ordinari criteri di correttezza e buona fede (cfr. Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2010, n. 13658, vedi Cap. 3, §10).
Relativamente alla qualificazione della buona fede quale fonte eteronoma del contratto, produttiva di obblighi autonomi e distinti da quelli prestazionali, previsti dai contraenti, giova rammentare l’obbligo di protezione gravante sulla società di leasing nei confronti dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del fornitore. L’utilizzatore, pur non potendo domandare la risoluzione del contratto di fornitura intercorso tra fornitore e società di leasing – non rivestendo, rispetto ad esso, la relativa qualifica di parte – ha, tuttavia, nei confronti di quest’ultima, uno specifico obbligo informativo nei casi di vizi del bene ad oggetto dell’operazione negoziale. L’informazione fa, dunque, scattare l’obbligo di protezione della società di leasing in favore dell’utilizzatore, essendo, questa, tenuta ad agire ex contractu nei confronti del fornitore (cfr. Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785).
La casistica più significativa ha, tuttavia, interessato la figura dell’abuso del diritto, dove il giudizio di conformità alla buona fede serve a temperare la rigidità del diritto scritto, ovviando a situazioni di esercizio arbitrario dei diritti, lesive dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 41 Cost.
Cominciando, senza pretese di esaustività, con l’analisi della più interessante casistica giurisprudenziale concernente l’esercizio abusivo del diritto di credito, viene in rilievo, innanzitutto, la fattispecie del contratto autonomo di garanzia che si caratterizza per la sostanziale rimozione del vincolo di accessorietà fra la posizione del garante e quella del debitore garantito. Il primo si impegna, infatti, a pagare il creditore senza potergli opporre alcuna eccezione relativa al rapporto principale. In tali casi, esercita abusivamente il proprio diritto, al chiaro scopo di ottenere una locupletazione indebita, il creditore che, pur sapendo che l’obbligazione è già stata estinta o che si tratta di un’obbligazione illecita, escuta ugualmente la garanzia, avvalendosi della clausola di autonomia che impedisce al garante di opporre le eccezioni concernenti il rapporto principale. In proposito, la giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. 1° ottobre 1999, n. 10864; Cass. 28 luglio 2004, n. 14239; Cass. 7 marzo 2007, n. 5273), è giunta ad ammettere, ormai unanimemente, che il garante, di regola costituito da una banca o altro soggetto di sicura solvibilità, possa sollevare l’exceptio doli generalis per opporsi all’escussione della garanzia quando l’abusività della stessa risulti da prove pronte (dunque, in definitiva, documentali) e liquide (cioè certe e incontrovertibili).
Ancora, importanti applicazioni giurisprudenziali hanno interessato la fattispecie di cd. abusiva concessione di credito, consistente nell’erogazione di finanziamenti da parte di una banca ad una impresa della quale la banca stessa conosca l’insolvenza, così ingenerando nei terzi l’erroneo convincimento circa la solidità dell’impresa finanziata. La giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 7030, Cass. 14 maggio 2918, n. 11695) ha affermato, infatti, che l’erogazione di un finanziamento obbliga il finanziatore non solo a valutare i rischi che da tale finanziamento possano derivare a suo carico, ma anche a tenere in considerazione le conseguenze negative che dall’erogazione potrebbero conseguire nei confronti dei terzi operatori economici e, in generale, del corretto funzionamento del mercato, indotti in errore dalla sopravvivenza artificiosa di un’impresa ormai decotta. La giurisprudenza prevalente sanziona la concessione abusiva del credito attraverso lo strumento della responsabilità: a) aquiliana, nei confronti dei creditori dell’impresa finanziata e dei terzi, nonché dei concorrenti; b) contrattuale, nei confronti della stessa impresa finanziata per il danno provocato al patrimonio della società. Si tratta di un danno immediato e diretto derivante dalla condotta illecita della banca che, anziché ispirarsi ai principi di sana e corretta gestione del credito, risulta preordinata a mantenere artificiosamente in vita un imprenditore decotto.
Infine, in materia di diritti di credito, vengono in rilievo le pronunce di legittimità che, prima dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675), ma anche successivamente (Cass. 28 settembre 2023, n. 27545, su cui funditus si rinvia al Cap. 3 di questa Parte, §10.6.5.3), hanno fatto impiego della figura del divieto di abuso a fronte di fattispecie di cd. usura sopravvenuta, riscontrabili allorquando il tasso degli interessi, originariamente pattuito in misura legale, diventi usurario nel corso dell’esecuzione del contratto, per effetto della rideterminazione trimestrale del tasso soglia da parte del Ministero del Tesoro. Contrariamente a quanto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite nel 2017, le pronunce qui richiamate avevano condivisibilmente concluso nel senso che la norma che sanziona l’usura non è una norma formale che vieta la pattuizione usuraria, ma una noma materiale, di ordine pubblico economico, che reprime il risultato usurario, comunque prodottosi (per effetto dell’originaria pattuizione fra le parti ovvero anche per effetto di sopravvenienze normative come la rideterminazione del tasso soglia). In questa prospettiva, pertanto, rientra nel contenuto del divieto non solo il negozio che preveda ab origine interessi usurari (certamente nulla per la parte de qua), ma anche il comportamento di chi pretenda in executivis interessi divenuti usurari. Una siffatta pretesa, ove di fatto avanzata, integrerebbe esercizio abusivo del diritto di credito contrario a buona fede, e sarebbe paralizzabile, per la parte di interessi divenuti superiori alla soglia, con lo strumento dell’exceptio doli generalis (vedi Cap. 3, §10.6.5).
Ancora, in un contratto di locazione a uso abitativo è stata giudicata (Cass. 14 giugno 2021, n. 16743) abusiva la improvvisa richiesta del locatore di integrale pagamento del canone dopo un lungo periodo di morosità. Difatti, in tal caso, l’assoluta inerzia del locatore nell’escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole, può ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia.
Tali conclusioni, tuttavia, non convincono fino in fondo. La tesi dell’abusività dell’esercizio tardivo del credito, con conseguente perenzione dell’azione (teoria tedesca del “Verwirkung”, che predica soluzioni ricostruttive come la rinuncia all’azione, la decadenza dal diritto e la perenzione dell’azione), conduce, infatti, al varo di un’asistematica causa parziale di estinzione dell’obbligazione, a fronte della violazione di una regola di condotta fronteggiabile con la più ortodossa sanzione del risarcimento contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c. Si oppongono, infatti, all’assunto: a) argomenti di ordine dogmatico, stante l’eccezionalità delle norme di fattispecie; b) sistematico, in quanto, come noto, il sistema delle cause di cause estinzione non può essere forzato o etero-integrato; c) rimediale, non essendo coerente con il principio di proporzionalità dei rimedi, avendo sostanzialmente trasformato il contratto di locazione in un comodato precario a titolo gratuito, pur non essendo spirato il termine ultimo per l’esercizio del credito riconosciuto dal primo negozio.
La giurisprudenza successiva sembra aver considerato questi rilievi. In una decisione del 26 aprile 2024, n. 11219, infatti, la Suprema Corte, in contrasto con il proprio precedente, ha chiarito che il comportamento di un creditore a lungo inerte nell’escutere il proprio credito – anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato – non integra un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto (nel caso di specie si trattava di un locatore che per lungo tempo non aveva sollecitato il conduttore a saldare svariati canoni mensili non versati). Secondo la pronuncia del 2024, inoltre, la richiesta del creditore, dopo una lunga inerzia, dell’integrale adempimento delle somme spettanti non costituisce un caso di abuso del diritto. Ciò in quanto il semplice ritardo di una parte nell’esercizio delle proprie prerogative può dar luogo a una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte.
Per la sentenza, inoltre, il principio condiviso dal precedente del 2021 non convince anche per motivi più generali in quanto si tradurrebbe “in una incondizionata apertura all’operatività, nell’ordinamento italiano, di un istituto ad esso sconosciuto, consistente nella Verwirkung del diritto tedesco, quale consumazione del diritto collegato all’inattività (Rechtsverschweigung) del titolare, di cui il codice civile tedesco tradizionalmente fa applicazione, in particolare, in materia di perdita del “praemium inventionis” (§971), della provvigione del mediatore (§654) e del diritto al pagamento della clausola penale (§339)”. Sebbene anche nell’ordinamento italiano vi siano degli esempi simili, per esempio nel diritto del lavoro (il ritardo del datore nel contestare la giusta causa di licenziamento o quello del prestatore di lavoro nella prosecuzione del rapporto) tuttavia nel nostro ordinamento non può darsi ingresso in via generale al principio della Verwirkung.
Rilevanti applicazioni del divieto di abuso si sono riscontrate, poi, in materia di diritti potestativi che, proprio per la struttura che li contraddistingue, prestano il fianco, più che mai, a condotte scorrette ed ingiustificatamente pregiudizievoli della posizione di soggezione della controparte. Non è un caso, del resto, che proprio il leading case in materia di abuso del diritto, in relazione al quale la Suprema Corte ha dettato il “decalogo” degli elementi costitutivi di tale figura (cfr. la sopra citata sentenza “Renault”, 18 settembre 2009 n. 20106), abbia riguardato l’esercizio abusivo del diritto potestativo di recesso contrattuale.
Le statuizioni rese dalla Suprema Corte nel caso Renault con riferimento al diritto potestativo di recesso contrattuale sono state in seguito ribadite anche nell’ambito dei rapporti bancari, in specie di apertura di credito, laddove il recesso, benché pattiziamente consentito anche in assenza di giusta causa (ad nutum), venga esercitato dalla banca con modalità del tutto impreviste ed arbitrarie (cfr. Cass. 21 maggio 1997, n. 4538; Cass. 14 luglio 2000, n. 9321; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2642). E, con riferimento ai rapporti di conto corrente, è stato ritenuto che, in presenza di una clausola negoziale che, nel regolare tali rapporti, consenta all’istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli, impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto. Con la conseguenza, in caso contrario, del riconoscimento a carico della banca di una responsabilità per risarcimento dei danni (cfr. Cass. 28 settembre 2005, n. 18947).
Vasta casistica di abuso del diritto potestativo si rinviene, poi, in materia di diritto del lavoro, con riferimento all’esercizio dei poteri direttivi e disciplinari spettanti al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti. Emblematica, in proposito, la fattispecie del mobbing cd. verticale (distinto dal mobbing cd. orizzontale esercitato dai colleghi di lavoro) che altro non è se non una forma di reiterato esercizio abusivo dei poteri spettanti al datore (demansionamento, trasferimento etc.), al fine di mortificare ed emarginare un determinato soggetto sul luogo di lavoro e costringerlo, per l’effetto, a presentare le dimissioni.
In materia di diritti reali, quanto mai copiosa è la giurisprudenza in ordine alle figure tipiche di cui agli artt. 1015 c.c. (abuso del diritto di usufrutto, sanzionato con l’estinzione del diritto medesimo), 2793 c.c. (abuso della cosa da parte del creditore pignoratizio) e, soprattutto, art. 833 c.c. in tema di atti emulativi che, come detto, costituiscono un’ipotesi tipica e specifica di abuso funzionale del diritto di proprietà, caratterizzata, sul piano soggettivo, dalla necessaria sussistenza di un animus nocendi, nonché, sul piano oggettivo, dalla totale assenza di un qualche interesse/utilità dell’atto per il soggetto agente. Con riferimento alla fattispecie degli atti emulativi, costituisce tema tradizionalmente discusso in dottrina e giurisprudenza quello della configurabilità di una aemulatio per omissionem, se, cioè, gli atti di emulazione possano consistere anche in comportamenti omissivi. Sul punto, a fronte di un minoritario e risalente orientamento giurisprudenziale favorevole, la prevalente dottrina e giurisprudenza risponde negativamente ritenendo che gli atti emulativi possano consistere solo in comportamenti attivi/commissivi e non anche meramente passivi/omissivi. A sostegno di siffatta conclusione, si adduce, in primo luogo, il dato letterale, atteso che il termine “atti” di cui all’art. 833 c.c. sembra riferirsi inequivocabilmente ad una condotta attiva. In secondo luogo, e soprattutto, si rileva l’ontologica incompatibilità del contegno omissivo con la nozione di emulazione, che, come detto, postula l’assenza di qualsiasi interesse per il suo autore, laddove, al contrario, l’omissione implica sempre, per definizione, un vantaggio in termini di risparmio di spesa, tempo e/o energia psico-fisica.
Forme di abuso del diritto possono riscontrarsi, poi, con riferimento a quel peculiare diritto che è la libertà negoziale, allorché ad essere esercitato in modo scorretto e fraudolento sia il potere di autonomia negoziale. Vengono in rilievo, in proposito, le tradizionali fattispecie della doppia alienazione immobiliare allorché il secondo acquirente, pur essendo a conoscenza del primo trasferimento, proceda in mala fede alla trascrizione del proprio titolo avvalendosi della regola pubblicitaria di cui all’art. 2644 c.c., ovvero quella del contratto in danno o in frode di terzo.
In siffatti casi, peraltro, la varietà delle misure comminabili al fine di negare tutela all’esercizio abusivo dell’autonomia negoziale incontra un limite generale nei capisaldi minimi indispensabili per la sicurezza e la certezza dei rapporti giuridici. Tali capisaldi sono rappresentati, per un verso, dal regime pubblicitario della trascrizione, per altro verso, dalla già citata distinzione tradizionale fra regole di condotta e regole di validità.
Sotto il primo profilo, si osserva che il rigore formale è l’ubi consistam del regime pubblicitario, che, a tutela della fede pubblica, ordina lo svolgimento dei traffici giuridici sulla base del criterio formalistico della priorità nella trascrizione. Introdurre, in un sistema ontologicamente formalistico, un correttivo ispirato a ragioni di giustizia sostanziale quale quello della buona fede e dell’abuso del diritto, significherebbe, di fatto, contraddirne, la ratio. Così, nel caso di doppia alienazione immobiliare, la condotta fraudolenta del secondo acquirente non potrà essere neutralizzata dal primo acquirente con l’opposizione dell’exceptio doli generalis volta a paralizzare, previa disapplicazione dell’art. 2644 c.c., l’effetto acquisitivo prodottosi nei suoi confronti. Esclusa la possibilità di una tutela reale che consenta al primo acquirente di prevalere sul secondo di mala fede, residua, in tal caso, lo strumento del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Quanto, invece, alla tradizionale distinzione fra regole di comportamento e regole di validità, come già anticipato in chiusura del precedente paragrafo, poiché la buona fede su cui si fonda il principio dell’abuso del diritto è una clausola generale ampia ed indeterminata, deve ritenersi escluso che, in assenza di una previsione normativa espressa e specifica che eccezionalmente lo consenta, la sanzione per la sua violazione possa essere rappresentata dalla nullità dell’atto abusivo. Detta sanzione, infatti, per la gravità che la contraddistingue, può derivare soltanto dalla violazione di norme di fattispecie puntuali e specifiche. E, così, sempre in caso di doppia alienazione immobiliare, non solo non sarà possibile opporre l’exceptio doli al fine di ottenere la disapplicazione dell’art. 2644 c.c., ma la condotta abusiva del primo trascrivente non potrà essere sanzionata in forma reale nemmeno predicando l’invalidità dell’atto d’acquisto da lui compiuto. Analogamente, in tutti i casi di contratto a danno o in frode di terzo, il contratto fraudolentemente stipulato è comunque valido e l’unico rimedio azionabile dal danneggiato è costituito dalla tutela risarcitoria (per una recente rivisitazione dell’orientamento tradizionale che esclude l’idoneità della buona fede ad assurgere a regola di validità si rinvia, in modo più approfondito, al successivo §8).
Tra le fattispecie di esercizio abusivo dell’autonomia negoziale può annoverarsi anche quella del cd. abuso del contratto tipico che ha trovato applicazione giurisprudenziale essenzialmente in materia tributaria, allorché si dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che le parti hanno fatto ricorso a quel determinato negozio essenzialmente (anche se non esclusivamente) allo scopo di aggirare le regole tributarie e conseguire vantaggi fiscali (cfr. Cass. 19 maggio 2010, n. 12249; Cass. 31 maggio 2010, n. 13208). La fattispecie, già da tempo riconosciuta a livello giurisprudenziale, è oggi normativamente prevista dall’art. 10bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto, in risposta alle spinte comunitarie (cfr. sent. Corte di Giustizia, Halifax e University of Huddersfield, cause C-255/02, C-419/02 e C-223/039), dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128. In tal caso, l’abuso è sanzionato, secondo il canone generale del rifiuto di tutela, riconoscendo all’Amministrazione finanziaria il potere di riqualificare il contratto, al fine di dare ingresso ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello che consegue agli effetti dello schema contrattuale adottato dalle parti.
Una vastissima casistica applicativa del divieto di abuso ricorre, poi, in materia societaria. Viene in rilievo, innanzitutto, l’abuso del diritto di voto da parte sia della maggioranza che della minoranza assembleare. L’abuso del potere di maggioranza, che rappresenta l’ipotesi più frequente, si configura quando la delibera assembleare non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, ma sia, al contrario, ispirata al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale contrastante con quello sociale, ovvero sia intenzionalmente e fraudolentemente orientata al solo fine di ledere i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza (si pensi, ad esempio, a una delibera di aumento del capitale posta in essere al solo scopo di escludere altri soci dalla maggioranza economicamente impossibilitati a esercitare il diritto di opzione alla sottoscrizione). La giurisprudenza (Cass. 11 giugno 2003, n. 9353; Cass. 25 gennaio 2000, n. 8004; Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151; Cass. 9 marzo 1991, n. 2503) reputa che tale abuso sia causa di annullamento della deliberazione assembleare ex art. 2377 c.c.
Benché sia molto meno frequente (come dimostrato dalla scarsissima giurisprudenza in proposito), l’abuso dei poteri e delle facoltà inerenti all’adozione delle delibere assembleari può essere posto in essere anche dalla minoranza dei soci con funzione ostruzionistica nei confronti delle scelte societarie programmate dalla maggioranza (cd. abuso del potere di minoranza). Le condotte abusive ascrivibili alla minoranza si concretano, per lo più, nella sistematica e strumentale impugnazione delle delibere assembleari, in particolar modo quelle di approvazione del bilancio (cfr. Cass. 11 dicembre 2000, n. 15592), nell’uso anomalo dei poteri statutari, del diritto di convocazione di assemblea ex art. 2367, comma 1, c.c. senza un valido motivo ed al solo scopo di ostacolare l’attività degli amministratori, ovvero, ancora, all’uso distorto, con finalità di sistematico disturbo, del diritto di intervento e parola in assemblea.
Sempre in ambito societario, costituisce peculiare manifestazione di abuso del diritto la figura del cd. abuso di personalità giuridica (cfr. Cass. 25 gennaio 2000, n. 804; Cass. 16 maggio 2007, n. 11258), espressione “ellittica” con la quale ci si riferisce all’abuso dei diritti e dei vantaggi connessi al concetto di personalità giuridica (Zorzi). Tale fattispecie ricorre laddove una o più persone fisiche utilizzino lo schermo societario per esercitare un’attività imprenditoriale a carattere sostanzialmente individuale (e, dunque, per gestire i propri personali affari), fruendo del beneficio della responsabilità limitata. Si realizza, in sostanza, un uso distorto della struttura sociale come schermo per gestire un’attività imprenditoriale senza sopportarne i rischi e assumere in prima persona la responsabilità per le obbligazioni alla stessa connesse (Chiné). In tal caso, la sanzione è rappresentata dal “disvelamento” della fictio iuris della dissociazione fra persona giuridica e persone fisiche che ne compongono la compagine umana (piercing the corporate veil), consentendo la disapplicazione delle norme attributive di benefici con la ricostituzione di una responsabilità illimitata e la personale soggezione, in caso di insolvenza, al fallimento del soggetto che ha abusato della personalità giuridica (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 1981, n. 6594).
Ancora, in materia societaria, viene in rilievo la fattispecie dell’abuso di controllo nel contesto di gruppi societari, allorché la società capogruppo eserciti i poteri direttivi sulle società controllate non già per il perseguimento di interessi comuni del gruppo, bensì per il perseguimento di interessi a lei esclusivamente riferibili, eventualmente in conflitto con quelli facenti capo alle società controllate.
Infine, rilevanti applicazioni del divieto di abuso hanno riguardato la materia processuale, integrando la figura di cd. abuso del processo. Costituisce principio ormai consolidato, infatti, quello per cui il divieto di abuso si estende non solo alle condotte sostanziali ma anche a quelle processuali, imponendo il rispetto del principio di buona fede in ogni fase di esercizio del diritto, compresa quella patologica di proposizione dell’azione in giudizio. Il divieto di abuso del diritto si converte, così, in sede contenziosa, in divieto di abuso del processo quale esercizio improprio del potere discrezionale della parte di scegliere le proprie strategie di difesa processuale sì da determinare un aggravio della posizione della controparte non giustificato dal perseguimento di un interesse legittimo e ragionevole.
In tema di abuso del processo viene in rilievo, innanzitutto, la fattispecie del frazionamento giudiziale del credito unitario. Superando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass., Sez. Un., 10 aprile 2000, n. 108), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia 15 novembre 2007, n. 23726, hanno affermato che il frazionamento giudiziale di un credito unitario, laddove non giustificato da un interesse oggettivamente apprezzabile del creditore, integra abuso del processo nella misura in cui tale condotta, pur senza essere vietata da alcuna specifica norma processuale, infligge un ingiustificato sacrificio al debitore; e ciò sia sotto il profilo temporale del prolungamento del vincolo obbligatorio cui deve soggiacere prima di liberarsene per intero, sia sotto il profilo economico delle spese cui far fronte per resistere in giudizio. Siffatto abusivo frazionamento si traduce, così, in un motivo ostativo all’esame nel merito della domanda che dovrà essere rigettata in rito per inammissibilità.
Al riguardo, parte della dottrina ha criticato queste conclusioni, in quanto, diversamente dal caso dell’improponibilità della prima domanda con riserva delle successive (caso in cui si registra una sanzione solo processuale che non impedisce la successiva proposizione della domanda unitaria), tale improponibilità si traduce nella non ammissibile creazione di una causa atipica di estinzione sostanziale e fattuale di un diritto per via della definitiva cancellazione del potere d’azione.
In merito, invece, alle conseguenze dell’esercizio abusivo del frazionamento giudiziale delle domande, si confrontano due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, la sanzione sarebbe quella dell’improponibilità della domanda di credito abusivamente frazionata; tale soluzione troverebbe conferma dall’indirizzo che giustifica la rilevabilità ex officio dell’abusiva parcellizzazione del credito, pur con le garanzie processuali del contraddittorio. Altro indirizzo meno rigoroso sostiene, invece, la proponibilità della domanda creditoria de qua in modo che essa possa essere esaminata nel merito e, nel caso in cui sia accertata la natura abusiva della richiesta frazionata, individua la sanzione nella condanna del richiedente alle spese processuali. La I sezione della Suprema Corte, (ord. 8 febbraio 2024, n. 3643) rilevato il contrasto, ne ha rimesso la composizione alle Sezioni Unite.
Sul tema della legittimità del frazionamento giudiziale del credito, le Sezioni Unite sono, poi, successivamente ritornate con riguardo all’ipotesi in cui le plurime domande proposte abbiano a oggetto diversi e distinti diritti di credito, sia pure relativi a un medesimo rapporto di durata fra le parti. La Suprema Corte ha osservato come, in tal caso, l’imposizione del simultaneus processus si porrebbe in inammissibile contrasto con il diritto di effettività della tutela giurisdizionale del creditore ex art. 24 Cost. Quest’ultimo, infatti, si vedrebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi, in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale), con conseguente indebita sottrazione all’autonoma disciplina processuale applicabile ai diversi crediti e perdita della possibilità di fruire di riti più snelli per la riscossione più rapida ed efficace. Con sent. 16 febbraio 2017, n. 4090, le Sezioni Unite hanno, pertanto, concluso che qualora le plurime iniziative giudiziali del creditore abbiano ad oggetto non già frazioni di un credito unitario, bensì plurimi e distinti diritti di credito, sia pure relativi ad uno stesso rapporto, non si configuri una condotta abusiva dove la deroga all’onere di proposizione cumulativa sia giustificata da un interesse processuale oggettivamente apprezzabile.
A fronte di ciò, la più giurisprudenza ha, tuttavia, ritenuto che non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene, quindi, al divieto di abuso degli strumenti processuali l’iniziativa del creditore di uno o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti dell’altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c., fintanto che la stessa non sia stata interamente eseguita dal terzo pignorato fino all’integrale concorrenza del credito per il quale si agisce, e fermo restando il divieto di ottenere più dell’ammontare massimo del credito medesimo (Cass., sez. IV, 24 aprile 2020, n. 8151).
Sempre in tema di abuso del processo, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656) ha ritenuto abusivo, sanzionandolo con una declaratoria di inammissibilità in rito della domanda (secondo il consueto canone del diniego di tutela), il comportamento del ricorrente che, dopo essere risultato, in primo grado, vittorioso sulla questione della giurisdizione ma soccombente nel merito, contesti, in sede d’appello, proprio la sussistenza della giurisdizione da lui in origine prescelta. Tale condotta integra utilizzo abusivo degli strumenti processuali nella misura in cui, per un verso, contravviene palesemente al generale divieto di venire contra factum proprium, per l’altro, costringe la controparte a subire lo spostamento del giudizio dinnanzi a nuovo giudice senza che tale sacrificio trovi giustificazione nell’interesse dell’eccipiente. Quest’ultimo, infatti, gravando la sentenza nei profili di merito che lo hanno visto soccombente, ben potrebbe difendersi senza abbandonare la giurisdizione da lui stesso in origine prescelta. L’intento abusivo ed opportunistico sotteso alla contestazione è, pertanto, quello di sottrarsi al giudice che in primo grado ha rigettato la domanda per tentare un esito più favorevole dinnanzi ad altra giurisdizione.
Ancora, si è ravvisato un impiego abusivo degli strumenti processuali nella condotta del creditore che proceda ad iscrizione di ipoteca giudiziale per un valore ingiustificatamente superiore rispetto a quello del credito garantito (secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c.), in evidente pregiudizio degli interessi del debitore. In questo caso, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente in capo al creditore ipotecario la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c.
Infine, un’applicazione del divieto di abuso del processo si è avuta, poi, con riguardo alle fattispecie di cd. uso selettivo delle nullità di protezione.
A fronte di contrastanti orientamenti espressi in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a chiarire se la condotta del risparmiatore che, a fonte dell’integrale nullità di un contratto quadro di investimento ex art. 23 TUF, deduca in giudizio la nullità solo di alcuni ordini di acquisto, rappresenti legittimo esercizio della normativa protezionistica che lo tutela in qualità di consumatore, ovvero possa rappresentare uno sfruttamento abusivo ed opportunistico della stessa, paralizzabile dall’intermediario convenuto in giudizio con lo strumento generale ed atipico dell’exceptio doli. Con la pronuncia 4 novembre 2019, n. 28314, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’uso selettivo della nullità di protezione ex art. 23 TUE non può dirsi né a priori illegittimo né sempre e comunque consentito, ma la sua legittimità andrà valutata caso per caso ed in concreto, verificando, attraverso una comparazione tra gli investimenti oggetto dell’azione di nullità e quelli che ne sono rimasti esclusi, se permane o meno un pregiudizio per l’investitore corrispondente al petitum azionato. Se il rendimento degli investimenti non colpiti dall’azione di nullità supera il pregiudizio confluito nel petitum, la condotta selettiva dell’investitore dovrà dirsi contraria a buona fede. Al fine di evitare il prodursi di un ingiustificato sacrificio economico in capo all’intermediario, quest’ultimo sarà legittimato a servirsi dello strumento generale e atipico dell’exceptio doli generalis al solo scopo di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullità degli ordini selezionati (rimanendo precluso, invece, l’esercizio di un’azione di ripetizione).
Se, invece, per l’investitore residua un danno anche al netto dei rendimenti degli ordini non colpiti dall’azione di nullità, deve concludersi che egli abbia agito conformemente a buona fede, in coerenza con la funzione riequilibratrice sottesa alla disposizione protezionistica di cui all’art. 23 TUE.
I principi espressi dalle Sezioni Unite con la descritta pronuncia relativa alla nullità di protezione di cui all’art. 23 TUF sono stati successivamente ribaditi dalla Suprema Corte con riguardo alla nullità di protezione del contratto preliminare comminata dall’art. 2, D.Lgs. 122/2005 per il caso di mancanza della garanzia accessoria (Cass. 22 novembre 2019, n. 30555). La Corte ha, infatti, affermato che la proposizione della domanda di nullità del preliminare per mancanza della predetta garanzia accessoria, una volta che la garanzia medesima sia stata rilasciata successivamente alla stipula del contratto, e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente la cui tutela è preposta tale nullità di protezione, costituisce abuso del diritto e non può pertanto essere accolta.
In definitiva, come ben rilevato in dottrina (A.M.S. Caldoro), la tendenza giurisprudenziale è quella di caricare di sempre maggiore contenuto la clausola costituzionalizzata di buona fede, permettendo al giudice ampia discrezionalità nell’intervenire nel rapporto contrattuale, correggendolo, modificandolo, finanche precludendo l’esercizio di diritti stabiliti dal programma negoziale o riconosciuti ex lege (come quello di scegliere autonomamente le strategie processuali) allorché si ponga in violazione degli obblighi di solidarietà e ciò risulti necessario per garantire la giustizia del caso di specie.
*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto civile” di F. Caringella – Dike giuridica editrice – Ottobre 2024