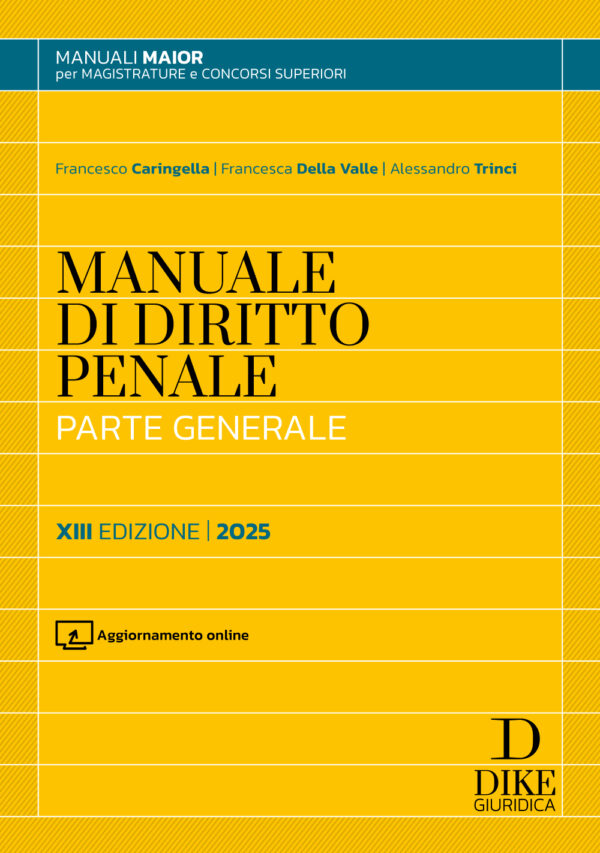Il concorso materiale tra reati si realizza nel caso di condotte distinte, separate dal punto di vista temporale, cui conseguono più reati (si pensi alla già richiamata ipotesi di un soggetto che prima rubi un’autovettura, quindi, guidandola, investa colposamente una persona cagionandole lesioni).
In tale caso, come si è già anticipato, gli artt. 71 c.p. e ss. prevedono l’applicazione del criterio del c.d. cumulo materiale temperato (tot crimina, tot poenae), per il quale si procederà alla somma aritmetica delle pene previste per ogni reato in concorso (senza alcuna deroga nei casi di applicazione di pene diverse per genere o specie), senza superare i limiti prefissati per legge (artt. 78 e 79 c.p.).
In sostanza, il legislatore ha inteso temperare la rigida applicazione del principio del cumulo materiale delle pene tramite dei correttivi.
Così, che per quel che concerne le pene principali, l’art. 78 c.p. stabilisce che “nel caso di concorso di reati preveduto dall’art. 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti”, prefissando comunque dei limiti ulteriori “trenta anni, per la reclusione; sei anni per l’arresto; 15.493 euro per la multa e 3.098 euro per l’ammenda; ovvero 64.557 euro per la multa e 12.911 euro per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’art. 133-bis. Nel caso di concorso di reati, preveduto dall’art. 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall’arresto”.
Per le pene accessorie, l’art. 79 c.p. prevede che “la durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti: 1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte; 2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte”.
Inutile dire che l’estensione della disciplina del concorso formale tra reati (si veda, infra, §5) e del reato continuato (si veda, infra, §7) anche ai casi di reati eterogenei ha, di fatto, ridotto l’ambito applicativo del concorso materiale tra reati. La sua concreta applicazione, inoltre, va delimitata anche alla luce della possibile sussistenza di un concorso apparente tra norme. Al riguardo gli indici rivelatori della sussistenza di più fatti-reati da sanzionare sono costituiti dalla diversa natura dei reati, dal differente atteggiamento psicologico del reo, dai distinti interessi giuridici protetti, ecc.[1].
Sussisterà, pertanto, concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nelle ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell’art. 589 e al comma 3, dell’art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell’incolumità individuale protetto dai secondi) impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p.
Allorché un soggetto riceva, in momenti diversi così come in unico contesto temporale, una pluralità di cose di provenienza delittuosa appartenenti ad una stessa persona, rendendosi responsabile, con riferimento ad alcune di esse, del reato di cui all’art. 648 c.p. e, con riferimento ad altre, di quello di cui all’art. 648bis c.p., si è in presenza di una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati. Non si tratta, infatti, di concorso apparente di norme in relazione alla medesima condotta, ma di distinti reati commessi con riferimento a beni diversi[2].
Non esiste alcun rapporto di sussidiarietà tra il reato di cui all’art. 3, comma 1, n. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 75 (induzione di taluno a recarsi nel territorio di altro Stato per esercitare la prostituzione) ed il reato di cui all’art. 12, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento all’ingresso clandestino di stranieri), essendo diversi gli interessi tutelati e le condotte sanzionate dalle due norme, atteso che la prima è esclusivamente finalizzata ad impedire l’induzione e la diffusione della prostituzione e sanziona la condotta di colui che induce taluno a recarsi nel territorio di altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della residenza abituale, per esercitarvi la prostituzione, mentre la seconda tutela i beni giuridici della sicurezza interna e della disciplina del mercato del lavoro e sanziona la condotta di colui che favorisce l’ingresso “clandestino” di stranieri nel territorio dello Stato italiano, sicché quest’ultima fattispecie criminosa non può ritenersi compresa nella prima[3].
Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 15 c.p., tra la norma di cui all’art. 15, L. 22 febbraio 2001, n. 36 e quella prevista dall’art. 674 c.p., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto nel primo caso, la condotta è sanzionata – con la sanzione amministrativa – solo se l’emissione di onde elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso, la condotta costitutiva dell’illecito penale sussiste a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone[4].
La dottrina maggioritaria tende ad escludere che il concorso materiale tra reati costituisca un autonomo istituto di diritto sostanziale, riducendone la portata ad un mero criterio di applicazione delle pene applicabili al reo nel caso in cui si sia reso responsabile di più violazioni della legge penale, al di fuori dei casi contemplati dall’art. 81 c.p. (concorso formale tra reati e reato continuato).
Sembra, tuttavia, giustificare l’inquadramento della figura nell’ambito delle forme di manifestazione del reato la disciplina accordata dal codice, alla particolare circostanza aggravante costituita dal concorso sostanziale tra reati di cui all’art. 61, n. 2, c.p. che contempla i casi di c.d. connessione teleologica (per la quale il “reato mezzo” per realizzare un determinato “reato fine” risulta aggravato anche nelle ipotesi in cui il “reato fine” non sia stato poi commesso o tentato) e consequenziale (che ricorre ove i reati connessi rientrino nell’originario disegno criminoso – così, ad esempio, nel caso in cui l’agente originariamente deliberi di uccidere il complice della rapina per assicurarsi il bottino o di nascondere o distruggere un cadavere dopo aver ucciso la vittima per non farsi scoprire –).
La figura, della quale verrà effettuata una più articolata disamina a proposito del reato continuato (si veda, infra, §7), contempla e punisce una più intensa criminosità nella condotta dell’agente, la cui pervicace determinazione soggettiva nella consumazione del reato fine è resa manifesta dal rifiuto di arretrare di fronte all’eventualità di perpetrare altro reato. Nulla esclude, peraltro, sussistendo il requisito dell’unicità della condotta di cui al primo comma dell’art. 81 c.p., che la circostanza aggravante possa manifestarsi nelle forme di un concorso formale tra reati.
Ciò avviene, ad esempio, quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporsi, mentre compie un atto dell’ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell’interessato, si determina un concorso tra il delitto di resistenza e quello di lesioni, e per quest’ultimo sussiste l’aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale[5].
[1] Cass., sez. IV, 6 giugno 2001, n. 35773.
[2] Cass., sez. VI, 2 novembre 1998, n. 1472. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che non operava, con riferimento al reato di riciclaggio riguardante preziosi sostituiti in blocco con denaro contante, il divieto di bis in idem in relazione al reato di ricettazione, già giudicato, avente ad oggetto altri preziosi, sia pure ricevuti dall’agente nel medesimo contesto temporale.
[3] Cass., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 81.
[4] Cass., sez. I, 31 gennaio 2002, n. 10475, relativa a fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di ripetizione radiotelevisiva.
[5] Cass., sez. VI, 5 dicembre 2003, n. 1272
*Contributo estratto da “Manuale di diritto penale – parte generale” di F. Caringella, F. Della Valle, A. Trinci – Dike giuridica editrice – Marzo 2025